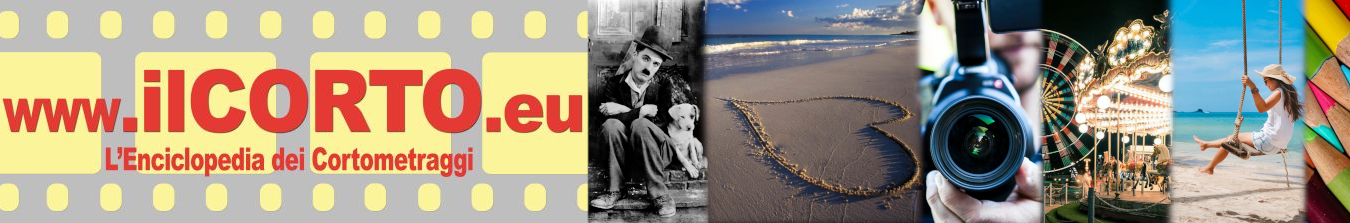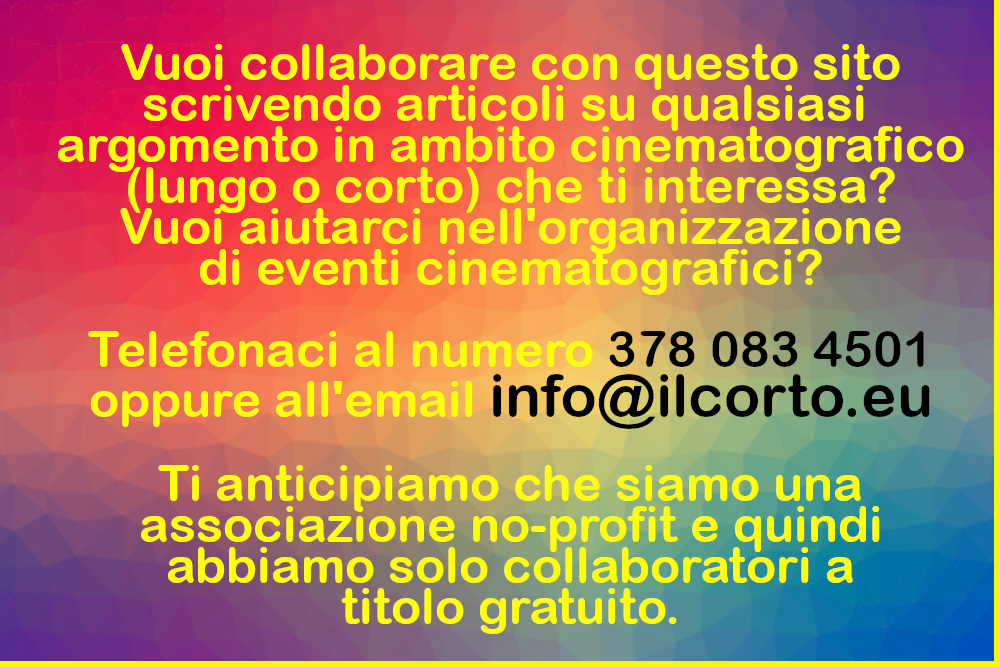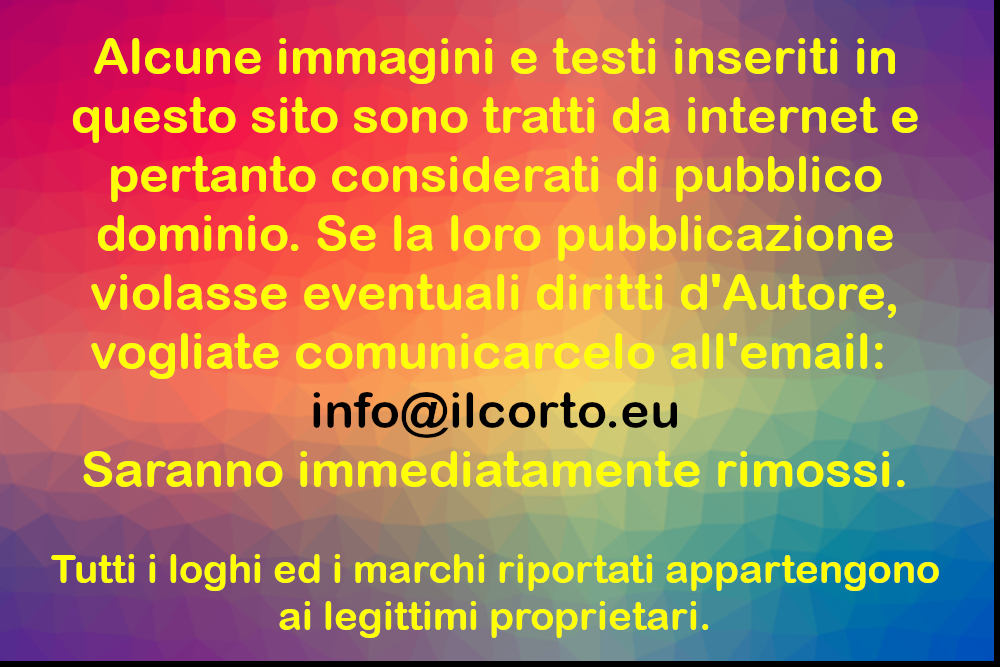“Il sorpasso” (1962) di Dino Risi è considerato un capolavoro della “commedia all’italiana” e, al tempo stesso, un film che svela l’anima inquieta di un Paese nel pieno del “boom economico”. La pellicola vede protagonista Bruno Cortona (Vittorio Gassman), un quarantenne estroverso, guascone e un po’ cialtrone, e Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant), un giovane timido e introverso. Il loro viaggio in auto, durante il Ferragosto, diventa un itinerario che attraversa l’Italia del benessere incipiente e svela contraddizioni, sogni e fragilità della società di inizio anni Sessanta.
“Il sorpasso” (1962) di Dino Risi è considerato un capolavoro della “commedia all’italiana” e, al tempo stesso, un film che svela l’anima inquieta di un Paese nel pieno del “boom economico”. La pellicola vede protagonista Bruno Cortona (Vittorio Gassman), un quarantenne estroverso, guascone e un po’ cialtrone, e Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant), un giovane timido e introverso. Il loro viaggio in auto, durante il Ferragosto, diventa un itinerario che attraversa l’Italia del benessere incipiente e svela contraddizioni, sogni e fragilità della società di inizio anni Sessanta.
Perché i dialoghi sono importanti?
- Mettono in contrasto due caratteri opposti: Bruno (logorroico, impulsivo) e Roberto (riservato, riflessivo). Le loro battute rivelano chi sono e come cambia il loro rapporto durante il viaggio.
- Offrono uno spaccato dell’Italia del tempo: riferimenti alla famiglia, al lavoro, alla moralità, al divertimento, all’ossessione per la macchina e la velocità.
- Alternano comicità e amarezza: dietro la facciata brillante delle parole di Bruno, si percepisce un vuoto esistenziale che coinvolge anche il giovane Roberto, arrivando al finale tragico.
- Caratterizzano situazioni e luoghi: ogni incontro, ogni sosta, ogni “sorpasso” diventa occasione per scambi di battute che fotografano l’Italietta di allora.
- Preparano la svolta drammatica: il climax emozionale ed esistenziale dei protagonisti si fonda anche sulla progressiva tensione costruita con i dialoghi.
Di seguito, i momenti in cui il dialogo risulta determinante, spiegando il perché.
1. L’incontro iniziale a Roma (Ferragosto)
- Contesto: Bruno, in una Roma deserta, cerca una cabina telefonica funzionante e incrocia per caso Roberto, chiuso in casa a studiare.
- Perché è determinante: Le prime battute tra i due stabiliscono immediatamente i caratteri antitetici: Bruno è espansivo e strafottente, Roberto è impacciato e gentile. Il dialogo convince (o costringe) il giovane a farsi trascinare in un giro in auto che cambierà tutto.
2. L’invito a pranzo e il “tradimento” dei piani di studio
- Contesto: Bruno propone a Roberto di uscire solo per un breve pranzo; in realtà, si spinge sempre più lontano da Roma.
- Perché è determinante: Roberto cerca di resistere (“Io dovrei studiare…”), ma Bruno lo sommerge di parole e promesse (“Solo un’oretta, dai!”). Il contrasto tra l’esuberanza e la reticenza mostra come il linguaggio di Bruno sia manipolatorio e affascinante, preparando Roberto a un’avventura fuori dal suo controllo.
3. La guida spericolata e il primo “sorpasso”
- Contesto: Bruno sfreccia sulla sua Lancia Aurelia, sorpassando chiunque. Roberto protesta per la velocità eccessiva.
- Perché è determinante: Il dialogo serve a definire Bruno come simbolo dell’imprudenza e dell’euforia “moderna” (l’auto diventa status symbol di libertà). Roberto cerca di esprimere la sua ansia, ma viene zittito da battute ironiche. È il nucleo stesso del film: il “sorpasso” è un gesto estremo e una mentalità spavalda.
4. La sosta al bar lungo la strada
- Contesto: Si fermano a un bar per bere qualcosa. Bruno chiacchiera con estranei e fa il gradasso, mentre Roberto assiste in silenzio.
- Perché è determinante: Le frasi di Bruno rivolte a sconosciuti creano immediata confidenza tipica dell’italiano estroverso e un po’ “cialtrone”. Roberto prova un certo disagio, ma viene incuriosito da un mondo che non conosce. I dialoghi descrivono l’Italia spensierata del boom, fatta di convenevoli e battute leggere.
5. L’idea di andare al mare
- Contesto: Bruno, dopo essersi stancato di Roma, propone a Roberto di raggiungere la costa laziale.
- Perché è determinante: Roberto esita, ma Bruno usa la logica dell’“adesso o mai più”, promettendo divertimento. I botta e risposta mostrano come Roberto inizi a cedere a quell’entusiasmo, scoprendo il piacere del “carpe diem” rispetto alla sua vita rigida.
6. L’episodio del parcheggio truffaldino
- Contesto: In un paesino, Bruno parcheggia in modo sconsiderato e poi finge di conoscere vigili o persone altolocate per evitare multe.
- Perché è determinante: I dialoghi tra Bruno e il vigile (o i passanti) svelano la sua abilità nel mentire con disinvoltura, sdoganando la “furbata” come stile di vita. Roberto assiste, combattuto tra ammirazione e vergogna.
7. L’incontro con l’amico “della buona società”
- Contesto: In un ristorante, Bruno incontra un conoscente benestante e lo saluta calorosamente.
- Perché è determinante: Bruno cerca di millantare rapporti di amicizia stretti, ma l’altro è meno entusiasta. Il dialogo è un esempio di apparenza e mondanità: Bruno vuole mostrarsi un viveur pieno di contatti, ma si percepisce che non c’è vera sostanza. Roberto osserva e inizia a intuire la solitudine dietro la maschera.
8. La cena con parenti o conoscenti di Bruno
- Contesto: Bruno porta Roberto a una cena dove ci sono parenti o vecchi amici, e parla in modo superficiale di matrimonio e famiglia.
- Perché è determinante: Emergono i conflitti di Bruno con i legami personali: attraverso le battute, si vede il suo disprezzo per la routine e la stabilità, nonché la sua incapacità di costruire rapporti solidi. Roberto ne è incuriosito ma al contempo spaventato.
9. La confessione di Roberto sulla sua timidezza
- Contesto: In un momento di tranquillità, Roberto ammette di essere sempre stato introverso, di non aver mai vissuto avventure.
- Perché è determinante: La sua ammissione sincera nasce dal clima di complicità creato da Bruno. Il dialogo svela la profonda insicurezza di Roberto, che si lascia trascinare perché cerca di rompere la sua gabbia. Uno spiraglio di intimità che rafforza il legame tra i due.
10. La rievocazione del padre di Roberto
- Contesto: Roberto parla del padre e della sua vita opaca, forse di un genitore assente o poco stimolante.
- Perché è determinante: Il dialogo mette in luce come Roberto proietti su Bruno la figura di un “fratello maggiore” o mentore. Al contempo, si comincia a intravedere la dimensione di famiglia spezzata o di modelli inesistenti: un vuoto che Bruno riempie, almeno temporaneamente.
11. L’approccio con le ragazze in spiaggia
- Contesto: Bruno sprona Roberto a corteggiare due ragazze, magari anche in modo un po’ maldestro.
- Perché è determinante: Le battute di Bruno sono fatte di goliardia e doppi sensi, stimolando Roberto a uscire dal guscio. Roberto cerca di imitare Bruno, ma fatica a trovare il tono giusto. Il divario tra i due si fa palese: la spensieratezza di Bruno fa sembrare Roberto ancora più ingenuo.
12. Il piccolo scontro sulla “vita reale”
- Contesto: A un certo punto, Bruno e Roberto discutono di futuro, responsabilità e lavoro. Roberto accenna alla laurea, Bruno ironizza sui “professori” e sulla noia di una vita ordinaria.
- Perché è determinante: È uno dei primi momenti in cui si scontra la filosofia esistenziale dei due: Bruno difende l’edonismo immediato, Roberto teme il vuoto ma non sa come sfuggirgli. Da questa frizione nasce la tensione che li spingerà verso il finale.
13. L’incontro con la figlia di Bruno
- Contesto: Bruno ritrova (o accenna a) una parente, una giovane che non vede da tempo. Il dialogo mostra imbarazzo e distanza.
- Perché è determinante: Rivela il fallimento di Bruno nel ruolo di padre o di parente, facendo emergere la sua superficialità e la sua recitazione costante. Roberto, vedendo la realtà dietro i sorrisi, si rende conto che c’è dolore e disillusione sotto l’allegria di facciata.
14. La sera prima del ritorno
- Contesto: Roberto e Bruno hanno un momento di confidenza più profondo, forse complice un bicchiere di troppo. Parlano di sogni, rimpianti, paure.
- Perché è determinante: Qui i due si avvicinano emotivamente: Roberto è incantato e al tempo stesso inquieto, Bruno confessa con frasi vaghe un senso di fallimento. Il dialogo fa presentire che l’illusione potrebbe infrangersi presto.
15. Il drammatico epilogo
- Contesto: Nell’ultima corsa, Bruno e Roberto sono in auto, Bruno provoca un sorpasso azzardato e avviene l’incidente mortale.
- Perché è determinante: Le battute finali, talvolta leggere o scherzose, si interrompono di colpo con la tragedia. È la resa dei conti: proprio mentre Bruno parla di tutto e di niente, la follia della velocità porta alla fine. Il silenzio successivo e il corpo di Roberto sulla scogliera valgono più di ogni parola, ma è chiaro come le frasi di Bruno, sempre fiduciose e superficiali, abbiano alimentato questa corsa verso il nulla.
Dai dialoghi di Il sorpasso possiamo imparare:
- Come caratterizzare due personalità opposte: Bruno e Roberto emergono subito grazie alle loro modalità comunicative.
- L’uso dell’ironia per svelare il vuoto: Le battute di Bruno sono spesso spiritose, ma nascondono un’esistenza senza radici.
- La tensione tra il dire e il non detto: Roberto è incerto, parla poco, ma lo spettatore coglie i suoi turbamenti.
- La costruzione di una tragedia “a colpi di parole”: La velocità verbale di Bruno si riflette nella guida spericolata; le parole diventano benzina per una corsa verso il disastro.
- Il commento sociale sull’Italia del boom: La mania di apparire, il desiderio di vivere alla giornata e l’assenza di valori solidi sono ritratti con feroce e affettuosa ironia proprio attraverso gli scambi verbali.
La parabola del film, con il suo finale crudele e inatteso, fa capire come la fuga verbale di Bruno e la passività di Roberto conducano a uno scontro frontale con la realtà. Studiare Il sorpasso insegna a scrivere dialoghi che siano “motore” dell’azione e, allo stesso tempo, specchio di un’epoca e di due esistenze alla deriva.