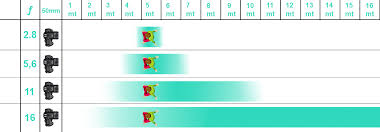Le lezioni di Gianfranco Manfredi
 IL PRIVATO SOCIALE. Analizzeremo in questa lezione quegli ambienti domestici che ricoprono una funzione sociale: il salotto di casa e gli spazi comuni del condominio.
IL PRIVATO SOCIALE. Analizzeremo in questa lezione quegli ambienti domestici che ricoprono una funzione sociale: il salotto di casa e gli spazi comuni del condominio.
IL SALOTTO. E' l'ambiente domestico storicamente deputato ad accogliere i visitatori. Chi ha una certa età, ricorderà che un tempo questa stanza era considerata a tal punto riservata agli ospiti occasionali, che in certe famiglie la si teneva chiusa e sempre perfettamente in ordine, per non fare cattiva figura. Oltre alla rivoluzione degli spazi interni caratteristica delle case post-boom, che avevano meno stanze a disposizione, è stata la presenza della televisione (l'apparecchio televisivo) a cambiare radicalmente la natura di questa stanza, mutandola da luogo di rappresentanza della famiglia, in una sorta di teatro privato. Al grande tavolo che normalmente occupava l'ambiente, essendo spesso il salotto anche destinato a sala da pranzo, sono subentrati i divani e le poltrone orientati verso l'apparecchio televisivo.
La televisione è stata anche il medium che ha reso dominante, fin dagli anni 50, questo ambiente della casa con le prime sit-com. La tradizione era stata ripresa dal teatro, in cui il salotto era un ambiente sul quale davano tutte le altre stanze della casa, e sul quale si apriva la cosiddetta "comune", cioè la porta principale d'ingresso.
Dunque, non una stanza riservata, ma il centro stesso della casa, da cui tutti passano e in cui tutti i personaggi si fermano. Una stanza che a volte si apriva su un giardino o su una grande terrazza, per offrire una maggiore profondità e altre possibilità di movimento. Sarebbe infatti terribilmente monotono e ripetitivo fare entrare ed uscire i personaggi, a turno, sempre dalla stessa porta. L'autore del copione si trova in questo modo a dover creare occasioni e pretesti perchè i vari personaggi passino da una porta piuttosto che da un'altra. Dal punto di vista della scritture, si può dire che le porte sono più importanti della stanza in sè. Si tratta di pensare la storia attraverso una regia dei movimenti dei personaggi, che costituiscono il necessario contraltare alla relativa fissità delle posizioni tra personaggi che si intrattengono tra loro nella stanza. Anche se non vengono mostrati gli altri ambienti della casa, dovete immaginarvi una topografia dell'appartamento, in modo che con l'andamento della pièce sia reso trasparente al pubblico che quella porta è la porta d'ingresso, che quell'altra è della camera da letto, l'altra ancora della cucina e così via. La disposizione dei mobili era già qui, in teatro, orientata verso la quarta parete, cioè la parete invisibile, rivolta al pubblico.
Similmente, nella sit-com televisiva, campeggia in genere un grande divano centrale, rivolto verso noi spettatori, che in questo modo ci troviamo di fronte a una sorta di specchio: noi schierati sul divano, guardiamo altri personaggi schierati su un divano.
La prima accortezza di uno sceneggiatore è la stessa sopra ricordata: cercare di muovere i personaggi, facendoli entrare e uscire dalle porte laterali e di fondo, in modo da togliere fissità alla scena, che però per quanti sforzi si facciano rende comunque obbligati e limitati i movimenti degli attori e mai ci mostra la quarta e misteriosissima parete. Nelle sit-com più recenti si ha cura di rendere questo ambiente più vario e multiuso (guardate ad esempio Friends oppure Will and Grace) con angolo salotto, angolo cucina, insomma sezioni dell'ambiente che possono consentirci inquadrature differenti e meno fisse. In cinema, la quarta parete non può essere invisibile, perchè ciò renderebbe appunto troppo teatrale e dunque "innaturale" la messa in scena.
Una ripresa cinematografica in genere mostra gli ambienti a 360°. Anche in questo caso, è bene che pensiate la vostra stanza (che sia un salotto reale, o che sia ricostruito in studio) in modo che si presti a ritagliare nello spazio situazioni particolari, ad esempio un angolo in cui due degli ospiti di una festa possano parlare in privato, senza essere ascoltati dagli altri presenti, punti di fuga su corridoi o altri ambienti, non necessariamente divisi da delle porte. Più un ambiente è affollato più bisogna creare occasioni perchè il quadro d'insieme non soffochi i personaggi, consentendoci comunque di ritagliare per loro ambiti e possibilità di movimento che li isolino (anche se solo convenzionalmente) dagli altri. Uno degli errori che si possono commettere più facilmente in sceneggiatura è quello di mettere in scena un gruppo di persone senza aver chiara la gerarchia dei personaggi. Dobbiamo sempre poter distinguere visivamente i protagonisti su cui dobbiamo concentrare l'attenzione, dai figuranti e dalle comparse. Questo vale soprattutto nel caso di una festa o di un ricevimento, ma quando invece mettiamo in scena un ristretto gruppo di amici, è bene comunque considerarne attentamente i ruoli. La prima distinzione di base è tra il padrone di casa e gli ospiti. Questa differenza ormai si è fatta più sfumata di un tempo. Anche se la casa è di tizio, i suoi amici-ospiti possono essere disinvolti come se si trovassero a casa loro. Già questo però può darvi delle occasioni narrative, perchè pur nella famigliarità di gruppo, i personaggi sono diversi: può esserci l'ospite abitudinario per il quale è più ovvio che si consideri "a casa", ma può esserci anche quello invadente perchè maleducato, o quello curioso che trovandosi lì per la prima volta guarda dappertutto.
Riguardo al dialogo e alla distribuzione delle battute, tutti devono trovare il modo di interloquire, naturalmente nella giusta misura. Evitate lunghi monologhi del protagonista con tutti gli altri che si limitano ad ascoltare o intervengono solo per dargli ragione. Voi non state raccontando solamente il protagonista cui gli altri fanno da mero contorno, voi avete messo in scena un gruppo di amici. Se anche un personaggio in una determinata circostanza parla più degli altri o fa da centro della conversazione, non dimenticate mai che gli altri personaggi devono esprimersi o con le espressioni o con interlocuzioni che corrispondano al loro carattere. Non commettete l'errore di affidarvi solo al dialogo (e/o a un dialogo meramente funzionale). Ciò che si dice è figlio di ciò che si vede. In scena c'è un gruppo di persone differenti, con certe dinamiche tra loro, che non possono venire meramente delegate all'inventività degli attori, devono essere pensate dallo sceneggiatore: se una ragazza è semisdraiata sul divano, un ragazzo seduto sul tappeto schiena al divano, un altro appollaiato sul bracciolo di una poltrona, un altro ancora in posizione più isolata e discosta, uno sempre in movimento per darsi un contegno, questo genere di scelte possono rimarcare e identificare il carattere di ciascuno dei vostri personaggi. Voi dovete "vedere" la scena. E' sulla base di quello che si vede che si costruisce dialogo.
Non viceversa. Questo errore (cioè il viceversa) è comunissimo tra gli sceneggiatori (non solo di cinema, anche di fumetti). Si scrive il dialogo e si suppone che ciò che si deve vedere, vada di conseguenza. Sbagliatissimo nella comunicazione visiva. Non siamo alla radio, né stiamo leggendo un libro. Un gesto, un'espressione, una posizione, possono rendere superflua la battuta, oppure possono darle senso e vita.
Ma ciò che si vede, in cinema, viene sempre prima di ciò che si ascolta. Questo è uno dei motivi per cui quando un personaggio pronuncia una battuta particolarmente importante, nel cinema classico si stringe su di lui, non solo per sottolineare l'intensità della sua espressione, ma anche per escludere possibili distrazioni, per togliere dal campo visivo tutto ciò che può far perdere concentrazione al pubblico. Si tratta in genere di un momento di assoluta intimità (per quanto espressa) che viene isolata dal contesto sociale. Se invece lo stesso personaggio non sta solamente dando voce e sfogo ai suoi pensieri, ma si rivolge a tutti o a qualcuno in particolare, ecco che allora la scena (la posizione stabilita per i personaggi) deve consentirlo. Ci sono attori che tendono sempre a "parlare da soli", altri invece che hanno assoluto bisogno, per dare forza alla propria espressività, di rivolgersi a qualcuno in particolare, di guardarlo negli occhi, di stabilire una comunicazione diretta con questo o quello.
Magari voi non saprete ancora, mentre scrivete, quale attore interpreterà un certo personaggio, ma dovete avere ben chiaro chi è il vostro personaggio: un introverso? Un vanitoso? Un polemico per natura? Un chiacchierone? E dovete aver ben presente anche quali sono i suoi rapporti con le persone che ha intorno. Con qualcuno di loro ha un dialogo più diretto? Ne sta trascurando un altro, magari il suo migliore amico, perchè in quel momento gli preme di più conoscere un nuovo arrivato? Tutte queste dinamiche psicologiche sono il fondamento di un dialogo. E il fondamento di queste dinamiche è visivo, si appoggia sulla dislocazione nell'ambiente e sull'atteggiamento dei personaggi.
In un salotto vi troverete sempre, per le caratteristiche strutturali e storiche dell'ambiente, implicati in una dinamica pubblico-privato. Un film che vi consiglio caldamente di studiare, perchè di impianto teatrale, ma in forma quanto mai cinematografica, è Festa per il compleanno del caro amico Harold (The Boys in the Band, 1970, di William Friedkin). Prima opera Hollywoodiana sull'omosessualità, questo film al di là del tema, può offrirvi un esempio perfetto di narrazione corale (nel primo tempo) cui segue (nel secondo) un approfondimento drammatico dei singoli (spesso isolati e al telefono) e illustrarvi nel modo migliore come si possa dare continuamente dinamica ad un interno con terrazza, attraverso i differenti e distinti ruoli dei personaggi, il loro comparire e uscire di scena, il loro essere centro o margine della conversazione, senza che nessuno venga relegato a mero contorno.
b) IL CONDOMINIO
Gli spazi abitativi comuni, pianerottoli, scale, atrio d'ingresso, portineria, cortile di casa, erano nel cinema italiano del dopoguerra ambienti assolutamente fondamentali.
La famiglia viveva all'interno di un contesto collettivo. Non la si mostrava isolata, conoscevamo anche i suoi vicini, attraverso gli spazi comuni del palazzo. Gli ultimi condominii del cinema italiano datano dai tempi di Fantozzi che vive in un palazzone disumano, ma che già concentra la sua attenzione più sui colleghi di lavoro che sui vicini di casa. Si segna in questo modo un passaggio storico: dal condominio comeluogo di vita in comune, al condominio come coabitazione di assoluti sconosciuti, ciascuno rinchiuso nella privacy del proprio appartamento. Dopo di che, l'ultimo e inevitabile passaggio, è stato segnato nel cinema italiano, dalla scomparsa degli spazi comuni. I personaggi vengono mostrati già nel loro appartamento. Magari c'è un location shot dove si mostra il palazzo in cui abita il nostro protagonista, ma non lo vediamo mai fare le scale, incontrare dei vicini, ritirare la posta, se non quando è narrativamente funzionale al personaggio stesso, e non per raccontare il suo contesto sociale.
Questa ormai consolidata abitudine può rappresentare un colossale errore se per esempio dovete scrivere un film o un film tv ambientato negli anni 40 o 50, dove questo concetto della privacy non esisteva e dove dunque il contesto abitativo va raccontato per forza. Ma può rappresentare un limite anche se raccontate un film nell'epoca attuale. Il condominio si presta ancora e non poco alla narrazione cinematografica. Basti citare La Comunidad (di Alex de la Iglesia, 2000) o Rec (di Paco Plaza e Jaume Balagueró, 2007) entrambi ambientati in un grande condominio.
Sono film spagnoli e può anche darsi che in Spagna sopravviva più che da noi il senso del condominio come spazio collettivo. Può anche darsi però che il nostrocinema abbia nel tempo, consapevolmente o meno, sposato un certo ideale di vita piccolo-borghese che rifugge dall'idea di raccontare il "popolo" e nemmeno le sopravvivenze di costumi "popolari", perchè è indubbio che anche in Italia in un condominio popolare, si instaurano tuttora rapporti più stretti con i vicini di casa che in un palazzo borghese. D'altra parte, nei film americani gli spazi comuni, anche in elegantissimi palazzi di New York, vengono narrati più spesso che da noi. Lo status del palazzo in cui abita il nostro personaggio, il tipo di vicini che incrocia (non necessariamente salutandoli) ci rivelano molto di lui, e sono dunque considerati elementi preziosi per la narrazione. Quand'anche limitati alle scene di passaggio (entrate e uscite di casa) sono senz'altro più identificativi del nostro personaggio e del clima che lo circonda di una scena di transito in auto. Il condominio e i suoi spazi comuni, sono di per sè, elemento di passaggio tra privato e sociale. Non dimenticate mai che questa relazione privato-sociale è il nodo su cui uno sceneggiatore costruisce il proprio personaggio. Tanto più oggi, che l'ambiente di lavoro non identifica più il luogo principe delle relazioni sociali, e il posto di lavoro è spersonalizzato, il palazzo in cui si abita, con la sua stessa socialità decaduta, "privato" anche in quanto deprivato di relazioni, è ambiente da non trascurare per raccontare a tutto tondo il nostro protagonista e la sua vita quotidiana.
LEZIONE XL di Gianfranco Manfredi
 Andiamo in bagno diverse volte ogni giorno, eppure questa abituale attività non è rappresentata con corrispondente frequenza nel cinema. In particolare il tempo che dedichiamo alle necessità fisiologiche non viene abitualmente considerato in una storia. D'altro canto, anche nella storia dell'arte figurativa, della letteratura e del teatro, sono rarissimi gli esempi in cui si rappresenta questo genere di attività, da un lato oggetto di persistente pudore, dall'altro, momento di pausa per eccellenza, poco significativo nello sviluppo di una storia e sul quale si può dunque tranquillamente soprassedere. Eppure, come ambiente, il bagno una sua importanza ce l'ha nella nostra vita individuale e nello sviluppo stesso della nostra società. Nello spazio di un secolo siamo passati da bagni o latrine esterne, ai doppi/tripli servizi come indicatore di livello di sviluppo civile. Gli standard minimi di confortevolezza abitativa, passano dalla storia delle stanze da bagno.
Andiamo in bagno diverse volte ogni giorno, eppure questa abituale attività non è rappresentata con corrispondente frequenza nel cinema. In particolare il tempo che dedichiamo alle necessità fisiologiche non viene abitualmente considerato in una storia. D'altro canto, anche nella storia dell'arte figurativa, della letteratura e del teatro, sono rarissimi gli esempi in cui si rappresenta questo genere di attività, da un lato oggetto di persistente pudore, dall'altro, momento di pausa per eccellenza, poco significativo nello sviluppo di una storia e sul quale si può dunque tranquillamente soprassedere. Eppure, come ambiente, il bagno una sua importanza ce l'ha nella nostra vita individuale e nello sviluppo stesso della nostra società. Nello spazio di un secolo siamo passati da bagni o latrine esterne, ai doppi/tripli servizi come indicatore di livello di sviluppo civile. Gli standard minimi di confortevolezza abitativa, passano dalla storia delle stanze da bagno.
 Il numero e la confortevolezza delle sale da bagno in un harem è sempre stato di gran lunga maggiore di quello dei nostri bordelli, e persino delle nostre regge e palazzi nobiliari: per secoli questa differenza ha evidenziato un livello di igiene pubblica molto più sviluppato in oriente che in occidente. Gli esempi di "scene in bagno" sono d'altro canto di gran lunga aumentati in letteratura e in cinema nel dopoguerra. Questo è il sintomo evidente di un abbassamento della "soglia del pudore" e insieme di una identificazione del bagno come luogo esemplare, particolarmente adatto a rappresentare situazioni narrative "di limite".
Il numero e la confortevolezza delle sale da bagno in un harem è sempre stato di gran lunga maggiore di quello dei nostri bordelli, e persino delle nostre regge e palazzi nobiliari: per secoli questa differenza ha evidenziato un livello di igiene pubblica molto più sviluppato in oriente che in occidente. Gli esempi di "scene in bagno" sono d'altro canto di gran lunga aumentati in letteratura e in cinema nel dopoguerra. Questo è il sintomo evidente di un abbassamento della "soglia del pudore" e insieme di una identificazione del bagno come luogo esemplare, particolarmente adatto a rappresentare situazioni narrative "di limite".
Ad esempio, alle origini del cinema neo-realista che programmaticamente intendeva rappresentare tutti i momenti dell'esistenza quotidiana e dunque anche le permanenze "in cesso", questa scelta destò non poche polemiche. Quando il senatore Andreotti denunciò il fatto che il cinema italiano non faceva onore al paese rappresentando situazioni che sarebbe stato meglio evitare di mostrare (cioé "lavava i panni sporchi in pubblico"), non si riferiva tanto al cinema di denuncia sociale, quanto all'indulgere nella rappresentazione di situazioni giudicate "indecorose" come ad esempio mostrare persone in canotta e mutande calate che leggevano il giornale sulla tazza del cesso e consimili situazioni di vita quotidiana che il "comune senso del pudore" giudicava quanto meno di cattivo gusto. E persino negli anni 60 e 70, ormai vaccinati dall'abitudine alla provocazione, ben più dei "bed-in" di John Lennon e Yoko Ono, destò scandalo il poster di Frank Zappa che dissacrando violentemente anche il mito della rock star, abitualmente rappresentata come una sorta di divinità, sifece effigiare seduto sul cesso. Da allora, lentamente e progressivamente, l'aura di scandalo attorno alla stanza da bagno si è molto stemperata.
Intendiamoci: anche oggi è molto difficile che una star cinematografica accetti di farsi riprendere seduta sulla tazza del cesso, però l'inviolabile sacralità del bagno è finita. Questo genere di scene si sono moltiplicate nei film e non sono più un tabù. Ma come e perchè vengono utilizzate? Dev'esserci alla base un elemento di coerenza con il racconto. E devono essere occasione per rappresentare qualcosa che non si riduce al semplice mostrare ciò che possiamo dare per scontato e cioè che ogni persona ha la necessità di fare i propri bisogni e/o di lavarsi regolarmente.
Consideriamo in proposito alcune scene celebri nella storia del cinema, ambientate in bagno, da un lato nella commedia, dall'altro nel dramma.
a) Il Bagno in commedia
 Consiglio di vedere attentamente due scene esemplari dei film Hollywood Party (in originale The Party, 1968) di Blake Edwards, e Tutti pazzi per Mary (There's Something About Mary, 1998) di Bobby e Peter Farrelly. Nel primo film, il protagonista Peter Sellers ospite di una faraonica villa hollywoodiana e afflitto da un'irrefrenabile necessità fisiologica, riesce finalmente a trovare un gabinetto nel quale combina guasti a catena. E' una delle scene comiche più irresistibili del film, nella quale tutti gli elementi dell'ambiente vengono usati: i rotoli di carta igienica, l'impianto idrico della tazza, eccetera. Scene simili erano state coraggiosamente interpretate in televisione già anni prima, ad esempio nella famosa serie di telefilm per famiglie I Love Lucy (1951/1957) con Lucille Ball. La serie ironizzava sui nuovi costumi di vita americani della middle class, in particolare l'uso sempre più spinto degli elettrodomestici nella vita domestica, con un satira spesso corrosiva che valse persino all'attrice l'etichetta di "comunista". In uno degli episodi viene mostrato il tentativo di Lucille e della sua amica di installare da sole una doccia, nella quale finiscono imprigionate fin quasi ad annegare. Le gag basate sull'acqua e sui tubi sono antiche quanto il cinema: una delle prime comiche mute rappresentava appunto i guai provocati da una pompa da giardino. Lo sviluppo di Blake Edwards, che parte dalla situazione di un bisogno fisiologico, rappresenta uno scatto in più e riesce a rendere non solo gradevole, ma spassosa una situazione che fino a pochi anni prima sarebbe parsa volgare e non rappresentabile: ad esempio il senso di liberazione nello sfogo di una pisciata troppo a lungo trattenuta.
Consiglio di vedere attentamente due scene esemplari dei film Hollywood Party (in originale The Party, 1968) di Blake Edwards, e Tutti pazzi per Mary (There's Something About Mary, 1998) di Bobby e Peter Farrelly. Nel primo film, il protagonista Peter Sellers ospite di una faraonica villa hollywoodiana e afflitto da un'irrefrenabile necessità fisiologica, riesce finalmente a trovare un gabinetto nel quale combina guasti a catena. E' una delle scene comiche più irresistibili del film, nella quale tutti gli elementi dell'ambiente vengono usati: i rotoli di carta igienica, l'impianto idrico della tazza, eccetera. Scene simili erano state coraggiosamente interpretate in televisione già anni prima, ad esempio nella famosa serie di telefilm per famiglie I Love Lucy (1951/1957) con Lucille Ball. La serie ironizzava sui nuovi costumi di vita americani della middle class, in particolare l'uso sempre più spinto degli elettrodomestici nella vita domestica, con un satira spesso corrosiva che valse persino all'attrice l'etichetta di "comunista". In uno degli episodi viene mostrato il tentativo di Lucille e della sua amica di installare da sole una doccia, nella quale finiscono imprigionate fin quasi ad annegare. Le gag basate sull'acqua e sui tubi sono antiche quanto il cinema: una delle prime comiche mute rappresentava appunto i guai provocati da una pompa da giardino. Lo sviluppo di Blake Edwards, che parte dalla situazione di un bisogno fisiologico, rappresenta uno scatto in più e riesce a rendere non solo gradevole, ma spassosa una situazione che fino a pochi anni prima sarebbe parsa volgare e non rappresentabile: ad esempio il senso di liberazione nello sfogo di una pisciata troppo a lungo trattenuta.
Tutti pazzi per Mary è un gradino ulteriore in quanto mette in scena il protagonista Ben Stiller che in previsione di un incontro erotico, temendo di non riuscire a controllare l'eccitazione e di avere un'eiaculazione troppo precoce, su consiglio di un amico, si masturba in bagno prima che l'incontro abbia luogo. Lo sperma stesso diventa origine di una scena comica irresistibile, quando la ragazza, giunta prima del previsto, lo scambia per un gel e se lo mette sui capelli. Anni prima, una scena simile sarebbe stata bandita da un film comico "per tutti". Anche in questo caso, più la scena è al limite, più si tratta di essere accorti nel renderla "lieve" cioé nel non involgarirla con dettagli che potrebbero causare disgusto. D'altro canto se una simile scena era ormai rappresentabile, ciò significava senza ombra di dubbio che ormai la generalità del pubblico non la considerava più istintivamente fastidiosa. Del resto non è l'unica scena in bagno del film. Ce n'è un'altra nella quale Ben Stiller, anni prima, ha un altro incidente in bagno, nella casa della ragazza, quando si chiude la zip sui coglioni. In altre parole, l'ambiente bagno viene usato per rappresentare una sorta di evento traumatico che si ripete come un imbarazzante destino nella vita del protagonista. E in questo si può già evidenziare come il bagno mantenga tutta la sua natura originale di ambiente "eccezionale", riservato, privato per definizione e ai limiti della rappresentazione. Insomma: non si mette in scena un bagno per rappresentare qualcosa di abituale, al contrario il bagno è l'ambientazione ideale per rappresentare una situazione estrema.
b) Il Bagno nel dramma
Anche in questo caso consiglio due film fondamentali: Psycho (1960) di Alfred Hitchcock e The Shining (1980) di Stanley Kubrick . Il primo, con la famosissima scena della doccia, condiziona la storia del cinema a venire: mai scena è stata infatti più imitata. Come ho già rilevato in una precedente lezione, se si facesse una compilation di tutte le scene di delitti o di aggressioni o di minacce sotto la doccia nel cinema (non solo horror) dopo Psycho, ne uscirebbe un video di durata interminabile.
 E se si confrontassero queste scene, si potrebbe scoprire quante infinite varianti si possono sviluppare da un'unica radice. Del resto, lo stesso Hitchcock è probabile si sia ispirato a un precedente, cioè il film The Seventh Victim (1943) di Mark Robson prodotto da Val Lewton. In una scena di questo film, vediamo la protagonista, sotto la doccia, che riceve la improvvisa visita di una inquietante signora di cui vediamo soltanto l'ombra minacciosa attraverso la tenda della doccia. La signora non aggredisce, si limita a rivelare un inquietante segreto alla protagonista, ma la situazione di tensione c'è già tutta e nasce da un paradosso. La doccia infatti non è soltanto un luogo di estrema riservatezza, ma è anche un luogo eminentemente confortevole. Che un ambiente ideato come rimedio antistress, diventi invece l'ambiente stressante per eccellenza, è un capovolgimento drammatico non da poco. Il trovarsi nudi sotto un getto d'acqua, da cerimoniale di purificazione, diventa sintomatico della totale impossibilità di difendersi. Ora, per quanto la scena di Psycho sia stata imitata, per quanto sia diventata un topos quasi obbligato, uno sceneggiatore deve tenere in debito conto alcuni elementi di ordine pratico e produttivo: la scena dura soltanto quarantacinque secondi nel film, ma comportò duemila dollari di spesa soltanto per pagare lo storyboard di Saul Bass. Infatti prima delle riprese fu necessario disegnare ogni singola inquadratura. L'esigenza di superare i prevedibili ostacoli della censura, spinse Hitchock a scegliere di girare la scena per stacchi repentini e improvvisi "in modo che il pubblico non possa rendersi conto di che diavolo sta succedendo". Dunque vennero alternati i più diversi punti di vista e angolazioni, in genere piani molti stretti. Bisognava creare l'effetto di un'aggressione selvaggia e di inaudita violenza, senza mostrarla in dettaglio. Per consentire questa varietà di riprese in un ambiente ristretto come quello di una doccia, fu necessario costruire un ambiente con quattro pareti rimovibili. Dopo vari adattamenti si programmarono ben settantotto diverse posizioni di camera per riprendere la sequenza. Secondo il foglio di produzione per realizzare la scena della doccia sarebbero stati necessari undici giorni di riprese! Se dunque qualcuno di voi pensa che una scena di paragonabile efficacia possa venire realizzata semplicemente piazzando una donna nuda sotto una doccia, commette un errore di ingenuità. Oggi è praticamente impossibile che una produzione autorizzi un regista ad impiegare undici giorni per girare una scena di quarantacinque secondi. E' già difficile ottenere che per una scena in bagno si ricostruisca un bagno in studio. Ma in un bagno autentico le difficoltà per girare una scena simile sarebbero insormontabili: lo spazio per muoversi è estramente ridotto, le angolazioni possibili poche e obbligate, e anche girando con una camera digitale e più flessibile, la doccia stessa, il vapore, la disposizione "naturale" delle luci, renderebbero la scena impraticabile.
E se si confrontassero queste scene, si potrebbe scoprire quante infinite varianti si possono sviluppare da un'unica radice. Del resto, lo stesso Hitchcock è probabile si sia ispirato a un precedente, cioè il film The Seventh Victim (1943) di Mark Robson prodotto da Val Lewton. In una scena di questo film, vediamo la protagonista, sotto la doccia, che riceve la improvvisa visita di una inquietante signora di cui vediamo soltanto l'ombra minacciosa attraverso la tenda della doccia. La signora non aggredisce, si limita a rivelare un inquietante segreto alla protagonista, ma la situazione di tensione c'è già tutta e nasce da un paradosso. La doccia infatti non è soltanto un luogo di estrema riservatezza, ma è anche un luogo eminentemente confortevole. Che un ambiente ideato come rimedio antistress, diventi invece l'ambiente stressante per eccellenza, è un capovolgimento drammatico non da poco. Il trovarsi nudi sotto un getto d'acqua, da cerimoniale di purificazione, diventa sintomatico della totale impossibilità di difendersi. Ora, per quanto la scena di Psycho sia stata imitata, per quanto sia diventata un topos quasi obbligato, uno sceneggiatore deve tenere in debito conto alcuni elementi di ordine pratico e produttivo: la scena dura soltanto quarantacinque secondi nel film, ma comportò duemila dollari di spesa soltanto per pagare lo storyboard di Saul Bass. Infatti prima delle riprese fu necessario disegnare ogni singola inquadratura. L'esigenza di superare i prevedibili ostacoli della censura, spinse Hitchock a scegliere di girare la scena per stacchi repentini e improvvisi "in modo che il pubblico non possa rendersi conto di che diavolo sta succedendo". Dunque vennero alternati i più diversi punti di vista e angolazioni, in genere piani molti stretti. Bisognava creare l'effetto di un'aggressione selvaggia e di inaudita violenza, senza mostrarla in dettaglio. Per consentire questa varietà di riprese in un ambiente ristretto come quello di una doccia, fu necessario costruire un ambiente con quattro pareti rimovibili. Dopo vari adattamenti si programmarono ben settantotto diverse posizioni di camera per riprendere la sequenza. Secondo il foglio di produzione per realizzare la scena della doccia sarebbero stati necessari undici giorni di riprese! Se dunque qualcuno di voi pensa che una scena di paragonabile efficacia possa venire realizzata semplicemente piazzando una donna nuda sotto una doccia, commette un errore di ingenuità. Oggi è praticamente impossibile che una produzione autorizzi un regista ad impiegare undici giorni per girare una scena di quarantacinque secondi. E' già difficile ottenere che per una scena in bagno si ricostruisca un bagno in studio. Ma in un bagno autentico le difficoltà per girare una scena simile sarebbero insormontabili: lo spazio per muoversi è estramente ridotto, le angolazioni possibili poche e obbligate, e anche girando con una camera digitale e più flessibile, la doccia stessa, il vapore, la disposizione "naturale" delle luci, renderebbero la scena impraticabile.
Insomma: se ambientate una scena in bagno, dovete appurare prima di scriverla, se la produzione consente riprese in studio e in un ambiente attrezzato allo scopo oppure se la scena verrà girata in un ambiente reale, cioè in un vero bagno. In quest'ultimo caso, toglietevi dalla testa Psycho. In The Shining il bagno è egualmente usato drammaticamente come luogo di un'aggressione. La ristrettezza dell'ambiente, che ha come unica via di fuga una finestrella, viene anche in questo caso sottolineata e rese ancor più angosciosa da riprese molto strette e la dinamica viene assicurata da una notevole quantità di stacchi. Si tratta egualmente di una scena estremamente complessa nella preparazione e nell'esecuzione, che richiede notevoli mezzi economici e molti giorni di riprese. In questo caso le preoccupazioni hicthcokiane di evitare la censura, erano cadute ( c'è un'altra scena in bagno, nel film, dove una donna viene mostrata completamente nuda). Restava però l'esigenza di usare l'ambientazione per una resa drammatica estrema. In un tempo contratto e in un ambiente ristretto il ritmo e la mobilità della scena devono aumentare e ciò comportauna location adeguata e tempo per le riprese.
Tenete dunque a mente, quando sceneggiate, che un scena di breve durata non è necessariamente una scena che si possa girare alla svelta. Tutto dipende non solo da cosa avviene, ma da cosa bisogna esprimere, e dunque dallo stile necessario a dare il massimo sotto il profilo dell'intensità espressiva e dai quattrini a disposizione.
Riassumendo: le scene in bagno (che si tratti di una commedia o di un dramma) sono da considerare scene climax. Quello che nella realtà è un ambiente abitudinario, in cinema è un ambiente eccezionale, cui è bene ricorrere per situazioni limite e di massimo risalto espressivo e a condizione che la macchina produttiva lo consenta.
LEZIONE XXXVIII di Gianfranco Manfredi
 Si tende ad ambientare in camera da letto le scene di risveglio (di cui abbiamo già parlato) e quelle di sesso, il che è piuttosto ovvio. In realtà la camera da letto è più simile di quanto si pensi ad una stanza di soggiorno. Scrive Anthony Burgess (Letti, 1982, Rizzoli): "Il letto è un mobile pulifunzionale, intorno al quale si organizza la vita di tutta la famiglia o di alcuni dei suoi componenti. Così il letto ha finito per simboleggiare, anche nella vita di tutti i giorni, i concetti di comodità e di distensione (...) Per i bambini poi il letto è anche il simbolo dell'unità e dell'affetto famigliare e proprio alla ricerca di tali sensazioni tentano con moine e manfrine di vario tipo, di essere accolti nel lettone dei genitori." E' dunque bene che uno sceneggiatore non dimentichi questa natura primaria, simbolica, e insieme sociale del letto. Una conversazione tra amiche, per esempio, che potrebbe essere ambientata in qualsiasi posto, un bar, un salotto, una spiaggia, se viene ambientata in una camera da letto esprime da subito e con immediatezza quel senso di confidenza, di comodità, e di unità d'affetti che in altri ambienti deve essere ricreato attraverso l'isolamento, il tono di voce, i gesti e gli atteggiamenti.
Si tende ad ambientare in camera da letto le scene di risveglio (di cui abbiamo già parlato) e quelle di sesso, il che è piuttosto ovvio. In realtà la camera da letto è più simile di quanto si pensi ad una stanza di soggiorno. Scrive Anthony Burgess (Letti, 1982, Rizzoli): "Il letto è un mobile pulifunzionale, intorno al quale si organizza la vita di tutta la famiglia o di alcuni dei suoi componenti. Così il letto ha finito per simboleggiare, anche nella vita di tutti i giorni, i concetti di comodità e di distensione (...) Per i bambini poi il letto è anche il simbolo dell'unità e dell'affetto famigliare e proprio alla ricerca di tali sensazioni tentano con moine e manfrine di vario tipo, di essere accolti nel lettone dei genitori." E' dunque bene che uno sceneggiatore non dimentichi questa natura primaria, simbolica, e insieme sociale del letto. Una conversazione tra amiche, per esempio, che potrebbe essere ambientata in qualsiasi posto, un bar, un salotto, una spiaggia, se viene ambientata in una camera da letto esprime da subito e con immediatezza quel senso di confidenza, di comodità, e di unità d'affetti che in altri ambienti deve essere ricreato attraverso l'isolamento, il tono di voce, i gesti e gli atteggiamenti.
La camera da letto è fondamentale quando si deve raccontare la storia di un bambino.
In questo caso assume anche un aspetto di incrocio tra il contesto di vita e famigliare (l'affetto con cui i genitori l'hanno decorata pensando a lui come "bambino") e il suo privato (gli oggetti e i giochi cui è più affezionato e che rivelano qualcosa di lui, i poster e le affiches con cui il bambino o il ragazzino l'hanno personalizzata). Nel corso della crescita, da ambiente riservato dai genitori al bimbo, la camera da letto accentua il suo carattere personale e privato. C'è un momento dell'adolescenza in cui il ragazzino sente il bisogno di dichiarare esclusiva la SUA stanza e allora affigge sulla porta il classico cartello VIETATO ENTRARE. La camera da letto dunque è un ambiente, in questo caso, evolutivo, che segna il maturare di una propria e autonoma personalità. Non ci si affida più alla stanza dei genitori per ottenere rassicurazione, come nella prima infanzia, ma ci si separa per rassicurarsi sulla propria e autonoma identità. Questo trapasso è mostrato in molti film. Nel film Poltergeist di Steven Spielberg (sceneggiatura) e Tobe Hooper (regia) del 1982, la camera da letto è un ambiente multiplo che esplora tutte queste sfumature: c'è la camera da letto con il lettone dei genitori e la televisione davanti, dove appunto ottenere rassicurazione dalle paure notturne e dove anche vivere un'intimità famigliare rilassata e giocosa, anche sancita da quell'altare di famiglia che è il televisore (con tutte le sue insidie, nel caso); c'è la camera da letto del bimbo che si trova ossessionato dall'inquietante "mondo esterno" (l'albero fuori dalla finestra, scosso dalla tempesta e pronto ad irrompere nella stanza, spezzando i vetri) e dai pupazzi/bambolotti che si mutano di notte in presenze vive e minacciose. Attraverso la camera da letto (le camere da letto) gli autori dipingono un quadro del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, raccontando turbamenti che rappresentati in un altro ambiente non avrebbero la stessa forza simbolica. Questo aspetto in cinema è da tenere sempre presente: l'ambiente crea psicologia. Non dovete pensare alla psicologia di un personaggio come se fosse semplicemente inscritta in lui e collocabile ovunque. L'ambiente non è mero fondale e scenario. L'ambiente forma gli stati d'animo. Quando dunque scegliete un ambiente per una situazione narrativa, non sceglietelo per una mera questione di opportunità, sceglietelo per i suoi valori espressivi e simbolici.
In molti film Gialli, l'esplorazione da parte del detective della camera da lettodell'indiziato è spesso la sede della rivelazione della psicologia dell'indagato e non ci si limita all'esplorazione della camera da letto attuale, ma si va persino alla ricerca della sua stanza da bambino, nella quale possiamo vedere la genesi della sua personalità. Nella realtà non avviene mai che un poliziotto vada a frugare nella casa dei genitori, e nella stanza del killer da bambino, sia perchè questa stanza in genere non esiste più (mentre nei film è rimasta come una sorta di sacrario museale mantenuto inalterato negli anni) sia perchè nessun investigatore considererebbe determinante esplorare un ambiente frequentato dall'assassino in epoche assai lontane dal suo delitto. In cinema invece questa "radice" è fondamentale non per un'esigenza realistica, ma simbolica. L'esame della camera da letto, delle fotografie, dei passatempi giovanili, dei vezzi privati di un killer, è esplorazione del suo animo, della sua psicologia, cioè della sua intimità, e insieme del contesto famigliare in cui è maturata la sua personalità.
 Ma riprendiamo dalle situazioni ovvie, la più ovvia delle quali è la classica scena d'amore e di sesso, rispetto alla quale il cinema, nella sua storia, mostra un atteggiamento inizialmente piuttosto pudico: la macchina da presa indietreggia o si ferma sulla soglia della camera da letto, da un lato per sottolineare la privacy dei personaggi che in quel momento si separano dal mondo e dagli sguardi altrui, d'altro lato per non raccontare ciò che narrativamente (in un certo contesto narrativo) non offrirebbe spunti particolari: i due fanno l'amore, come normali esseri umani.
Ma riprendiamo dalle situazioni ovvie, la più ovvia delle quali è la classica scena d'amore e di sesso, rispetto alla quale il cinema, nella sua storia, mostra un atteggiamento inizialmente piuttosto pudico: la macchina da presa indietreggia o si ferma sulla soglia della camera da letto, da un lato per sottolineare la privacy dei personaggi che in quel momento si separano dal mondo e dagli sguardi altrui, d'altro lato per non raccontare ciò che narrativamente (in un certo contesto narrativo) non offrirebbe spunti particolari: i due fanno l'amore, come normali esseri umani.
Mostrare come lo fanno non aggiunge nulla alla nostra narrazione ed è dunque bypassabile, anzi è meglio immaginarlo, ciascuno con la propria sensibilità, sulla base delle proprie memorie, della propria esperienza e della propria fantasia.
L'identificazione è favorita in questo caso dal non mostrare più che dall'esibire.
Ovviamente in questi film, l'accoppiamento è una manifestazione di sentimento più che di erotismo. Rispetto al "sentimento" il riserbo è maggiore che rispetto a un atto fisico. C'è qualcosa di soggettivo, di intimo, che non può venire rappresentato pienamente nell'oggettività della situazione perchè ne verrebbe svilito. La camera da letto è in questo caso un ambiente per certi versi Tabù, come un tabernacolo dove si è al cospetto del Sacro, cioè del Non Rappresentabile ( Non fatevi immagine alcuna, come recita il Comandamento), luogo non-luogo del Mistero, del cerimoniale segreto che acquista senso solo per chi vi partecipita, non per chi vi assiste.
Nel tempo e con l'evoluzione del costume, a sessualità de-sacralizzata e disvelata, la macchina da presa non arretra più, entra in camera da letto, nella camera degli amanti e ce li mostra mentre si amano. Anche qui, però, se ci fate caso, una certa segretezza, un senso di occultamento permane: nel gioco della penombra che dissolve i corpi in forme, nei dettagli alternati di corpi nudi che si abbracciano avvolti da una musica che detemporalizza la situazione. Non ci vengono mostrate "tecniche" d'accoppiamento, ma una sorta di sintesti emotiva di fasi diverse e accavallate, a dissolvenza incrociata. Il dissolvere esplicita un annullamento/superamento/sublimazione della fisicità e dell'oggettività. Questo tipo di rappresentazione è diventata talmente standardizzata da non esprimere ormai più nulla di creativo. Meglio per certi versi, non mostrare affatto come nel cinema d'un tempo, piuttosto che mostrare una sorta di clip obbligato e replicante in cui i personaggi si spersonalizzano. Il consiglio è dunque di evitare situazioni e modi di rappresentazione che l'uso costante e ripetuto ha reso banali. Un rapporto sessuale e amoroso ha sempre in sè qualcosa di "eccezionale" ed "elettivo" che la riproposizione standardizzata finisce per uccidere. Altra situazione ormai talmente standardizzata da non offrire più alcuna sorpresa al pubblico, è la rappresentazione di un rapporto particolarmente passionale, attraverso la solita carrellata di indumenti frettolosamente abbandonati sul pavimento. Davvero non la si riesce più a vedere, non solo per la noia, ma anche perchè non c'è nulla di meno appassionante dell'abitudine. Se dobbiamo raccontare una passione travolgente, la cosa peggiore che possiamo fare è mostrarla con uno stile di racconto consueto.
E' sbagliato per uno sceneggiatore e ancor di più per un regista appoggiarsi esclusivamente ad elementi di "codice" senza averli verificati criticamente. I codici hanno una storia. Vanno riscritti a seconda della propria sensibilità e delle "ricadute" sulla mutata sensibilità del pubblico. Nell'affrontare queste "situazioni obbligate", in questo caso applicate agli ambienti di vita quotidiana che ci troviamo a dover descrivere nel corso di una storia, dobbiamo imparare a distinguere tra elementi simbolici strutturali non transeunti (ad esempio il senso simbolico della "camera da letto" che ha mantenuto nei secoli, a partire dalle arti figurative, delle sue costanti di senso) e stili narrativi profondamente segnati dalla mentalità e dagli usi di una certa epoca e non meccanicamente trasferibili, nè adatti per raccontare l'attuale e/o il nuovo. Il cinema non è solo quel certo film che state scrivendo, è anche l'insieme dei film. Una sequenza troppo riprodotta, uno stile troppo consueto, una scansione consuetudinaria dei tempi e delle azioni, una scalettatura troppo evidente degli eventi, può essere d'ostacolo alla specificità e all'originalità della vostra narrazione, rendendola indistinguibile dalle altre, dunque banale e inespressiva.
In conclusione: la camera da letto è un ambiente che unisce socialità e intimità. Questo non è un elemento passeggero, ma permanente, è un dato simbolico imprescindibile. Il cosa vi avviene e il come esprimerlo va invece definito sulla base della vostra storia, dei vostri personaggi, del contenuto espressivo e "di senso" che intendete rimarcare, non è copiabile ed espropriabile se non a prezzo di degradare la vostra narrazione a stile corrente (e corrivo) e il vostro presunto "autorismo" a superficialità. E' importante comprendere questo punto, proprio perchè troppo spesso si tende a fare il contrario e cioè a considerare transeunte e accessorio (se non a ignorare del tutto) il significato simbolico specifico di alcuni ambienti, e a considerare invece permanente cioè che è passeggero e datato, cioè il modo in certe fasi prevalente di raccontare una situazione.
LEZIONE XXXIX di Gianfranco Manfredi
 Il copione teatrale, fin dal teatro classico antico, è diviso in Atti. E ciascun Atto è suddiviso in Scene. A differenza dalla sceneggiatura cinematografica, dove le Scene in genere prevedono scenografie/ambienti diversi (cioè si cambia scena quando si cambia ambiente), quelle teatrali sono suddivisioni di comodo che identificano differenti entrate in scena, cioè attori diversi che si alternano nello stesso ambiente (cioè si cambia scena quando si cambiano attori). Per secoli in Teatro, la descrizione della scena nel testo è stata quanto mai sommaria, limitandosi ad indicare il luogo d'ambientazione per il quale si lasciava massima discrezionalità allo scenografo. Le cose cambiano sostanzialmente a cavallo tra la fine dell'ottocento e l'inizio del secolo scorso. Prendiamo ad esempio un copione del Grand Guignol (teatro parigino che cominciò le sue rappresentazioni nel 1897). Sabotaggio ( atto unico di Charles Hellem, W.Valcros e Pol d'Estroc. La citazione è tratta dall'antologia a cura di Corrado Augias Teatro del Grand Guignol, Einaudi 1972).
Il copione teatrale, fin dal teatro classico antico, è diviso in Atti. E ciascun Atto è suddiviso in Scene. A differenza dalla sceneggiatura cinematografica, dove le Scene in genere prevedono scenografie/ambienti diversi (cioè si cambia scena quando si cambia ambiente), quelle teatrali sono suddivisioni di comodo che identificano differenti entrate in scena, cioè attori diversi che si alternano nello stesso ambiente (cioè si cambia scena quando si cambiano attori). Per secoli in Teatro, la descrizione della scena nel testo è stata quanto mai sommaria, limitandosi ad indicare il luogo d'ambientazione per il quale si lasciava massima discrezionalità allo scenografo. Le cose cambiano sostanzialmente a cavallo tra la fine dell'ottocento e l'inizio del secolo scorso. Prendiamo ad esempio un copione del Grand Guignol (teatro parigino che cominciò le sue rappresentazioni nel 1897). Sabotaggio ( atto unico di Charles Hellem, W.Valcros e Pol d'Estroc. La citazione è tratta dall'antologia a cura di Corrado Augias Teatro del Grand Guignol, Einaudi 1972).
Una sala da pranzo modesta in una famiglia di operai. A sinistra: in primo piano, una finestra. In secondo piano, un lettino da bambini, collocato parallelamente alla scena con le tendine appese a un'asta di ferro che parte dal letto. Grazie a queste tendine, il pubblico non può vedere l'interno in cui si suppone sia coricato il piccolo Jeannot. La testata del letto tocca il fondo della scena. Al fondo. In mezzo, una porta che dà su un vestibolo il quale, a destra, porta all'uscita dell'appartamento sul pianerottolo. Il vestibolo si presume dia accesso, a sinistra, a una camera.
Il copione teatrale, fin dal teatro classico antico, è diviso in Atti. E ciascun Atto è suddiviso in Scene. A differenza dalla sceneggiatura cinematografica, dove le Scene in genere prevedono scenografie/ambienti diversi (cioè si cambia scena quando si cambia ambiente), quelle teatrali sono suddivisioni di comodo che identificano differenti entrate in scena, cioè attori diversi che si alternano nello stesso ambiente (cioè si cambia scena quando si cambiano attori). Per secoli in Teatro, la descrizione della scena nel testo è stata quanto mai sommaria, limitandosi ad indicare il luogo d'ambientazione per il quale si lasciava massima discrezionalità allo scenografo. Le cose cambiano sostanzialmente a cavallo tra la fine dell'ottocento e l'inizio del secolo scorso. Prendiamo ad esempio un copione del Grand Guignol (teatro parigino che cominciò le sue rappresentazioni nel 1897). Sabotaggio ( atto unico di Charles Hellem, W.Valcros e Pol d'Estroc. La citazione è tratta dall'antologia a cura di Corrado Augias Teatro del Grand Guignol, Einaudi 1972).
Una sala da pranzo modesta in una famiglia di operai. A sinistra: in primo piano, una finestra. In secondo piano, un lettino da bambini, collocato parallelamente alla scena con le tendine appese a un'asta di ferro che parte dal letto. Grazie a queste tendine, il pubblico non può vedere l'interno in cui si suppone sia coricato il piccolo Jeannot. La testata del letto tocca il fondo della scena. Al fondo. In mezzo, una porta che dà su un vestibolo il quale, a destra, porta all'uscita dell'appartamento sul pianerottolo. Il vestibolo si presume dia accesso, a sinistra, a una camera. Tra la porta e il letto un tavolinetto rotondo; sopra, alcune boccette di medicine, una caraffa, un bicchiere, un cucchiaino. Tra la porta e l'angolo della scena, a destra, una credenza a due corpi da sala da pranzo. A destra: una porta che comunica con la cucina. Qualche quadro, oleografie o fotografie alle pareti. Verso il centro della scena un tavolo da sala da pranzo. Tre o quattro sedie. La stanza è illuminata da una lampada elettrica con paralume, appesa al soffitto, al centro, con un filo che si avvolge lungo un contrappeso di maiolica bianca, di modello corrente. Sono le nove di sera, in autunno. Fuori, notte fonda. L'azione si svolge verso il 1900 nella periferia di una grande città, in Francia.
 Come mai una descrizione così minuta? Perchè ciascuno dei dettagli indicati servirà nel corso dell'azione scenica. Cioè mobili (e loro disposizione) , arredi, singoli oggetti entrano a far parte della narrazione. Il Grand Guignol inoltre, essendo un teatro dell'orrore, si avvale di effetti speciali che richiedono attrezzature particolari incluse negli elementi scenici (la sottolineatura del lampadario serve perchè poi si verificherà un black out).
Come mai una descrizione così minuta? Perchè ciascuno dei dettagli indicati servirà nel corso dell'azione scenica. Cioè mobili (e loro disposizione) , arredi, singoli oggetti entrano a far parte della narrazione. Il Grand Guignol inoltre, essendo un teatro dell'orrore, si avvale di effetti speciali che richiedono attrezzature particolari incluse negli elementi scenici (la sottolineatura del lampadario serve perchè poi si verificherà un black out).
Questo sviluppo del copione teatrale (che include anche una precisa descrizione dei movimenti degli attori nell'ambiente, al di là delle indicazioni espressive), chiarisce come tra il Teatro e il neonato Cinema cominci a stabilirsi un rapporto molto stretto.
Nulla dev'essere lasciato al caso perchè tutto, dal tipo e dalla disposizione dei mobili alla collocazione dei punti luce, diventa parte integrante della narrazione. L'ambiente non è più una scena generica o un fondale dipinto in cui avvengono azioni tra attori. L'ambiente è esso stesso personaggio e gli attori interagiscono con esso, quanto con gli altri altri attori.
Confrontiamo la descrizione di Sabotaggio, con quella della sceneggiatura del film Son of Frankenstein di Willis Cooper (1938).
Salone. E' una stanza con alti soffitti a volta, situata nella parte centrale del castello. La pareti sono in pietra e coperte da una tappezzeria visibilmente vetusta. Bandiere con stemmi araldici sono appese alle travi a soffitto. Lungo le pareti, alte finestre e sul lato più lontano della stanza, un grande camino in cui arde un grosso ciocco. Tappeti di pelle d'orso e di capra sul pavimento di pietra, e sedie antiche, divani e divanetti piazzati qua e là per la stanza; alcuni mobili sono ancora coperti di lenzuola anti-polvere. Luci elettriche brillano in applique di bronzo a parete, e ci sono lampade su uno o due tavoli. Davanti al camino, due comode poltrone, con un tavolino fornito di lampada. Sul camino, un ritratto a grandezza naturale del primo Barone Frankenstein, proprio quello che creò il mostro.
Queste descrizioni non sono "testo per il pubblico", in quanto al pubblico basta vedere l'ambiente. Sono un testo per gli addetti ai lavori, gli scenografi, nel caso.
 Nella sceneggiatura cinematografica questo sotto-testo invisibile al pubblico è fondamentale. I reparti devono sapere cosa è necessario avere in scena. Dove possono essere liberi nel dare una propria interpretazione e dove invece sono vincolati perché gli elementi prescritti servono alla narrazione.
Nella sceneggiatura cinematografica questo sotto-testo invisibile al pubblico è fondamentale. I reparti devono sapere cosa è necessario avere in scena. Dove possono essere liberi nel dare una propria interpretazione e dove invece sono vincolati perché gli elementi prescritti servono alla narrazione.
Mi è capitato di leggere un copione per una situation comedy scritto da Umberto Simonetta, che oltre che romanziere e autore di teatro, fu uno dei più brillanti autori televisivi italiani. In Italia, spesso le persone geniali e anti-conformiste si prendono in sceneggiatura delle libertà ignote al mondo dei professionisti americani, usando a volte, quando si rivolgono ai reparti, uno stile discorsivo. Nel caso, Simonetta doveva semplicemente indicare che il tal personaggio tornava a casa da un viaggio esotico.
L'epoca era precedente a quella delle anonime Samsonite o delle borse a ruote ormai talmente standardizzate che in aereoporto al ritiro bagagli capita di tirarne giù quattro prima di capire quale sia la tua. Allora, chi tornava da un viaggio, spesso aveva appiccicate alla valigia etichette-cartoline multicolori del posto in cui era stato. Dunque, presentare un personaggio con valigia così etichettata, di per sè, faceva già capire visivamente che era stato in vacanza in qualche posto turistico senza doverlo necessariamente precisare nel dialogo. In questo caso, uno sceneggiatore scrive: Tizio entra con una valigia etichettata. Simonetta si prendeva il divertimento di precisare:
una o due etichette, non fatemelo entrare con una valigia cosparsa di etichette, non è un rappresentante, non ha fatto il giro del mondo in ottanta giorni, non è un collezionista di etichette kitsch eccetera. Conoscendo i vizi e i possibili errori dei reparti, metteva insomma le mani avanti. Di tutto questo testo (molto più spassoso di come lo abbia riassunto io a memoria) il pubblico non sa nulla, perchè è appunto rivolto esclusivamente ai reparti. Questo testo serve a chiarire bene: 1. cosa è essenziale sotto il profilo del racconto visivo; 2. cosa non deve esserci, ad evitare travisamenti.
Mi è capitato invece di leggere una sceneggiatura di fumetti in cui l'autore, spiegando al disegnatore cosa avrebbe dovuto o potuto esserci in una singola vignetta, si dilungava per un'intera pagina accumulando indicazioni d'ambiente e di oggetti che mai sarebbero potuti entrare tutti insieme in una sola vignetta. Leggevo perplesso chiedendomi che senso avesse dilungarsi tanto. Alla fine, nell'ultima riga, l'autore scriveva: Ti ho messo un po' di cose, scegli tu. Ecco, questa è la cosa da evitare assolutamente. Lo sceneggiatore deve avere in testa delle scelte chiare, precisare cosa deve esserci per forza, lasciare sul vago quello che è e deve restare vago (nel testo del Grand Guignol citato, si dice ad esempio verso il 1900, alla periferia di una grande città, in Francia, il che significa che vanno evitate cose che possano invece identificare la città- ad esempio un monumento noto oltre la finestra- e l'anno preciso - ad esempio un calendario vistoso).
In una sceneggiatura, queste indicazioni non sono descrittive e d'atmosfera come sarebbero in un romanzo. Sono puramente e semplicemente utili. Devono essere scritte in un linguaggio scarno, semplice, diretto ed inequivocabile. Non sono testi per cui lo scrittore venga giudicato stilisticamente. Anzi quando uno sceneggiatore cinematografico si prende delle libertà stilistiche para-letterarie, spesso risulta fastidioso e ridicolo. I reparti vogliono sapere qual è il fabbisogno. Non gliene importa niente di un'alata descrizione. Un regista non si sente più ispirato se legge in
sceneggiatura una descrizione simil-poetica di un pomeriggio autunnale, non valuta lo sceneggiatore come un bravo scrittore, semplicemente si chiede : ma io, come la giro, questa roba? E un attore si chiede: io cosa dico? cosa faccio? Dunque, siate chiari e stringati. Un para-testo non lo si scrive per fare bella figura.
Ma torniamo alle descrizioni d'ambiente. Molta confusione che si fa nella conversazione comune tra "sceneggiatore" e "scenografo" nasce in realtà da un dato storico: in cinema e in teatro, gli ambienti si descrivono a parole prima d'essere disegnati o arredati. E le prime indicazioni minutamente dettagliate, in teatro, sono quelle rivolte allo scenografo. L'indicazione/descrizione della scena in quanto ambiente, ripeto: nei suoi elementi necessari alla narrazione (non voglio sapere dove sono situate le prese elettriche se questo non è un dettaglio utile al racconto), è parte integrante e necessaria del testo "sceneggiatura".
Lo è, per chi scrive, anche prima di mettersi a raccontare la scena vera e propria (cioè quello che accade). Io devo figurarmi l'ambiente in cui si muovono i personaggi, per poter sfruttare le occasioni narrative che ne derivano. Devo pensare prima anche quali oggetti possono tornarmi utili in scena. In fumetto può accadere, lo avrete visto un'infinità di volte, ad esempio questo: un cowboy smonta da cavallo e corre a rifugiarsi in un anfratto per sfuggire a un agguato. Poi risponde al fuoco con un fucile che non aveva in mano quando è sceso da cavallo. Cosa è successo? Lo sceneggiatore si è dimenticato di indicare (perchè non ci aveva pensato) che il cowboy scendeva da cavallo col fucile in mano e dunque il disegnatore non l'ha disegnato. Poi quando il fucile serviva, lo sceneggiatore ha scritto che il tipo spara col fucile. Risultato ? Il fucile appare magicamente. A me personalmente è capitato di scrivere in un fumetto che nella tal stanza c'era un camino. Dunque nel totale si vede il camino. Poche vignette più in là, l'eroe impugna un attizzatoio. Presumevo ovvio che scrivendo:
nella stanza c'è un camino, al disegnatore sarebbe stato chiaro che oltre al camino doveva disegnare (nel totale) anche gli attrezzi. Invece il disegnatore ha disegnato soltanto il camino. L'attizzatoio, anche in questo caso, è comparso magicamente nelle mani dell'eroe. Cautela vuole dunque che se avete pensato di piazzare un camino in un ambiente perchè quello che vi serve nell'azione non è il camino in sè, ma l'attizzatoio, precisiate anche ciò che parrebbe ovvio (e che in un romanzo si tralascerebbe) e cioè che accanto al camino ci sono gli attrezzi. Il problema non è che i reparti (o i disegnatori) siano scemi. Non lo sono affatto, anzi sono quasi sempre degli eccellenti professionisti. Il problema è che un para-testo nudamente descrittivo, non lo si legge con l'attenzione che si presta ad un dialogo o a una descrizione poetica o letteraria, lo si legge (giustamente) come una lista della spesa. In una lista della spesa non si dà e non si deve dare per scontato niente. Quello che non c'è scritto, non lo si acquista.
D'altra parte, insisto, se io mi metto a descrivere qualsasi cosa, anche le cose non necessarie, semplicemente perché mi sono venute in testa e sono di mio gusto, ma non fanno narrazione, un poveretto che legge questo testo non sa più distinguere cosa dev'essere in scena da cosa potrebbe esserci, ma non è affatto indispensabile. Il risultato è che non presta più attenzione a nulla e fa di testa sua. Non date mai dello scemo a nessuno. Se le vostre indicazioni di sceneggiatura non vengono comprese è perchè avete sbagliato voi a scriverle.
Certo può capitare che una certa idea venga scrivendo. Cioè che nel corso di una scena vi rendiate conto che vi sarebbe utile un dato oggetto. In questo caso tornate indietro, cioè al momento in cui avete descritto la scena e precisate che ci vuole quel dato oggetto. Un professionista fa "lo spoglio" scena per scena dunque in genere in cinema ci si accorge sempre se un oggetto dev'essere sul set, però è più comodo per i reparti se le indicazioni vengono raggruppate al principio, non disseminate lungo la scena, altrimenti qualcuna può andare perduta. Una persona dei reparti non è un lettore nel senso pieno del termine. Quando legge la sceneggiatura , può anche prescindere ad esempio dai dialoghi. Si concentra su quello che gli serve sapere. Se dunque in un dialogo scrivete: passami quel posacenere, la cosa può risultare inavvertita a chi sul set deve procurare quel posacenere. Dunque dovete scrivere in testa, tra le altre indicazioni, che nel tal posto c'è un posacenere. Questo vale anche per gli attori. Non tutti gli attori che compaiono in un film leggono l'intera sceneggiatura. A quelli che hanno un numero limitato di "pose" si danno soltanto le pagine relative al proprio personaggio. Si può in sostanza recitare in un film senza conoscere (se non per sommi capi) la storia narrata dal film. Ciò significa che ogni scena dev'essere estremamente chiara di per sè, alla lettura. L'attore in questione deve comprendere cosa deve fare e dire nelle scene in cui compare. Se ha esigenza di sapere dove sono collocate narrativamente le sue scene può chiedere spiegazioni al regista, ma nessun regista starà a perdere tempo raccontandogli l'intero film, si limiterà a indicargli come interpretare quella scena lì in modo che leghi con le altre. Faccio un esempio, tratto sempre dalla sceneggiatura di Son of Frankenstein.
Wolf e Elise, in piedi nell'anticamera del salone principale, si tolgono i soprabiti mentre Fritz, il maggiordomo entra con i bagagli. Il suo abito è inzuppato di pioggia.
Una precisazione del genere sarebbe superflua in un romanzo. Nella scena immediatamente precedente, pioveva, e avevamo visto Fritz prelevare i bagagli dall'automobile degli ospiti. Dunque è ovvio che Fritz si sarà bagnato il vestito. Ma in cinema, questa scena in interno può venire girata giorni dopo o anche prima della scena precedente all'esterno, con pioggia. Certo, l'assistente alla regia ha proprio il compito di assicurarsi che le diverse scene combacino, però è sempre meglio scrivere che il maggiordomo è bagnato, perchè l'assistente potrebbe dimenticarsene, e comunque chi si occupa dell'attore dove provvedere a bagnarlo, e deve saperlo quel giorno lì che si gira la scena. Per l'attore che interpreta Fritz, poi, un conto è entrare in scena sfuggendo a un temporale, un altro è entrare impeccabile. Questo deve stare scritto in sceneggiatura, altrimenti il set diventa un inferno. Non si possono chiedere delucidazioni ad ogni momento e improvvisare di continuo. Bisogna sapere tutto prima. Sul set si approfondisce, si cercano le sfumature, ma i fondamentali devono essere chiari su carta.
Tenete dunque presente che la sceneggiatura è una forma di scrittura composita. Il vostro racconto generale, certo, si rivolge al pubblico. La vostra scrittura, in pratica, si rivolge al regista (quello con cui dovreste avere fin dal principio una condivisione del racconto generale e se possibile anche qualche condivisione di gusto ed estetica), agli attori (e delle loro esigenze si è parlato diffusamente in altre lezioni), allo scenografo, al costumista, e in alcuni casi (quando è necessario indicare certi movimenti di macchina) all'operatore e ai macchinisti, insomma ai reparti. E ciascuno di questi lettori è un lettore molto particolare che si concentra su quello che gli compete. Voi avete di fronte dei lettori di frammenti, non dei lettori della storia. E avete di fronte dei lettori che lavorano al film che poi il pubblico vedrà, cioè dei lettori che non sono pubblico, ma collaboratori che raccontano insieme a voi, "mettendo in scena".
Lezione Lxii - La Forma Della Sceneggiatura (i) - di Gianfranco Manfredi
 Gli studiosi della cultura greca considerano l’Iliade di Omero come il primo testo scritto destinato al teatro. Trattandosi di un poema, è dunque evidente che siamo di fronte a una pura declamazione di un testo in scena, cioè a un teatro di parola, non a una vera e propria messa in scena. L'attore è unico, cui si alternano a volte il coro e/o degli intermezzi musicali. Il teatro nasce dunque in forma di monologo. Il che fa giustizia del luogo comune secondo cui il monologo, l'one man show, le letture dantesche o di altri classici, il cosiddetto teatro-canzone, siano forme teatrali innovative. E' vero l'esatto contrario: rappresentano l'anno zero del teatro. Non c'è scena, non c'è dialogo, non c'è molteplicità di attori, non c'è azione. La pura lettura/recitazione in scena non costituiscono un'autentica drammaturgia, ne sono al massimo l'infanzia.
Gli studiosi della cultura greca considerano l’Iliade di Omero come il primo testo scritto destinato al teatro. Trattandosi di un poema, è dunque evidente che siamo di fronte a una pura declamazione di un testo in scena, cioè a un teatro di parola, non a una vera e propria messa in scena. L'attore è unico, cui si alternano a volte il coro e/o degli intermezzi musicali. Il teatro nasce dunque in forma di monologo. Il che fa giustizia del luogo comune secondo cui il monologo, l'one man show, le letture dantesche o di altri classici, il cosiddetto teatro-canzone, siano forme teatrali innovative. E' vero l'esatto contrario: rappresentano l'anno zero del teatro. Non c'è scena, non c'è dialogo, non c'è molteplicità di attori, non c'è azione. La pura lettura/recitazione in scena non costituiscono un'autentica drammaturgia, ne sono al massimo l'infanzia.
Aristotele ricorda che fu Eschilo a portare a due il numero degli attori e dunque a inventare il dialogo. Successivamente, con Sofolcle, i personaggi diventarono tre e la scena più ricca. Le prime testimonianze di drammaturgia risalgono, secondo Aristotele, al VI sec. a.C. , prima non esistevano che spettacoli pre-narrativi di istrioni che venivano chiamati in modo diverso a seconda delle regioni in cui si esibivano: mimi, virtuosi, improvvisatori, burloni o dilettanti (nel senso che procuravano diletto). Si trattava di attori nomadi che intrattenevano il pubblico dei villaggi e dei borghi con lazzi e buffonagini, piccole scenette realistiche, azioni mimiche, caratterizzazioni burlesche di personaggi (l'atleta millantatore, lo spacciatore di intrugli miracolosi, il ladro di frutta, insomma "macchiette"). Le esibizioni buffonesche di Susarione ad Atene, non raccontavano una storia compiuta, erano rappresentazioni senza capo né coda.
 Gli studiosi della cultura greca considerano l’Iliade di Omero come il primo testo scritto destinato al teatro. Trattandosi di un poema, è dunque evidente che siamo di fronte a una pura declamazione di un testo in scena, cioè a un teatro di parola, non a una vera e propria messa in scena. L'attore è unico, cui si alternano a volte il coro e/o degli intermezzi musicali. Il teatro nasce dunque in forma di monologo. Il che fa giustizia del luogo comune secondo cui il monologo, l'one man show, le letture dantesche o di altri classici, il cosiddetto teatro-canzone, siano forme teatrali innovative. E' vero l'esatto contrario: rappresentano l'anno zero del teatro. Non c'è scena, non c'è dialogo, non c'è molteplicità di attori, non c'è azione. La pura lettura/recitazione in scena non costituiscono un'autentica drammaturgia, ne sono al massimo l'infanzia.
Gli studiosi della cultura greca considerano l’Iliade di Omero come il primo testo scritto destinato al teatro. Trattandosi di un poema, è dunque evidente che siamo di fronte a una pura declamazione di un testo in scena, cioè a un teatro di parola, non a una vera e propria messa in scena. L'attore è unico, cui si alternano a volte il coro e/o degli intermezzi musicali. Il teatro nasce dunque in forma di monologo. Il che fa giustizia del luogo comune secondo cui il monologo, l'one man show, le letture dantesche o di altri classici, il cosiddetto teatro-canzone, siano forme teatrali innovative. E' vero l'esatto contrario: rappresentano l'anno zero del teatro. Non c'è scena, non c'è dialogo, non c'è molteplicità di attori, non c'è azione. La pura lettura/recitazione in scena non costituiscono un'autentica drammaturgia, ne sono al massimo l'infanzia.
Aristotele ricorda che fu Eschilo a portare a due il numero degli attori e dunque a inventare il dialogo. Successivamente, con Sofolcle, i personaggi diventarono tre e la scena più ricca. Le prime testimonianze di drammaturgia risalgono, secondo Aristotele, al VI sec. a.C. , prima non esistevano che spettacoli pre-narrativi di istrioni che venivano chiamati in modo diverso a seconda delle regioni in cui si esibivano: mimi, virtuosi, improvvisatori, burloni o dilettanti (nel senso che procuravano diletto). Si trattava di attori nomadi che intrattenevano il pubblico dei villaggi e dei borghi con lazzi e buffonagini, piccole scenette realistiche, azioni mimiche, caratterizzazioni burlesche di personaggi (l'atleta millantatore, lo spacciatore di intrugli miracolosi, il ladro di frutta, insomma "macchiette"). Le esibizioni buffonesche di Susarione ad Atene, non raccontavano una storia compiuta, erano rappresentazioni senza capo né coda.
Pulcinella viene da questa tradizione di commedia di piazza, senza strutture, senza narrazione in senso proprio, una successione di "numeri" e di "gag" come diremmo oggi, che ebbe una grande importanza nel fissare una serie di tipi (maschere) e di situazioni divertenti. Questo genere di teatro, con fini più di intrattenimento che artistico, sopravvisse, anche quando la drammaturgia teatrale vera e propria si era codificata da secoli. Non c'era un vero e proprio copione, ma una semplice traccia, un canovaccio a volte davvero minimo, come nella seguente scenetta che così Nicoletta Capozza nel suo Tutti i lazzi della Commedia dell'Arte (Dino Audino Editore, 2006) traduce in lingaggio moderno: Pulcinella va a comprare un vaso da notte per il padrone. Coviello gli dice che mettendoselo in testa potrà conoscere i fatti di chiunque. Pulcinella mette la testa nel vaso da notte. Coviello fa lazzi, poi gli fa lo sgambetto e fugge. Pulcinella cade, fa lazzi ed esce di scena.
Il breve testo, come si vede, indica : (1) i personaggi in scena, (2) il percorso degli eventi dal principio alla fine e (3) le occasioni comiche. Dialoghi e lazzi (cioè gags) sono lasciati all'invenzione dei commedianti.
Commenta Nicoletta Capozza: "Il comico crea continuamente, non ha mai niente di già totalmente dato, la sua improvvisazione, benché fondata sulla perfetta conoscenza del tipo, è comunque messa in discussione ogni volta, perchè ogni volta diverse sono le modalità entro le quali si trova ad agire."
Questo modello è ancora attuale? Ne abbiamo già accennato nella lezione sul comico.
Vincenzo Cerami autore di parecchie sceneggiature per Benigni, ha diverse volte puntualizzato che il suo lavoro consiste principalmente nel fornire situazioni sulla base delle quali il comico possa scatenare la sua verve creativa. Ha detto anche che si tratta inoltre di fissare dei "binari", dunque dei limiti, e su questo punto torneremo in seguito. Per il momento concludiamo che il lavoro dello sceneggiatore, come quello degli autori dei mini-soggetti e dei canovacci per le rappresentazioni della Commedia dell'Arte, è nel genere comico, da un lato di offrire delle opportunità stabilendo una situazione di base di per sé divertente, dall'altro di fissare dei limiti perché l'improvvisazione non finisca totalmente fuori tracciato, non produca a sua volta situazioni che da gag diventino narrative, cioè sconfinino in derivazioni che poi richiederebbero ulteriori sviluppi e dunque non consentirebbero una "chiusura".
Esaminiamo ora la forma di un testo compiuto. Lo Ione di Euripide. Non mi soffermo sulla vicenda, piuttosto complessa, nè sullo stile che unisce tragedia e commedia fino alla parodia più dissacrante, accompagnandola con musiche e numeri di danza. In quest'ultima sezione del corso, infatti mi limiterò a considerare la pura forma del testo.
Il testo dello Ione elenca anzitutto i personaggi (soltanto i nomi, senza ulteriori indicazioni). Poi definisce la scena con una sintetica didascalia: La scena in Delfi. In fondo, il tempio di Apollo, davanti al tempio un altare e varie stele. Il frontone del tempio è ornato di bassorilievi. Da un lato un boschetto di lauri.
Nel testo, in alternanza ai dialoghi e ai cori (prima, durante e dopo), compaiono succinte indicazioni utili alla messa in scena e alle azioni rappresentate.
Entra Ione seguito da alcuni ministri del tempio. Indossa belle vesti, porta sulla spalla un arco, e stringe una frasca d'alloro ornata di bende, che gli serve a spazzare l'adito sacro del tempio.
Ci sono, a inframezzare la recitazione verbale, notazioni volte a chiarire a chi sta parlando Ione (ai ministri) e alle sue azioni (Dà di mano alla frasca d'alloro; depone la frasca d'alloro, prende un'anfora d'oro e versa acqua sul pavimento; come colpito da un rumore improvviso, alza gli occhi verso il cielo; dà di mano all'arco e allefrecce).
Come potete vedere, si comincia a delineare la forma della Sceneggiatura:
1. Dove è ambientata la scena e come è strutturata.
2. Chi entra in scena (e in seguito chi ne esce).
3. Come è vestito il protagonista e di quali attrezzi è dotato.
4. Quali azioni essenziali compie il protagonista (a chi si rivolge, quali gesti compie, come usa gli oggetti che porta con sé).
Si precisano queste cose non soltanto per chiarezza narrativa (nei confronti del pubblico), ma anche per prescriverle ai reparti (scenografia, costumi, attrezzeria) e all'interprete (ciò che dice acquista maggior senso attraverso i gesti che compie e il suo atteggiamento). Si scrive ciò che deve esserci, non ciò che potrebbe esserci. Non si esclude affatto che la scena, i costumi, il movimento in scena, possano essere arricchite, ma si sottolinea ciò che è obbligato, per motivi di natura narrativa.
Noterete in particolare un dettaglio prezioso: se si mette qualcosa addosso o in mano a un personaggio non è per un vezzo gratuito, ma perchè la userà nel corso della scena. Il testo precisa come e quando.
Si tratta insomma di indicazioni vincolanti, ma sommarie. Si evita di scendere in dettagli minuti. Si dice che Ione ha belle vesti, ma non le si descrivono, per tipo, colore o altro, come si farebbe in un romanzo. Si dice che sparge acqua a terra, da un'anfora d'oro (il che comporta e spiega la sacralità del gesto) ma non si dice se lo fa di getto o un po' per volta, se lo fa prima di parlare o mentre parla, e non si dice quando deve finire e posare l'anfora (questo è intuibile e ovvio e non richiede d'essere puntualizzato). Dunque in parte si precisa e in parte si lascia alla libera interpretazione.
Inoltre non si scrive, perchè sarebbe superfluo, quanto è chiaramente intuibile.
Questo è un utile insegnamento anche a riguardo del lavoro letterario. In un romanzo può essere caratterizzante precisare dei gesti o delle azioni di un personaggio nel corso di un dialogo, ma questo non vuol dire che se prende in mano un bicchiere di vino e lo sorseggia mentre parla, poi si debba per forza specificare che a un certo punto lo posa. Se in seguito il personaggio ha le mani occupate da qualche altro oggetto, è di per sè evidente che avrà posato il bicchiere. Non accumulate indicazioni ovvie, lasciate spazio all'intuitività del lettore.
La moderna sceneggiatura cinematografica si fonda ancora su questa antica misura. Nelle didascalie (cioè nelle descrizioni) si sottolineano le cose essenziali. Si prescrive soltanto ciò che è indispensabile e funzionale al racconto.
Nella commedia e nel teatro comico sono in genere più numerose le indicazioni rivolte all'attore. Aristofane, ad esempio, nella commedia Gli Acarnesi, indica in testa o in corso di dialogo: monologa tragicamente; con piglio oratorio; gridando; con voce e piglio da spaccamontagne; si stuzzica la gola con la penna; feroce. Insomma indica toni e intenzioni, suggerisce gesti significativi che caratterizzano quel certo personaggio in quel momento.
L'alternanza dei toni è fondamentale in una commedia. L'attore va aiutato a capire (la garanzia che capisca da solo non c'è) che una certa battuta va detta ironicamente, un'altra in tono irato, un'altra ancora sbraitando. Sono, come noterete, indicazioni di mutamenti improvvisi di tono e d'umore, cioé di eccessi. In una tragedia rincorrere gli eccessi è caratteristica degli attori cani, in commedia invece è fondamento della recitazione. Un attore drammatico (che rappresenta di solito, come ho segnalato nella relativa lezione, un personaggio "elevato") deve guardarsi dal diventare enfatico, un commediante (che rappresenta in genere un "uomo comune") deve invece guardarsi dall'apparire qualsiasi.
Le segnalazioni per l'attore dunque hanno lo scopo precipuo di fornirgli i "binari" di cui abbiamo parlato, cioé dei limiti entro cui muoversi, nella sua interpretazione. Il personaggio eroico deve contenersi, per non assumere caratteristiche da trombone che lo renderebbero retorico o addirittura ridicolo. Se dunque non precisiamo niente, vuol dire che non richiediamo di accentuare. Il personaggio comune caratteristico della commedia deve invece assecondare l'emotività, per non precipitare in un realismo triste e patetico. Sta all'attore trovare un equilibrio, la nostra segnalazione deve però essere precisa e inequivocabile. Sarebbe sbagliato scrivere: incazzato, ma non troppo.
O è incazzato o non lo è. Precisato che deve esserlo, starà all'attore cercare la misura giusta e più efficace.
Non scrivete mai quelle segnalazioni contraddittorie che sono tipiche della letteratura.
In letteratura, il lettore deve forgiarsi un'immagine mentale del personaggio.
Sottolinearne le contraddizioni può aiutare chi legge a non costruirsi un'immagine troppo unilaterale e definita che poi magari l'andamento della storia smentirebbe. Il personaggio di Harry Potter sulle pagine del romanzo è accortamente mantenuto abbastanza neutro, in modo che sia più semplice per i diversi lettori identificarsi con lui. In cinema si tratta invece di darne un'interpretazione che anzitutto è incarnata nel fisico dell'attore, ma che anche nell'andamento drammaturgico deve essere sempre coerente agli avvenimenti. Ciò che in un romanzo viene lasciato alla libera interpretazione del lettore, in cinema è consegnato all'interprete e al punto di vista di chi lo mette in scena e lo fa agire.
Ne consegue che il lavoro dello scrittore di romanzi, è molto diverso dal lavoro dello sceneggiatore. Il primo scrive per sollecitare il lettore a formarsi una propria immagine del personaggio, degli ambienti e delle situazioni; il secondo contribuisce a definire questa immagine, cioè deve sceglierne/suggerirne una tra le tante possibili. Il rapporto non è, come in romanzo, tra autore e pubblico. In un copione, tra l'autore del testo e il pubblico, ci sono dei tramiti: l'attore che interpreta il personaggio e chi mette in scena il testo.
Noi non dobbiamo descrivere l'attore, ma il personaggio, nei suoi tratti essenziali, e aiutare l'attore a comprenderlo passo passo, attraverso piccole ma precise indicazioni sui suoi gesti (funzionali e/o espressivi) e i suoi toni (esplicitare il tono, chiarisce il senso della battuta e il registro dell'interpretazione). Là dove la battuta è inequivocabile, come il tono con cui deve essere pronunciata, non c'è bisogno di precisare nulla. Non fate i professorini, perchè otterreste solo di irritare l'attore vincolandolo alla vostra interpretazione soggettiva, che è puramente teorica, non fisica. Non dilungatevi in spiegazioni psicologiche e motivazionali, perchè si presterebbero a interpretazioni molteplici e invece di chiarire confonderebbero.
La psicologia di un personaggio in un testo drammaturgico si deve capire da ciò che dice il personaggio, da come lo dice, e da ciò che il personaggio fa. L'attore va aiutato in corso di copione, non con delle complesse premesse dove spiegate il personaggio nei suoi tratti distintivi e nelle sue contraddizioni. Mettetelo in scena, il personaggio, e precisate quel che va precisato mentre lo fate agire.
Lo stesso vale per le indicazioni ai reparti e quelle di regia. Lo sceneggiatore rimarca l'indispensabile, ma deve guardarsi attentamente dal fornire indicazioni prescrittive sotto il profilo estetico, perchè questo lavoro non gli compete.
In conclusione: per assegnare dei limiti agli altri, dovete imparare a limitare voi stessi. In una buona sceneggiatura non si deve scrivere nulla di inutile, di puramente esornativo, nè tantomeno di controproducente, supponendo a torto che la messa in scena sia semplicemente un'esecuzione di una vostra idea puntigliosamente precisata fino allo sfinimento. Esagerare con le indicazioni porta a un unico risultato: verranno ignorate.
Lezione Lxi - Nascita E Fondamenti Del Copione Teatrale - di Gianfranco Manfredi
I GENERI: LA COMMEDIA
a) Le origini
Il Comos ( da cui si pensa origini la parola Commedia) era una Festa in onore di Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza. Il verbo comazein , in greco, significa infatti “far baldoria”. Aristotele osserva però, nella Poetica, che i Megaresi, presumibili creatori della Commedia, chiamavano i loro villaggi Comi. Secondo lui dunque la parola Commedia indica il fatto che queste rappresentazioni originavano dai villaggi, e passavano di villaggio in villaggio, mentre non erano tenute in gran conto nelle città. Aristotele considerava la Commedia anche come il genere teatrale più antico, o quanto meno, precedente alla Tragedia. Non trattandosi di rappresentazioni colte, ma estremamente popolari, furono meno documentate e dunque le loro caratteristiche originarie sono avvolte dal mistero. Paradossalmente questo mistero è stato accentuato dal fatto che i libri della Poetica di Aristotele dedicati all’analisi della Commedia, sono andati perduti. Tuttavia qualche traccia di questa analisi è accennata in alcuni passi della Poetica, per esempio nel capitolo II, dove Aristotele distingue tra rappresentazioni che hanno al loro centro personaggi migliori di noi (Tragedia) e personaggi ordinari, simili a noi, o addirittura inferiori (Commedia). Da un lato, cioè, il racconto delle Divinità , di uomini straordinari, Re, Eroi, individui eccezionalmente esemplari nel bene o nel male, dall’altro il racconto di personaggi come noi, dalla vita estremamente comune, tipi immediatamente riconoscibili in qualsiasi comunità , incarnazioni di ruoli quotidiani e famigliari. Questo non significa che in una commedia non possano apparire anche personaggi illustri, ma che questi personaggi vengono essi stessi rappresentati per i tratti che li rendono simili alle persone comuni. In particolare, ci interessano i loro vizi, le loro debolezze, le loro meschinità, le loro ridicolaggini , la loro “bruttezza” fisica e morale, più che le loro virtù, la loro forza, la loro grandezza, l’austerità e la serietà, la bellezza fisica e morale.
(In questa differenza d’origine, si può dunque anche leggere la fonte di quel pregiudizio secondo cui la rappresentazione tragico-drammatica sia più “elevata”, della Commedia e del Comico, tradizionalmente pensati come generi più “bassi”. Questo luogo comune estetico ha un’evidente origine “di classe” , nasce cioé dalla contrapposizione tra il pubblico aristocratico, colto ed elitario delle città e il pubblico popolare, ignorante, “volgare” delle campagne e dei villaggi. La Storia ha fatto giustizia di questo luogo comune, ma la Storia dei Premi Cinematografici ancora no: a tutt’oggi è molto più facile che venga premiato con l’Oscar un film drammatico che un film comico).
Nel suo saggio Il Teatro dalle origini ai nostri giorni (Universale Laterza, 1967) Léon Moussinac scrive:
“Il Comos delle feste rurali, così popolare, col suo corteo di personaggi seminudi e semiebbri, mostruosamente mascherati, dai gesti lubrichi, urlanti canzoni oscene e scagliando ingiurie, interruppe un giorno la sua sarabanda… si può immaginare il capo del corteo salire su un palchetto, togliersi la maschera e improvvisare davanti alla folla per dire il suo parere sui fatti politici.” Insomma, alle origini , nello spettacolo popolaresco, tutti i generi cosiddetti “minori” erano fusi: la farsa, l’orrore, il musicale, l’osceno, la satira di costume e politica.
(Sia detto per inciso: solo degli ignoranti possono sostenere che quando un comico si mette a parlare di politica uscendo dal suo ruolo di mero “buffone” allora non fa più satira, ma invettiva. L’invettiva è infatti parte costitutiva del ruolo del comico, fin dalle origini. Altra riflessione a margine: certi spettacoli contemporanei che tutti noi siamo portati a pensare come “nuovi” hanno in realtà un’origine antichissima: quando Moussinac cita lo “scagliare ingiurie”, si riferisce a una vera e propria gara (agon) di insulti, proprio come quella tra rapper cui assistiamo nel film 8 Mile (2002) con Eminem).
Uno dei più antichi, se non il più antico commediante di Atene fu Susarione. I suoi spettacoli erano senza capo né coda, una pura collezione di lazzi, buffonerie, scenette realistiche e mimiche. Da qui nacquero, ben prima di una narrazione sistematica e strutturata, i primi personaggi: un venditore di intrugli miracolosi (il cerretano) cioè il dottorone che coprendosi dietro un linguaggio pseudo-scientifico imbroglia le persone, il ladro di frutta ( prototipo del delinquente simpatico che ruba solo per sopravvivere), il goffo atleta millantatore di grandi imprese (prototipo del contaballe incallito, il classico Capitan Fracassa), il tipo che vuole apparire colto e pretende di usare un linguaggio forbito compiendo un’infinità di strafalcioni (come nella comicità di Nino Frassica o di Addolorata). E ancora: il Vecchietto (Pappos, cioè il nonno) di volta in volta arguto, rincoglionito, arzillo o invalido, ridicolo o arcigno. Lo Stupido, in tutte le varianti: dal “bietolone di mamma sua”, al nesci, cioè il finto stupido che finge di non vedere e non sentire, ma s’accorge di tutto. E poi: il Mangione, l’Ubriacone, il Pauroso (vittima anche di spaventi autentici, per esempio di fronte a serpenti mostruosi), il Dormiglione.
“ Da questa specie di monologhi-macchiette” scrive Ettore Romagnoli nella sua Prefazione alle Commedie di Aristofane (Zanichelli 1961) “ ebbe origine una specie di farsa che le notizie più tarde chiamano commedia di piazza.”
Se prima accadeva che tutti questi tratti burleschi potessero anche unirsi e sfumare l’uno nell’altro grazie all’interpretazione di un solo attore, con il diffondersi della Commedia di Piazza, gli attori raggruppandosi a recitare insieme furono portati ad esagerare ciascuno certe caratteristiche a contrasto con quelle altrui. Nacquero così i diversi ruoli. Le storie vere e proprie nascono dopo, da una codificazione dei Tipi.
Ho molto insistito in queste lezioni sul primato dei personaggi. E’ dalla creazione dei personaggi (e dei Tipi fondamentali) che prende forma il racconto vero e proprio. I personaggi non sono cioè derivati dalla vicenda, ma al contrario non c’è vicenda che non sia vicenda di personaggi. La definizione del personaggio e del suo carattere è preliminare al racconto.
b) I Ruoli nella Commedia
Aristofane è stato il primo a legare insieme in un’unica azione, i personaggi e i singoli elementi compositivi della Commedia in una struttura unitaria. Vediamo in breve un paio di trame.
Nelle Nuvole, Strepsiade, un contadino ossessionato dai debiti procuratigli da un figlio scansafatiche (Fidippide) che gioca alle corse dei cavalli, lo manda al Pensatoio (la scuola di Socrate) nella speranza di farne un ragazzo colto, educato e serio, formato a un ruolo sociale di assoluto riguardo e di sicuro avvenire (l’avvocato). Ma Fidippide adopera le tecniche retoriche di persuasione apprese alla scuola per umiliare il padre, non esitando nemmeno a picchiarlo, per poi infinocchiarlo convincendolo che questo suo comportamento è giusto: Fidippide in fondo non fa che restituire al padre le botte ricevute da piccolo .
In Lisistrata , le donne stanche di guerra, decidono uno sciopero del sesso nei confronti dei loro bellicosi mariti, per costringerli a fare la pace.
I temi civili e politici sono fondamentali nel teatro di Aristofane. I ruoli non sono semplicemente i Tipi Buffi, ma i ruoli famigliari e sociali (figlio/padre, mogli/mariti, allievi/insegnanti, colti/ignoranti) . Il “buffo”, ciò che rende Commedia la narrazione, sta nel capovolgimento dei ruoli abituali.
In questo modo la Commedia si forma come narrazione di un paradosso: da un lato si codificano i personaggi in ruoli ben differenziati e distinti, dall’altro i personaggi stessi finiscono per capovolgere i ruoli sociali, mostrandocene l’inconsistenza.
Il capovolgimento e lo scambio di ruoli giunge al suo apogeo con il teatro di Plauto, vero fondatore della “Commedia degli Equivoci”.
Nei Menecmi, due gemelli separati alla nascita si ritrovano da adulti nella stessa città e il fatto che siano identici all’aspetto, per quanto diversissimi di carattere, scatena una serie di equivoci. Su questa base Shakespeare scrisse la Commedia degli Errori e Goldoni I due gemelli veneziani.
Anche in Anfitrione, lo schiavo Sosia è al centro di una serie di scambi di “sembianze” .
Questo ruolo dello schiavo furbo che ricorrendo a tutti i trucchi possibili riesce a risolvere le difficili imprese assegnategli dal suo padrone, non senza procurarsene vantaggi personali, è molto presente in Plauto ed è una perfetta rappresentazione del carattere da Commedia (uomo comune) in contrapposizione al carattere da Tragedia (eroe e semidio). Possiamo leggerne l’eredità anche nel personaggio del Tenente Colombo: un umile funzionario di polizia, apparentemente rustico e ingenuo, in realtà astutissimo, che combatte (e vince) contro personaggi autorevoli, ricchi, famosi e socialmente protetti, cioè il rappresentante del Popolo contro quello del Potere.
I ruoli, il passaggio trasformistico tra i ruoli, la lotta tra i ruoli come manifestazione/metafora della più larga lotta sociale, è questo il tema dominante della Commedia.
c) La Commedia nel cinema
Un attore divorziato, per poter trascorrere del tempo con i figli, si finge un’anziana governante (Mrs.Doubtfire).
Due musicisti jazz braccati dai gangster, si travestono e riescono a trovare un impiego fuori città in un’orchestra di sole donne (A qualcuno piace caldo).
Un attore disoccupato si finge donna per recitare in una situation comedy che ha un ruolo femminile scoperto (Tootsie).
Una cantante da night assiste a un omicidio e la polizia per nasconderla la mescola alle suore di un convento (Sister Act).
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Tutte queste commedie cinematografiche si incentrano, come si vede, su uno scambio di ruoli e sul gioco degli equivoci. Anche la trama sembra la stessa: Sister Act ha la stessa partenza di A qualcuno piace caldo. Il protagonista di Mrs. Doubtfire, anche se per un motivo affettivo e non lavorativo, usa lo stesso escamotage del protagonista di Tootsie, a sua volta identico a quello della coppia di jazzisti di A qualcuno piace caldo. Eppure nessuno può negare che questi quattro film siano tutti molto diversi tra loro.
I canovacci della Commedia tendono a ripetersi, sono i contesti, gli ambienti, le situazioni, le rappresentazioni dei ruoli che cambiano.
Lo sviluppo di trame del genere ha uno schema praticamente obbligato:
1. Prologo. Si presenta il protagonista. Di lui dobbiamo conoscere non solo la professione, ma le convinzioni (in genere è una persona molto motivata, contenta del proprio ruolo) . Dobbiamo anche sottolineare certi suoi difetti che possono rendercelo simpatico . Non è quasi mai una persona importante, ma comune, e nient’affatto virtuosa.
2. Nasce una complicazione. Per l’urgenza di risolverla il protagonista cambia ruolo, si trasforma in un’altra persona che spesso ha un ruolo opposto al suo. Dall’iniziale disagio, passa alla stabilità: riesce a farsi accettare. Anzi tutto gli va miracolosamente meglio. Ma la stabilità raggiunta è minacciata dagli equivoci che si sono accumulati, e che hanno uno sviluppo sempre più complesso e ingovernabile.
3. Epilogo conclusione. Si tratta in genere di una baraonda finale, in cui tutti i personaggi sono in scena. Lo smascheramento/ soluzione si celebra in pubblico.
Sembra facile, ma non lo è affatto.
La situazione “buffa” ( data dal capovolgimento di ruolo) non è il punto d’arrivo, ma il punto di partenza. Quello che lo sceneggiatore deve raccontare è il groviglio di equivoci che nasce dallo scambio di ruoli iniziale.
Si tratta di escogitare situazioni divertenti a catena, secondo un meccanismo che è identico a quello che Hitchock usò per i suoi film di suspense. Cioè: lo spettatore conosce cose che i personaggi ignorano. Ridiamo della loro ignoranza e dalla facilità con cui cadono vittime dell’apparenza.
Nel caso di Tootsie, per esempio, lo spettatore sa che Tootsie è in realtà un uomo, mentre tutti gli altri personaggi credono che sia una donna.
Hitchock usa questo meccanismo tipico da commedia, ma lo stravolge e lo capovolge in pura tensione: in Psycho, noi sappiamo che la madre pazza di Norman Bates è stata chiusa in cantina e dunque tremiamo quando un altro e inconsapevole personaggio, cercando di nascondersi, va a rifugiarsi proprio in cantina. Però in Psycho il pubblico non sa e non deve sapere la cosa fondamentale e cioè che la madre pazza è lo stesso Norman Bates travestito.
Insomma: come si è accennato nella scorsa lezione, il “racconto del mistero”, anche quando rivela molto agli spettatori, si fonda su un segreto che non deve venire assolutamente rivelato se non nelle ultime scene. Nella commedia invece tutto deve essere rivelato e trasparente al pubblico. Il pubblico dovrà solo chiedersi: come diavolo farà il protagonista a uscire da un tal ginepraio di equivoci?
Il protagonista suscita la nostra simpatia perché passando attraverso una serie infinita di peripezie spesso si smarrisce nel finto ruolo che impersona fino a non sapere più che parte giocare e come liberarsi dalla sua stessa trama di inganni. Tutti questi passaggi psicologici del protagonista sono inscindibili da ciò che accade, devono essere raccontati . Ciò che accade insomma non è l’unica cosa che dobbiamo raccontare, ma anche come ciò che accade cambi il nostro protagonista, rendendolo una persona migliore e finalmente accettata dagli altri.
In genere il finale di commedia ci mostra che la salvezza del protagonista non starà nel continuare a nascondersi, ma proprio nello svelarsi di fronte a tutti. Solo allora, quando il suo castello di carte rischia di crollare miseramente, lui potrà davvero vincere e farsi accettare. In una commedia, fin dai tempi di Plauto, la simulazione e l’inganno producono un successo, una vittoria. Sono il modo attraverso cui si può giungere alla giustizia e alla verità, cioè alla fine degli inganni reciproci. In un thriller, invece, l’inganno teso dall’assassino agli altri personaggi e allo spettatore, in genere fallisce e viene punito. (Dico in genere perché non sono pochi i film , come ad esempio il recente Saw , in cui invece l’ingannatore vince e resta impunito).
La Commedia, che pare prendere in giro dal principio alla fine i “valori”, le “certezze”, la presunta saldezza dei ruoli sociali, ha quasi sempre una soluzione morale. Questa soluzione morale non sta nel punire, ma nel comprendere, non sta nel rimettere ordine, ma nel cambiare l’ordine.
Insomma attraverso il divertimento, la Commedia ci propone l’utopia di una società più mite, più disponibile, che sappia felicemente trasgredire ai ruoli prestabiliti. Se la morale comune, prestabilita, si fonda sul moralismo, la vera moralità si fonda sul riconoscimento delle nostre debolezze e della nostra capacità di cambiamento. Non dipende dai ruoli, ma da come sappiamo interpretarli. Questa verità deve trasmettersi dal protagonista a tutti gli altri personaggi (e ovviamente al pubblico). L’utopia non sarebbe tale se non diventasse patrimonio pubblico. Ecco perché l’epilogo di una Commedia è quasi sempre una scena collettiva, in cui compaiono tutti i personaggi.
Questo non significa che la Commedia non possa avere anche un andamento e un esito meno “buonista” e più disturbante. La Commedia come abbiamo visto, nasce da una sorta di brodo primordiale di generi “dionisiaci”, che con il tempo si distinguono: alcuni diventano indipendenti e autonomi ( il Comico, l’Horror, il Porno, il Musical), altri restando all’interno dei confini della Commedia, ne sviluppano però un’infinita serie di varianti e di sfumature.
d) La Commedia è una cosa seria
“La Commedia funziona così: si crea una situazione, poi si fanno agire e reagire i personaggi alla situazione e tra di loro. In una commedia, i personaggi non scherzano, non vogliono far ridere: devono credere a ciò che fanno, altrimenti la situazione diventa forzata, troppo voluta, e spesso, poco divertente.” (Syd Field). L’esempio offerto a questo proposito da Syd Field è Divorzio all’italiana (1961) di Pietro Germi, premio Oscar per la sceneggiatura. Field lo definisce “ a classic film comedy”. Per la verità si tratta di un film molto poco classico, anzi del tutto fuori dagli schemi, una “black comedy” inabituale per il cinema italiano. La “Black Comedy” è una sorta di variante grottesca della Commedia , che mette al centro della narrazione eventi più degni di una tragedia: tradimenti, complotti, conflitti coniugali e famigliari, crimini e omicidi anche efferati. Appartengono a questo sotto-genere film come Arsenico e Vecchi merletti (1944) di Frank Capra, La signora Omicidi (1955) di Alexander Mackendrick, Getta la mamma dal treno (1987) e La guerra dei Roses (1989) di Danny DeVito. Field però si serve dell’esempio, e in particolare dell’interpretazione di Mastroianni , per sottolineare che in una Commedia “i personaggi sono intrappolati in una rete di circostanze e svolgono il loro ruolo con esagerata serietà.” In proposito, Field cita anche questa “sentenza” di Woody Allen : “In una commedia recitare in modo divertente è la cosa peggiore che puoi fare.”
Questa è un’indicazione molto importante per lo sceneggiatore. Il protagonista di una commedia non deve essere necessariamente un comico, anzi questo è un pericolo. Non dobbiamo pensarlo come personaggio comico. Sono le circostanze, la situazione che costruiamo, a produrre divertimento, ma il protagonista non si diverte affatto, è troppo coinvolto, non sta giocando , sta cercando di salvarsi la reputazione e persino la pelle. Analizzeremo in un’altra lezione la specificità del cinema comico, qui ci limitiamo a richiamare il modello Susarione, cioè la serie di gag senza capo né coda. Il genere comico è totalmente anarchico, non sopporta strutture troppo vincolanti di racconto, la storia è solo un lieve pretesto per unire un numero comico al successivo, il protagonista entra ed esce dalla parte e a volte persino dal suo ruolo di attore/interprete con assoluta libertà, con l’unica preoccupazione di sostenere un certo ritmo: come avviene per un solista jazz, insomma. La Commedia invece costruisce degli intrecci molto complessi, il protagonista deve affrontare problemi molto seri, salvarsi da situazioni estreme che possono travolgerlo da un momento all’altro. E’ dunque lui stesso, come scrive Field, esageratamente serio.
L’esempio limite che si può fare è Oltre il Giardino (1979) di Hal Ashby. Peter Sellers che interpreta il ruolo di Chance, un giardiniere mentalmente ritardato che viene scambiato per un grande esperto di economia, mantiene per tutto il film un’espressione stralunata, da alieno gentile. Mentre scorrono i titoli di coda, il regista ci mostra dei ciak non riusciti nei quali si vede Sellers che non riesce a frenarsi e scoppia a ridere. Nella conduzione del suo personaggio, ciò non era in alcun modo possibile, sarebbe stato un errore. Chance alla fine, con il suo totale candore, si rivela una sorta di creatura metafisica ( cammina sulle acque). Il film fa molto ridere, senza che nessuno rida mai sullo schermo. Anzi, i personaggi, tutti i personaggi, agiscono, parlano con una serietà estrema. Tutte le battute che si pronunciano, non sono umoristiche per chi le pronuncia, lo sono per noi spettatori, perché la situazione,il contesto, ciò che sappiamo (e che i personaggi ignorano) ce le fa apparire tali. Dicevo che siamo ai limiti estremi della Commedia, quasi inarrivabili (anche se un film come Forrest Gump è andato molto vicino a questo risultato).
Per riassumere: dal brodo primordiale dei generi non-tragici esce una forma di spettacolo più costruita che dagli spunti puramente farseschi degli inizi, sviluppa una costruzione e una struttura quasi ferrea. Questa struttura però consente di liberare toni, stili, sfumature diversissime tra loro.
La Commedia può essere molto popolare, anche esplicitamente volgare (tipo American Pie, per intenderci) , può essere indirizzata alla satira di costume, alla polemica politica e sociale, può anche arrivare ad esprimere una filosofia di vita, e persino un sentimento poetico dell’esistenza, come in Oltre il Giardino. La scelta del tono è dunque fondamentale. Il protagonista e gli eventi che scegliamo di mettere in scena costruiscono uno stile e insieme vengono condizionati da questa scelta di stile, cioè tutti gli elementi della rappresentazione devono restare coerenti.
ESERCIZIO – Tra i tanti film citati in questa lezione, vi suggerisco di vedere più volte e di smontare nelle sue singole parti, Tootsie (1982) di Sydney Pollack .
Distinguete anzitutto i Tre Atti (prologo e presentazione del protagonista/ nascita e sviluppo della complicazione/ Epilogo).
Di ogni singolo atto, appuntatevi gli episodi che scandiscono la narrazione. Insomma ricostruite la scaletta del film, evento per evento.
Scrivete su due colonne, da un lato le situazioni, dall’altro l’evoluzione psicologica del protagonista, cioè uno specchietto comparativo di come la sequenza di eventi influenzi il suo carattere.
Scegliete una scena esemplare, quella che preferite, e ricostruite il gioco degli equivoci, il modo in cui lo sceneggiatore li accumula, come li fa arrivare vicini alla zona di rischio (per il protagonista) e come riesce ad allontanarsene. Distinguete, in questa scena, gli equivoci verbali da quelli fisici o di fatto (dovuti alla situazione).
Studiate attentamente l’epilogo cioè la scena dello smascheramento finale, di fronte a tutti.
So che in genere nelle scuole di scrittura, si parte subito da esercizi di scrittura che possono essere efficacemente discussi in gruppo , ma insisto che questo lavoro andrebbe sempre accompagnato allo studio strutturale dei film, cosa che di solito viene troppo trascurata. Quando si sta scrivendo una Commedia questo studio di struttura non può assolutamente essere considerato secondario. Come ho cercato di mostrare, ciò che costituisce una commedia è il passaggio da una struttura fissa e quasi obbligata, a uno stile, cioè al nostro modo di usare questa struttura, in coerenza con il tipo di protagonista e con ciò che abbiamo scelto di raccontare. Prima di poter compiere queste scelte stilistiche è necessario che la struttura di base ci sia diventata famigliare.
12° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Distinguiamo alcune funzioni essenziali:
1. Funzione espressiva
La parola, l’espressione verbale, sono sempre in rapporto con il comportamento, con lo stato emotivo particolare del personaggio in un certo momento della storia, non sono cioè un testo puramente scritto (letterario) ma una comunicazione verbale che ci rivela molto del personaggio. Ci rivela la sua origine (dall’inflessione), il suo livello culturale (dalla vastità del vocabolario, dai termini scelti, dalla proprietà o meno del linguaggio), il suo atteggiamento nei confronti degli altri e della vita non in termini ideologici, ma come “psicologia in atto” (uso o meno dell’ironia, concisione o verbosità, giudizi meditati o frettolosi, timidezza o spudoratezza, franchezza o simulazione, eccetera) .
Prendiamo come esempio un dialogo tratto dal film La Febbre del Sabato Sera (1977) sceneggiatura di Norman Wexler, ma prima vediamo la descrizione che Wexler ci dà del protagonista Tony Manero.
“ Il suo modo di camminare per strada è una performance. Tony ha diciotto anni, quasi diciannove, è alto, ben proporzionato, si muove con studiata disinvoltura e una punta di spavalderia. Ha un bel volto e quando è rilassato suscita un’istintiva simpatia che lo rende amabile. La sua personalità acquista luce dal contesto, lo fa spiccare sugli altri ( prodigo di buoni consigli con gli amici, sicuro e macho con le donne). In famiglia è imbronciato e cocciuto: rispetta i genitori, ma non si fida gran che di loro, prevede in anticipo le loro domande e le loro critiche nei suoi confronti. Spesso appare pensoso, ma se gli si chiede a cosa stia pensando, non sa dirlo. Vive in un eterno presente, il futuro per lui si limita al prossimo week end in discoteca. Tuttavia ci sono dei momenti , rari e privati, subito rimossi, in cui avverte qualche vaga preoccupazione sull’insieme della sua vita. Mangia, di fretta e con indifferenza, meccanicamente, senza provarne piacere, dando così l’impressione non d’essere un ghiottone, ma un insaziabile affamato che tuttavia non si cura del cibo se non come mero alimento. E’ un ballerino superbo, forte e pieno di grazia, si muove fluido e preciso, con una presenza notevolissima e una bravura indubitabile. In pista, si fermano tutti per guardare lui. E’ l’indiscusso re della compagnia”.
Come si vede, prima di fare agire e parlare il suo personaggio, Wexler si preoccupa di caratterizzarlo nei dettagli. Non è un caso che questi dettagli comincino dal modo di camminare e di muoversi, che includano il suo modo di mangiare … insomma si comincia dalla “fisicità” per fondare su di essa le caratteristiche psicologiche e il suo modo di “rapportarsi” con gli altri.
Passiamo alla descrizione che Wexler ci fa della sua partner Stephanie Mangano.
“ Stephanie, vent’anni, altezza media, slanciata, con un volto intenso e attraente, lunghi capelli neri con la scriminatura centrale, è in affannosa ricerca di cambiare se stessa , eliminando le tracce delle sue origini popolari nel quartiere di Bay Ridge e di rimodellarsi in una donna sofisticata, esperta delle cose del mondo, o quanto meno di tutto ciò che lei considera alla moda. Di fatto è un’amabile simulatrice, a mezzo tra due identità diverse, piena di arie e supponente, sempre in cerca di far colpo al di là di quanto le è possibile, una frustrata… ma in qualche modo riscattata da un senso giocoso e ironico del ruolo che recita e da una naturale disposizione all’ingenuità, alle gaffes, a una sostanziale trasparenza del suo comportamento. La cosa più importante è che la sua dolcezza di fondo e il suo coraggio ce la rendono simpatica anche quando le sue parole o azioni risultano offensive.”
Chiariti così i personaggi, il dialogo tra loro non diventa altro che l’espressione delle reciproche caratteristiche.
SCENA / BAY RIDGE STREET Esterno Sera
Tony e Stehanie a passeggio.
STEPHANIE: Dove lavoro io, vedo gente straordinaria… così… diversa dalla gente di Bay bridge.
TONY: Gli snob invece degli slob (in gergo per : zoticoni)
STEPHANIE: Cosa?
TONY: Bay Ridge non è la parte peggiore di Brooklyn... non è mica un inferno…
STEPHANIE: No, però non è Manhattan . Tu non hai idea di come sia diverso, di come cambi tutto di là del fiume. La gente è fantastica, gli uffici sono fantastici, le segretarie fanno tutte lo shopping da Bonwit Taylor. Persino gli intervalli di pranzo sono fantastici. Ti lasciano anche un paio d’ore per seguire i tuoi interessi… abbiamo visto, ho visto… Giulietta e Romeo di Zeffirelli.
TONY: E’ di Shakespeare. L’ho studiato a scuola.
STEPHANIE (facendo sfoggio di cultura): Zeffirelli era il regista. Della pellicola, voglio dire... il film.
TONY: Romeo avrebbe anche potuto aspettare un attimo. Non doveva prendere quel veleno così alla svelta.
STEPHANIE (sulla difensiva): E’ così che prendevano il veleno a quei tempi.
La scena continua in un caffè e gli elementi qui tracciati vengono approfonditi e dilatati con un vivace tono da commedia, ma noi possiamo anche fermarci qui per rimarcare alcune cose.
1. Dobbiamo fare incontrare i due personaggi e questo incontro è un’occasione per conoscerli nelle loro differenze.
2. Si va subito al punto con un giudizio in cui Stephanie cerca di differenziarsi dal suo quartiere. Parla apparentemente di un tema generico , ma esprime se stessa.
3. Tony scherza, non la prende molto sul serio, anche se evita di prenderla apertamente in giro o di polemizzare. Anche Tony rivela se stesso: non è un bullo da quattro soldi, rispetta la ragazza, cerca di capire le sue convinzioni senza ritenersi implicitamente offeso.
4. Lei alla prima obiezione scherzosa, già fatica a reggere il gioco. Non riesce a simulare fino in fondo. E’ un’ingenua e fa anche simpatia con questo suo atteggiamento.
5. E’ Stephanie ad avere le battute più lunghe. Tony agisce di rimessa con brevi notazioni, a contrasto con l’impacciata verbosità di lei. Stephanie usa sempre gli stessi aggettivi: pronuncia la parola beautiful ( che ho tradotto “fantastico”) indifferentemente per le persone, gli uffici, persino gli intervalli di lavoro.
In conclusione: il modo di parlare , l’uso del linguaggio, sono estrinsecazioni di un personaggio, devono dunque essere sempre coerenti al personaggio. In un dialogo tra due personaggi le differenze di linguaggio tra i due si devono notare, perché sono parte della differenza dei caratteri.
Non fate parlare i personaggi tutti nello stesso modo. Anche se si tratta di personaggi dello stesso quartiere, dello stesso ambiente sociale, dello stesso livello culturale, si tratta tuttavia di individui diversi e questa loro diversità deve venire espressa in quello che dicono e nel modo in cui lo dicono. Ciò che dicono e anche quello che non dicono è rivelatorio del loro atteggiamento.
2. Funzione informativa
In un dialogo si forniscono anche informazioni al pubblico sulla storia. Questa funzione tuttavia deve essere usata con grande parsimonia e ben regolata. Nella tragedia greca un ruolo codificato è quello del messaggero che per esempio giunge in scena a raccontare com’è andata una battaglia. In cinema è molto rischioso usare questo espediente perché in cinema gli eventi si mostrano, non si narrano a parole, tanto meno eventi di grande potenzialità spettacolare, come una battaglia. Tuttavia, dare sinteticamente delle informazioni può essere molto utile a stringere i tempi della narrazione e a offrire qualche coordinata essenziale.
Prendiamo ad esempio questa battuta del detective privato Sam Spade nel film Il Falcone Maltese (1941) sceneggiatura di John Huston.
SCENA – SALOTTO DELL’APPARTAMENTO DI SPADE. Interno Giorno.
Spade al telefono.
SPADE: Pronto… c’è il Sergente Polhaus? … sì… sono Sam Spade ( attesa). Ciao, Tom… senti, ho qualcosa per te. Le cose stanno così: Thursby e Jacobi sono stati uccisi da un certo Wilmer Cook… sì, sui vent’anni, un metro e sessanta. Vestito grigio di lana, soprabito grigio , camicia con il colletto morbido, cravatta chiara di seta. Lavora per un certo Kasper Gutman. Cura questo Gutman. Pesa più di cento chili… è coinvolto anche quel Cairo… sì… adesso stanno andando al Hotel Alexandria ma sono pronti a tutto quindi vedi di muoverti… non credo che si aspettino di venire pizzicati… stai attento quando affronti il ragazzo… Proprio così. Molto. Beh, buona fortuna, Tom.
Come si vede, l’informazione non viene in questo caso fatta filtrare all’interno di un dialogo, ma viene comunicata proprio per tale. Come un’informazione. Il detective parla con un poliziotto e segue regole di comunicazione chiare e svelte, con dati segnaletici. Tutto è rigoroso ed essenziale. Si dà per scontato che il poliziotto sappia valutare l’importanza dell’informazione senza bisogno che Spade la sottolinei troppo e la precisi maggiormente.
Prendiamo ora un altro caso, in cui un personaggio racconta a un altro un evento cui non abbiamo assistito e che non ci viene mostrato. Il seguente dialogo è tratto dal film Conoscenza Carnale (1971) , sceneggiatura di Jules Feiffer. Sono in scena Jonathan e Sandy, compagni di stanza al college negli anni 40, all’epoca entrambi ancora vergini.
SCENA- CAMPUS Esterno Notte
Jonathan e Sandy camminano lungo la strada che conduce al loro dormitorio. Foglie secche sul terreno.
JONATHAN: E allora?
SANDY: Mi ha detto di toglierle la mano dalla tetta.
JONATHAN: E allora?
SANDY: Le ho detto che non volevo.
JONATHAN: E allora?
SANDY: Mi ha detto che non capiva come facevo a trovarlo divertente se a lei non andava.
JONATHAN ( disgustato) : Gesù!
SANDY: Così io le faccio: credevo di piacerti.
JONATHAN: Sì?
SANDY: E lei fa: mi piaci per altri motivi.
JONATHAN: Altri motivi?!
SANDY: Così io le ho spiegato perché ne sentivo proprio bisogno…
JONATHAN: Cioè cosa le hai detto?
SANDY: Beh… che per me era la prima volta.
JONATHAN: La prima volta cosa? Cosa hai detto esattamente?
SANDY: Beh, di preciso non ricordo… che lei era la prima ragazza che avevo provato a toccare.
JONATHAN: Le hai detto così?
SANDY: Ho sbagliato?
JONATHAN: Io non l’avrei fatto.
SANDY: Lei così è stata più carina .
JONATHAN: Più carina in che senso?
SANDY: Mi ha messo la mano sulla sua tetta.
JONATHAN: Vuoi dire che tu gliel’hai messa e che lei ce l’ha lasciata.
SANDY: No, lei l’ha presa e me l’ha messa sopra.
JONATHAN: Te l’ha presa così… e te l’ha messa qui?
SANDY: Proprio così. Non sapevo più che pensare.
JONATHAN: No , eh?
SANDY: Voglio dire… era una cosa amichevole tra noi… e lei di colpo è diventata un tantino aggressiva.
JONATHAN: E poi?
SANDY: Le ho chiesto se era vergine.
JONATHAN: Stai scherzando!
SANDY: Ho sbagliato? … Comunque , sì, lo è.
JONATHAN: Lo dice lei. Cos’hai rimediato alla fine? Una mano sulle tette o due?
SANDY: Mi ha messo anche l’altra mano sull’altra tetta.
JONATHAN: Ti ha messo su… tutte e due le mani? Due mani?
SANDY: Sì, così io le ho detto: e tu con le tue mani cosa ci fai?
JONATHAN: No, non gliel’hai detto!
SANDY: Mi è scappato!
JONATHAN: E allora?
SANDY: Lei… per essere precisi… mi ha tirato fuori l’uccello.
JONATHAN: Che contaballe! E poi? E poi?
SANDY: L’ha fatto.
JONATHAN: Ha fatto cosa?
Sandy fa il gesto della masturbazione con la mano, ghignando.
JONATHAN: Sei un contaballe! Davvero ti ha fatto… ?
Sandy salta su e giù eccitato. Scoppiano a ridere tutti e due.
In questa scena Feiffer (lo sceneggiatore) mostra a contrasto i due personaggi: Jonathan (interpretato nel film da Jack Nicholson) personaggio potenzialmente sciovinista e sessista, cinico nei confronti delle donne, e Sandy ,(interpretato da Art Garfunkel) più convenzionale e anche un po’ stupidotto, tuttavia non certo uno che si tira indietro per troppa timidezza. Nel dialogo, Sandy sta informando Jonathan su come è andato un suo incontro con una ragazza. Contravvenendo apparentemente alla regola per cui gli avvenimenti al cinema vanno mostrati, non semplicemente riferiti, Feiffer in realtà sottolinea quello che lui vuole raccontare, cioè non l’incontro sessuale in sé, ma il modo diverso in cui i due amici affrontano il problema della loro verginità. Sono loro i protagonisti. La ragazza è un pretesto, è un’occasione per conoscere i due amici a confronto. Non è importante mostrarla, anzi sarebbe incongruo. Ritroviamo questa tecnica di dialogo in molti film di Scorsese e di Quentin Tarantino (tanto per fare due esempi) : i personaggi si raccontano storie vissute. Queste storie non vengono mostrate, nemmeno in FLASH BACK, perché non sono il vero oggetto della narrazione. L’oggetto sono e restano i personaggi, il loro modo di raccontare e di interagire. Si parte da un contenuto di tipo informativo ma in realtà lo si usa in funzione espressiva. Quando in un film avete necessità di far raccontare un fatto, ricordatevi sempre che il vero oggetto della narrazione sono i personaggi che in quel momento assumono la funzione di narratori. Sandy, nella scena che abbiamo esaminato, non è un messaggero , cioè il semplice e neutro latore di una notizia, ma è un protagonista che attraverso il racconto di un’esperienza vissuta esprime se stesso, il suo carattere.
3. Funzione enunciativa
In un dialogo i personaggi possono anche esporre i propri punti di vista su un qualche argomento o chiarire i propri progetti e le proprie intenzioni. Fate attenzione perché anche questo ha stretta attinenza con la descrizione che stiamo dando del personaggio. Evitate di usare il personaggio per mettergli in bocca opinioni vostre , di voi che scrivete. Le opinioni devono sempre essere quelle di quel tipo di personaggio, servono a farcelo comprendere meglio.
Prendiamo ad esempio alcuni giudizi tranchant dell’anziana attrice Norma Desmond, una celebrità del muto ormai decaduta, nel film Viale del Tramonto (1950) sceneggiatura di Charles Brackett e Billy Wilder. Nella scena, l’anziana attrice incontra un giovane sceneggiatore (Gillis).
GILLIS: Il vostro volto non mi è nuovo. Voi siete Norma Desmond. Facevate molti film. Eravate grande.
DESMOND: Io sono grande. E’ il cinema che è diventato piccolo.
GILLIS: Sì, qualcuno deve avere sbagliato qualcosa...
DESMOND: E’ morto. Finito. C’era un tempo in cui in questo lavoro avevamo addosso gli occhi dell’interno mondo. Ma non era abbastanza. Oh no! Loro volevano anche le orecchie. Così hanno aperto le loro boccacce e cominciato a parlare, parlare, parlare….
GILLES: Ecco perché si vende il pop corn. Te ne prendi una scatola e ti ci tappi le orecchie.
DESMOND: Colpa dei caporioni, nei loro begli uffici! Prendevano gli idoli e li infrangevano. I Fairbanks, i Chaplin, i Gilbert, i Valentino. E adesso cosa gli è rimasto? Delle nullità… un pugno di ranocchi incolori che gracidano!
Più tardi, Norma parla a Gillis di un suo progetto di sceneggiatura.
NORMA: Quanto dev’essere lunga una sceneggiatura, oggi? Cioè… quante pagine?
GILLIS: Dipende dal film… se è Paperino o Giovanna d’Arco .
NORMA: Questo sarà un film molto importante. L’ho scritto io stessa. Ci ho messo degli anni.
GILLIS ( guardando la pila di fogli sul tavolo): Qui ce n’è abbastanza per sei film importanti.
NORMA: E’ la storia di Salomè. Credo che lo dirigerà De Mille.
GILLIS: Uh-uuh
NORMA: Abbiamo fatto molti film, insieme.
GILLIS: E voi reciterete nel ruolo di Salomè?
NORMA: E chi sennò?
GILLIS: Chiedevo. Non sapevo che stavate progettando un rientro.
NORMA: Odio quella parola. E’ un ritorno. Un ritorno ai milioni di persone che non mi hanno mai perdonato d’aver abbandonato lo schermo.
Le opinioni di Norma sul cinema, i suoi progetti folli. Il personaggio, comparso nel film mentre sta seppellendo la sua scimmia in giardino, grazie al dialogo non viene presentato semplicemente come una pazza, ma come una donna con ferme opinioni e con progetti. Il cinismo con il quale lo sceneggiatore disoccupato Gillis le dà corda fa da contrappunto . Anche in questo caso, in cui nel dialogo si pronunciano giudizi e si enunciano intenzioni, non ci si discosta dalla prima ed essenziale funzione del “parlato”, quella espressiva.
4. Funzione dialettica
In un dialogo si mettono a confronto almeno due personaggi. Abbiamo visto in tutti gli esempi precedenti come questi due personaggi inevitabilmente finiscano per contrapporsi . Certo, non è strettamente indispensabile che i loro punti di vista si scontrino, uno dei due personaggi (come nel caso di Jonathan) può sollecitare l’altro, oppure (come nel caso di Gillis) assecondare l’altro, eppure nel confrontarsi si mostrano diversi. Insomma un dialogo mette sempre in scena una dialettica tra due punti di vista differenti. Se un personaggio dice la sua e tutti gli altri si limitano a dargli ragione, non siamo più in presenza di un dialogo, ma di un monologo assertivo. La funzione di un dialogo è dunque fondamentalmente espressiva, ma non unilaterale. Un dialogo ci mostra più spesso di quanto non accada nella vita reale (popolata da dialoghi tra sordi) personaggi che si ascoltano l’un altro, che si prendono più o meno sul serio, e che ribattono alle parole degli altri. Anche quando uno dei due personaggi all’apparenza si limita a fare da spalla , anche se , come Jonathan, continua a ripetere semplicemente: “ E allora?” , nella sua insistenza, nel suo chiedere maggiori dettagli , dice implicitamente:”io sono qui e sono diverso da te” . Bisogna stare molto attenti a non aderire troppo ad un personaggio, lasciando agli altri un mero ruolo di supporto, o di passiva complicità. Un dialogo vive di contrapposizione. La scena in cui Sam Spade parla al telefono, non richiede contrapposizione alcuna e dunque non ha alcun bisogno di mostrarci l’interlocutore. Ma se noi vediamo l’interlocutore, dobbiamo dargli un ruolo, una presenza attiva. Il suo intercalare ha anche il risultato ritmico di spezzare le battute dell’altro, di impedire che i dialoghi diventino discorsi (come nella tradizione teatrale e letteraria ).Il tempo del Discorso, non è un tempo cinematografico. Come abbiamo osservato nella precedente lezione, il montaggio accorcia il tempo degli eventi reali. Il parlato in cinema vive anch’esso di montaggio. Senza alternanza di battute, fermiamo il ritmo. Possiamo farlo se è un effetto consapevole che vogliamo dare. Ma se invece crediamo che consentire a un personaggio di dire tutto quello che ha da dire di filato , possa abbreviare il tempo complessivo della scena, beh allora ci sbagliamo clamorosamente. La somma di molte piccole frasi scambiate risulta comunque più veloce di un monologo. Le interruzioni non sono pause, sono un elemento ritmico (accenti che conferiscono dinamica all’espressione verbale) e sono un elemento dialettico grazie al quale ciascun personaggio prende luce e rilievo dall’altro, pur esprimendo se stesso.
ESERCIZIO
Utilizzate l’esempio proposto in questa lezione (da La Febbre del Sabato Sera). Scrivete i profili dei due personaggi protagonisti della vostra scena di dialogo e fate in modo che il dialogo esprima le loro caratteristiche.
Fin dalla prima lezione ho sottolineato la necessità di stilare dei profili dei vostri personaggi. Pochi però lo hanno fatto. In genere preferite passare subito alla sceneggiatura delineando alcune scene. In questo modo però finite per scoprire il vostro personaggio in corso d’opera cioè man mano che lo scrivete e accumulate incoerenze che poi vi ritroverete a dover correggere.
In tutti i manuali si insiste su soggetto/scaletta/trattamento/sceneggiatura come fasi principali del lavoro dello sceneggiatore. Ma è indispensabile anche concentrarsi sul profilo dei personaggi, che anzi dovrebbe essere la fase preliminare a tutte le altre. Quando avete scritto il profilo dei vostri personaggi, tenetelo sempre in vista mentre sceneggiate e verificate sempre che i comportamenti, le azioni, il modo di parlare e di esprimersi, corrispondano alle caratteristiche che voi stessi avete fissato di quel certo personaggio. Può capitare che scrivendo vi venga in mente una svolta, una correzione, un’integrazione al personaggio. Allora correggete il profilo, ma tenetelo sempre come guida, perché questa correzione avrà necessariamente la sua influenza su tutte le scene in cui compare il personaggio. Tony Manero, nel film succitato, balla anche quando cammina .Non dobbiamo far capire che è un ballerino nato solo nella sua scena di ballo in discoteca. Il ballo pervade tutta la sua vita. E’ il suo modo di muoversi che appare tanto naturale, sottolinea lo sceneggiatore, quanto studiato. Se non tenete presente l’unità del personaggio, il vostro personaggio diventerà una sorta di Frankenstein che in una scena si comporta e si esprime in un modo e in un’altra in un altro, e l’attore che lo interpreta avrà di conseguenza grossi problemi nel dare coerenza a un simile personaggio. Oppure può capitarvi di fare esprimere il vostro personaggio in modo neutro e meramente funzionale, senza caratterizzazione alcuna. In questo modo perderà qualsiasi caratteristica distintiva ed esporrete l’attore a dubbi anche più grandi nell’interpretarlo: per caratterizzare una battuta troppa neutra, magari gli conferirà un’ironia che non avevate affatto previsto, oppure drammatizzerà eccessivamente una battuta casuale e da non sottolineare troppo.
Tutto quello che si scrive in una sceneggiatura, non serve a voi che scrivete, ma ai reparti: al regista, agli attori, ai costumi, allo scenografo, al direttore della fotografia eccetera. Ciascuno di essi leggerà la scena dal suo punto di vista per capire come renderla al meglio nell’ambito del proprio ruolo. Di conseguenze le indicazioni devono essere molto precise e non offrire il destro a interpretazioni troppo varie e “libere” , altrimenti l’insieme della scena perderà ogni coerenza narrativa. Ora: l’asse della coerenza narrativa è rappresentato dai personaggi . Delineare bene i personaggi è il fondamento della narrazione. E il dialogo ,in quanto espressione dei personaggi, non può risultare efficace se non vi è costantemente chiaro chi sono le persone che stanno parlando.
APPENDICE – Il dialogo nei fumetti
Molte delle cose dette sopra a proposito della sceneggiatura cinematografica valgono anche per una sceneggiatura a fumetti. Il confronto è estremamente utile anche per chi si interessa solo di sceneggiatura cinematografica, perché certe caratteristiche sopra richiamate risultano addirittura esaltate in fumetto, altre invece sono opposte. Prenderò come base i fumetti Bonelli in quanto più assimilabili al cinema: i tempi della narrazione sono più dilatati rispetto a un fumetto Marvel , le azioni sono descritte in sequenza, le scene di dialogo sono più ampie . Inoltre i fumetti Bonelli di ultima generazione usano un linguaggio meno classicamente “da fumetto” e più vicino alle sfumature della lingua parlata usata nel cinema.
1.Quando avete necessità di una lunga scena di dialogo tra due o più personaggi, anzitutto cercate di suddividerla in due o più scene, cioè in ambienti diversi. Se riesaminate la scena di dialogo tratta da La febbre del Sabato Sera, noterete che è suddivisa in due scene diverse (come del resto quella di Viale del Tramonto): una all’esterno e un’altra all’interno. Nella prima i personaggi si muovono passeggiando , nella seconda sono seduti in un bar uno di fronte all’altra. Il dialogo è continuato, come se si trattasse di un’unica scena, ma differenziare gli ambienti permette di renderla visivamente più mossa, meno monotona e di variare le inquadrature. In fumetto questo è anche più importante, in quanto si tratta di disegni: non abbiamo a disposizione né attori , né movimento. Il rischio di una rappresentazione troppo statica è dunque molto più elevato.
2.Ha grande importanza che i due personaggi dialoghino davvero, cioè che uno dei due non si limiti a una presenza da bella statuina. Anche questa è un’esigenza più forte nel fumetto che in cinema. Normalmente in un film, una scena di dialogo tra due persone sedute a un tavolo, si gira così: prima si gira un master, cioè un’inquadratura in cui i due personaggi appaiono insieme nell’ambiente e recitano la scena dal principio alla fine. Poi si rigira la stessa scena in favore di uno dei due personaggi . Poi la si rigira a favore dell’altro. (Le inquadrature possono essere differenziate: PP dei due personaggi distinti, oppure con presenza in quinta di spalle dell’interlocutore, o master più stretti in cui i due personaggi si vendono entrambi ma più isolati dall’ambiente). Anche in questo caso però si gira l’intera scena: il personaggio che parla non viene ripreso solo quando parla , ma anche quando ascolta. Quest’ultimo si chiama “piano d’ascolto” e permette di far interagire i personaggi. Un personaggio anche se non parla, può essere espressivo per le reazioni che suscitano nella sua espressione muta le parole dell’altro. Inoltre, è molto monotono in cinema continuare a staccare ripetitivamente tra uno che parla e l’altro che risponde. Il montatore avrà più chance se potrà alternare il totale del master con i PP, i campi e controcampi, i piani in cui gli attori parlano e quelli in cui ascoltano. Tutto ciò muove la scena e le conferisce ritmo, e inoltre aiuta a mascherare possibili errori , ad eliminare pause di troppo o a inserirne se necessario, eccetera. In un fumetto questo movimento va reso sulla tavola, badando a non ripetere nella stessa tavola vignette identiche e badando anche a non creare effetti fastidiosi come ad esempio due vignette sovrapposte con piano identico anche se i personaggi rappresentati nella vignetta cambiano. La vignetta, al contrario di un’inquadratura cinematografica che è disposta nel tempo, prima o dopo le altre, è disposta nello spazio, cioè (nella tavola) insieme alle altre e una rappresentazione grafica monotona e ripetitiva ha in genere un effetto sgradevole. In un fumetto lo sceneggiatore è in certo modo anche regista della messa in scena, deve cioè precisare le inquadrature ( cosa che non è costretto a fare in una sceneggiatura cinematografica) se non altro per dare al disegnatore una traccia di impostazione della tavola nel suo insieme. Vi basterà guardare con attenzione delle scene di dialogo in un fumetto Bonelli per capire le varie tecniche che si usano, spesso mutuate dai campi/controcampi caratteristici del cinema, ma spesso più libere (per esempio con totali dall’alto, o con fondo bianco, in cui magicamente l’ambiente sparisce) per ottenere una maggiore varietà grafica nella pagina.
3. Le esigenze di sintesi proprie della battuta cinematografica, in un fumetto sono anche più stringenti. Le parole in un fumetto sono disegnate dentro la nuvola (il balloon) che è un elemento grafico esso stesso per il quale va previsto quando si disegna, uno spazio apposito. E’ evidente che se il balloon è troppo pieno di parole, diventa talmente grande che copre buona parte del disegno o costringe a effetti bruttissimi per esempio di balloon drappeggiati attorno alla testa e alle spalle del personaggio oppure a colonne di balloon in cui lo stesso dialogo viene suddiviso in singole frasi, ma con la conseguenza esteticamente poco piacevole di raffigurare sulle teste dei personaggi dei cono gelato a palle sovrapposte . Un balloon che ospiti più di trentacinque parole ( inclusi gli articoli) finisce per nuocere al disegno dei personaggi e della scena, mangiandosi gran parte dello spazio disponibile. Dunque se avete necessità di fare dire una lunga battuta a un personaggio, dovrete comunque badare a suddividerla non solo in più balloon, ma in più vignette. D’altro canto anche un eccesso di piani d’ascolto (con balloon da fuori campo) è un effetto sgradevole in fumetto . Dunque è buona regola in un dialogo che il personaggio principale non sia il solo a parlare, ma anche all’altro siano date occasioni di interruzione, di commento, di richiesta di chiarimento o di supporto al ragionamento fatto dall’altro. I monologhi esaltano la staticità: in fumetto (che è di per sé statico) abbiamo esigenza di cambiare le inquadrature più spesso che in cinema, evitando le ripetizioni.
ESERCIZIO – Quando in un fumetto si deve scrivere una scena di dialogo, ci si può anche occupare delle inquadrature in un secondo momento. Cioè: scrivete il dialogo, con botte e risposte, quasi si trattasse di un dialogo quotidiano, tra due personaggi reali che sviluppano una conversazione. Non preoccupatevi in questa fase della misura e della lunghezza della scena. Scritto questo primo brogliaccio, sintetizzatelo: togliete le frasi di passaggio, quelle che comportano ragionamenti troppo complessi, quelle più digressive rispetto all’argomento centrale. In altre parole cercate di concentrarvi sul contenuto fondamentale della conversazione e asciugate di conseguenza il primo testo. Dopo aver fatto questo, riprendete di nuovo il testo del dialogo da capo e cercate di condensare ancora, cioè di verificare se ogni singola battuta che avete scritto può venire espressa con meno parole. Questo riguarda anche la coloritura espressiva della frase. Una metafora, un’espressione particolarmente ficcante rendono sempre di più di un freddo ragionamento. Il linguaggio deve essere molto chiaro ed inequivocabile. Dato che in fumetto non abbiamo a disposizione degli attori e che è molto difficile per un disegnatore rendere le minime sfumature dell’espressione di un volto, è bene che le parole da sole , puramente scritte, senza che se ne possa udire il tono, siano trasparenti: una frase ironica dev’essere esplicitamente ironica nella scelta stessa delle parole usate, è meglio se risulta buffa piuttosto che “sottilmente ironica” perché la sottigliezza sarà sempre molto difficile da cogliere dal disegno. Se il vostro personaggio pronuncia una battuta commuovente, è importante che sia il testo stesso a commuovere. Se il disegnatore non darà una particolare accentuazione al volto del personaggio ( che so, una lacrima che scende , uno sguardo rivolto in basso, il capo chino, la fronte corrugata eccetera ) l’effetto che avete voluto dare resterà comunque nel testo. Anzi spesso non è consigliabile caricare troppo l’espressione del personaggio perché potrebbe dar luogo ad effetti un po’ ridicoli: stupori, perplessità, isterismi, ghigni, che certo fanno parte dell’iconografia fumettistica, vanno però regolati a seconda di quanto avviene. L’eroe non può stupirsi allo stesso modo di fronte a un evento del tutto prodigioso o ad un evento semplicemente inatteso. Il dialogo (o i pensieri) aiutano indubbiamente a precisare l’intensità emotiva , accentuandola o stemperandola dove necessario.
Una volta sintetizzato così il dialogo, cominciare a suddividerlo in vignette, per capire bene quante tavole occupa la scena. Un numero eccessivo di tavole di dialogo nello stesso ambiente, diminuisce le chance del disegnatore e lo costringe a infinite capriole per non ripetersi . Per disegnare qualcos’altro, a volte ci si trova costretti a passare all’esterno e vedere i balloon dei personaggi che dialogano spuntare da una finestra, oppure ad inquadrare la scena in campo lungo con i due personaggi che dialogano sullo sfondo e delle comparse in PP. Questo tipo di scelte sono sempre molto discutibili in quanto distraggono l’attenzione. Il volto o il gesto di una comparsa in PP può diventare indebitamente protagonista a scapito dei personaggi protagonisti. Lo stesso vale per gli oggetti . Il disegnatore può divertirsi a disegnare in PP un vaso cinese graficamente molto elaborato, con i due protagonisti che chiacchierano sul fondo. Ma perché mai un vaso dovrebbe essere protagonista della scena? Se nella stessa scena questo dettaglio di scenografia ha un’importanza narrativa ( per esempio per farci capire che si tratta di un locale cinese di una certa eleganza, oppure perché successivamente quel prezioso vaso verrà spaccato) allora ha un senso metterlo. Se invece è una pura belluria da ornamento, una furbizia per evitare di stare sempre sui personaggi, allora questo dettaglio è soltanto distraente . E’ molto meglio, di fronte a una scena di dialogo che si sviluppa per parecchie pagine, cercare altre soluzioni: per esempio quella già indicata di suddividere il dialogo in più ambienti con i personaggi in movimento, oppure abbreviando ancora la scena fino a raggiungere una dimensione accettabile in termine di numero di pagine. Qui ovviamente si aprono delle alternative, diverse a seconda dello stile del fumetto e dell’autore : su Tex un dialogo in un interno può durare anche più di otto pagine, su Magico Vento è molto raro che una scena di dialogo in un ambiente duri più di due pagine, al massimo può arrivare a quattro. Vale qui , per lo spazio, quanto detto nella lezione precedente per il tempo. Lo spazio nel fumetto, non ha solo il valore grafico prima ricordato, ma corrisponde anche a un tempo diverso di lettura. E’ ovvio che se il lettore deve leggere molti balloon, impiegherà per quelle pagine più tempo di quanto non ne impieghi per delle tavole di pura azione senza balloon o con pochissimi balloon. Certo se queste tavole sono particolarmente interessanti sotto il profilo visivo, il lettore si soffermerà di più sulle immagini, ma in linea di massima nelle tavole in cui ci sono molte battute da leggere, il tempo di lettura necessario è più ampio di quelle in cui prevale il colpo d’occhio. Insomma: un fumetto con pochissimi dialoghi può apparire senz’altro più vivace di un fumetto con molti balloon, però il lettore si troverà a finirlo molto prima e potrebbe restare deluso per non aver letto abbastanza.
Scrivendo un fumetto è sempre bene tenere equilibrato il tempo di lettura. Dialoghi e azione vanno bilanciati con cura. Esagerare in dialoghi e spiegazioni, rallenta e stanca. Esagerare in azione lascia l’impressione che il racconto latiti o sia stato sbrigato troppo in fretta. In linea di massima vanno riservate più pagine all’azione, rispetto a quelle riservate al dialogo, se non altro perché le prime vengono lette più in fretta. Dunque uno stile equilibrato non è ad esempio otto tavole di dialogo e otto tavole d’azione. Le pagine di dialogo dovrebbero essere la metà. Naturalmente, ripeto, ciò attiene alle scelte stilistiche dell’autore, non è una regola valida per tutti e in tutti i casi, né vale per tutte le storie. Tenete però presente che una scena di dialogo come quella di Jonathan e Sandy in Conoscenza carnale è quasi impossibile da realizzare in fumetto: diventerebbe immobile, di una ripetitività grafica insopportabile e troppo lunga alla lettura. Un continuo botta e risposta a piccole frasi, in fumetto comporta una moltiplicazione delle vignette all’eccesso, oppure un’alternanza di balloon a gelato tra i due protagonisti che non si adatta alle caratteristiche grafiche di tutti i fumetti e che oltretutto comporta una distonia espressiva: il dialogo si sviluppa, mentre i due protagonisti restano espressivamente fissi. Se in cinema il rapido botta e risposta esalta i valori ritmici e accorcia, in fumetto accade esattamente il contrario. E’ particolarmente sintomatico sottolineare questo se si tiene presente che lo sceneggiatore di Conoscenza Carnale, Jules Feiffer, è anche un grande autore di fumetti. I fumetti di Feiffer sono egualmente molto dialogati, ma se li confrontate al suo film, non potrete non rilevare che in essi il dialogo risulta maggiormente condensato, in poche battute essenziali ed esemplari.
Prendo un altro esempio da un vecchio libretto che ho ritrovato , pubblicato nel 1959, quando ormai era già diffuso, con l’otto millimetri, il cinema amatoriale. All’epoca i ragazzi che si procuravano una piccola macchina da presa non si accontentavano più di usarla per immortalare matrimoni, nuove nascite, gite famigliari e scene varie di vita tra amici e parenti . Nasceva il film maker dilettante che già provava a girare dei piccoli film di pochi minuti, film in genere muti, perché pochi possedevano una camera con registratore e un proiettore sonoro. Questi piccoli film erano il più delle volte improvvisati, senza alcuna sceneggiatura. Manualetti come questo di Leopold Eugeen Vermeiren ,intitolato Brevi spunti e sceneggiature per i vostri film (Biblioteca del Cineamatore, Edizioni del Castello, Milano) si proponevano non solo di suggerire delle brevi sceneggiature, ma di mostrare praticamente come scriverle. Nel breve sketch filmato che ho scelto tra gli altri (alterandolo un pochino per stringere e per maggiore efficacia “didattica”) , si racconta l’attesa che precede un appuntamento galante.
- (PP) Interno di un salotto. Un orologio segna le cinque meno cinque. Accanto all’orologio sta una fotografia di Rosetta. Una mano la prende.
- (PP) Enrico , un tipo piuttosto corpulento, vestito molto bene come per un appuntamento galante, guarda teneramente la fotografia. Poi guarda l’orologio.
- (CL) Enrico va alla tavola apparecchiata a festa per due, sulla quale stanno bicchieri, vino e liquori. Nel mezzo c’è una grande torta.
- (CM) Con meticolosa cura, il tenore ritocca la decorazione della tavola e guarda di nuovo l’orologio.
- (PP) L’orologio segna le cinque meno due minuti.
- (CM) Enrico diventa po’ impaziente. Va alla finestra e guarda la strada.
- (PP) Un orologio alla parete segna le cinque precise.
- (CM) Enrico cammina nervosamente su e giù per la stanza. Guarda il suo orologio da polso, poi l’orologio da parete, poi di nuovo la fotografia di Rosetta.
- (PP) L’orologio segna alcuni minuti dopo le cinque.
- (PPP) La mano di Enrico tamburella nervosamente sul tavolo.
- (PP) Fuori dalla porta. Un dito preme il campanello.
- (PP) Nell’appartamento. Il volto di Enrico si rischiara felice.
- (CM) Enrico corre veloce alla porta.
- (PP) Appare oltre la soglia un ragazzo dell’Ufficio Telegrafico.
- (CM) Enrico , sconcertato, ritira un telegramma.
- (CM e PP) Di nuovo nel salotto. Enrico ha aperto il telegramma e lo sta leggendo. Lo abbassa, deluso e afflitto. Guarda verso la tavola imbandita.
- ( CM) La tavola imbandita.
- (CL) Enrico attraversa lentamente la stanza. Legge ancora una volta il telegramma. Si ferma di fronte alla fotografia.
- (PP) La mano di Enrico prende la fotografia di Rosetta e la gira verso la parete.
- (CM e PP) Enrico va alla tavola imbandita e si siede lentamente. Il suo sguardo vaga sulla tavola. Si versa un liquore. Poi prende un pezzo di torta.
- (PP) Enrico mangia la torta. Il suo sguardo è assente. Poi si concentra sulla torta. E’ buona.
- (PP) L’orologio segna le cinque e dieci minuti.
- (CL,CM, PP alternati) Enrico sta mangiando avidamente. Metà della torta se n’è già andata. L’espressione di Enrico è di intensa soddisfazione. Si è tolto la giacca e la cravatta, libero da ogni formalità. E continua ad abboffarsi.
In questa e altre scenette molto semplici, il primo scopo dell’autore del manualetto è insegnare come si scaletta una situazione, come si può scandire il tempo, e come alternare inquadrature molto semplici ( Primo Piano, Campo Medio,Campo Lungo) per dare un ritmo a una scena che in tempo reale risulterebbe noiosa. Come potete vedere, il tempo cinematografico non è tempo reale. Gli stacchi ci permettono la sintesi. L’insistenza sugli orologi segnala il passare dei minuti. Ma dieci minuti sono per il pubblico passati in pochi secondi. Ogni stacco ci ripresenta il protagonista in una situazione emotiva cambiata: da attesa fiduciosa ad attesa nervosa, da attesa delusa a delusione compensata. Abbiamo raccontato, senza bisogno di dialoghi, l’evoluzione degli stati d’animo del protagonista e anche il suo carattere: in fondo la sua vera passione è mangiare, della fidanzata poteva anche fare a meno.
Tuttavia questo è anche un tipico esempio di cosa fare quando non ci si può fidare degli attori, che nel caso di un film amatoriale non sono dei professionisti. In questo caso, staccare spesso e usare molti dettagli consente di evitare quei passaggi intermedi, da uno stato emotivo all’altro, che solo un attore esperto sarebbe in grado di esprimere. Se riprendiamo l’esempio fatto sopra a proposito della nostra scena della casalinga, difficilmente un attore dilettante saprebbe sintetizzare in un’unica posizione, in uno sguardo nel vuoto, lo stato d’animo del personaggio. In questo caso dunque, usare la telefonata permette una maggiore resa. Sarebbe velleitario cercare intensità espressiva in chi non può darla. Infine, riguardo all’uso abbastanza esasperato, nell’esempio di Enrico, dei primi piani, va osservato che al contrario di quanto si potrebbe pensare, il primo piano non è per un attore professionista il climax della sua performance. Un bravissimo regista di film western all’italiana ( Giulio Petroni) si trovò in Tepepa a girare con Orson Welles che interpretava nel film il ruolo del cattivo. Ora, nel cinema classico americano, i primi piani sono rari: vengono usati per particolari sottolineature, e in genere sono riservati ai protagonisti. Un bel primo piano, all’epoca, richiedeva anche una preparazione molto accurata delle luci . Il primo piano di una diva, destinato a fare di lei un’icona, poteva comportare anche una giornata intera di preparazione. Non era cosa da sbrigare al volo. Era un ritratto. Welles restò dunque stupito dalla quantità di primi piani girati alla svelta da Petroni , primi e primissimi piani per di più riservati spesso a semplici comparse e a figuranti. Ne chiese il motivo: “Perché tutti questi primi piani?” E Petroni osservò giustamente: “Il primo piano drammatizza. Anche un attore cane sembra un bravo attore.” L’abuso dei primi piani che si fa nelle novelas televisive non è soltanto dovuto ad ovvi motivi di dimensione dello schermo, ma anche al fatto che stringendo sulle facce, anche un attore poco espressivo risulta efficace.
Ora analizzeremo invece un altro caso. Un caso dove ci si può fidare degli attori (e del regista). Una scena che non può certo venire definita come di pausa o d’attesa e nemmeno come semplice approfondimento della psicologia del personaggio. Una scena molto complessa, tratta dalla Dolce Vita di Fellini. E’ la famosa scena finale. Sulla spiaggia c’è un mostruoso pesce morto che desta la curiosità di tutti. Ciascuno ha la sua reazione: stupore, indifferenza, divertimento, persino tenerezza. E il protagonista? Gli sceneggiatori scrivono:
- Marcello non sa staccare il suo sguardo da quello del pesce. Si direbbe che lo guardi come un messaggio da decifrare, giunto a conclusione di una nottata vuota e persa, o forse a conclusione di tutto.
Saggiamente, gli sceneggiatori ( Fellini, Flaiano, Pinelli, Rondi) non fanno esprimere verbalmente questo sentimento dal protagonista. Gli altri personaggi lo hanno fatto. Lui no. Non perché Marcello sia dipinto come un antisociale o un introverso. Ma perché Marcello stesso non ha parole per definire la sua emozione di fronte all’indecifrabile sguardo/messaggio del pesce. Sarebbe stata una pacchianata se Marcello avesse mormorato: è la fine di una nottata vuota, la fine di tutto… ( e quante pacchianate del genere si fanno nei film, soprattutto quando si vogliono sottolineare a tutti i costi i significati presunti “alti”!) Proseguiamo.
- Marcello si allontana di qualche passo. E’ sempre più nauseato, stanco, forse oppresso da oscuri presentimenti, da un’angoscia accumulata e che ora sembra stia toccando il fondo. Qualcosa però lo distrae…
- Sono piccole, dolci figure femminili apparse sulla spiaggia, dalla pineta. Si direbbero bambine. Esse si avvicinano al mare, tranquille, sicure, allegre,come sono le ragazze quando stanno in compagnia.
- Come sollevato da quella vista, Marcello le osserva attento, attratto, quasi già con un lieve sorriso sulle labbra. Si sentono le loro voci gaie e un po’ sciocche.
- Marcello, che aguzza lo sguardo come se ne riconoscesse una, getta via la sigaretta e va loro incontro con le mani in tasca.
-Sono di fronte.
- Marcello le sta a guardare con un mezzo sorriso. Tutte lo sorpassano occhieggiando e sorridendo, tranne una. Resta ferma davanti a Marcello: è timidissima, eppure lo guarda diritta negli occhi, educata e sicura.
Com’è stata narrata fin qui la scena in sceneggiatura? I tempi sono scanditi sui passaggi emotivi del protagonista rispetto a ciò che vede. Le definizioni di questi stati d’animo sono chiare eppure , se ci fate caso, sono molti i “forse” , i “sembra” , i “quasi” . Ciò definisce anche lo stile della rappresentazione: si vuole esprimere qualcosa di sottile, di indeterminato, qualcosa che non si è ancora fissato nella mente del protagonista e che tanto meno deve venire impresso nella mente del pubblico. Tanto sono inequivocabili nei loro giochi le ragazzine, tanto è, per contrasto, smarrito il protagonista . E di questo smarrimento noi spettatori dobbiamo essere partecipi. Tutto ciò può essere espresso perfettamente in un tempo “sospeso” e con una scena muta. Non bisogna avere paura delle scene mute. Sono cinema, come e spesso più delle scene fittamente dialogate. I problemi per la sceneggiatura iniziano infatti da qui. Da quando i due (Marcello e la ragazza) si parlano.
MARCELLO: Tu… come ti chiami?
PAOLA( stupita, ma lievissimamente, come se egli già lo dovesse sapere) : Paola !
MARCELLO: Ma noi… mi pare…ci conosciamo…
Paola accenna di sì, più volte, molto decisa, con la testa, con un sorriso tra trionfante e impacciato.
MARCELLO: Sai … che non mi viene in mente…
PAOLA: Lavoravo a Tor Vaianica… portavo da mangiare alla signora…
MARCELLO ( con allegra sorpresa) : Ah, sì… adesso mi ricordo: Paola…
Tutti e due sono stranamente lieti dell’incontro: c’è qualcosa di profondamente gioioso nella loro espressione.
MARCELLO: E cosa fai qui?
PAOLA (con naturalezza): Lavoro.
( ma si sente obbligata a precisare)
Qui alla Pensione Amalfi…
( e furbescamente nella sua assoluta ingenuità)
Si guadagna di più!
Paola ha un sorriso.
(Con un guizzo)
Adesso io e le mie compagne siamo venute a farci un bagno…
Guarda impaziente, infantile, allegra,verso le sue compagne, che tirandosi su le sottane, alcune, altre in costume, stanno bagnandosi le gambe poco più in là.
Si vede che ha molta voglia di raggiungerle, di stare con loro, di divertirsi con loro.
Marcello però ha ancora qualcosa, non sa nemmeno lui cosa, da dirle. Vorrebbe trattenerla.
MARCELLO: Aspetta…hai visto cosa hanno pescato? Vieni a vedere…
Priva di vero interesse per la cosa, ma incapace di dire no all’uomo, Paola lo segue verso il gruppo dei pescatori.
Il gruppo si è frattanto diradato. Gli amici di Marcello si stanno allontanando dall’altra parte, lungo la spiaggia. E alcuni pescatori sono già chini ad arrotolare le reti, al loro lavoro quotidiano.
Il pesce è ancora lì, sotto il sole. Ma ormai è superato: è un povero pescione morto.
Anche il suo occhio è come spento, forse perché camminandogli accanto, qualcuno gli ha fatto cadere sopra un po’ di sabbia.
MARCELLO: Vedi?
Paola guarda un momento il pesce : poi – benché sempre gentile e sorridente – alza lievemente le spalle come a mostrare che di quella bestia le importa poco.
PAOLA: E’ un pesce.
E, con un guizzo improvviso, corre verso le sue compagne. La sua corsa è un po’ esagerata ed è piena di una dolce goffaggine infantile. Correndo si volta un attimo verso Marcello , come per scusarsi, con inconscia crudeltà.
PAOLA: Addio!
Rimasto lì accanto al pesce, Marcello è incerto: non sa se seguirla, chiamarla…
MARCELLO (a voce quasi bassa): Paola!
Ma Paola corre, corre verso le sue compagne. A un certo punto si ferma, si toglie le scarpe, e continua a correre scalza.
Marcello si muove lentamente, andandole dietro. Essa è già laggiù, nella luce freschissima della mattina, che entra in acqua, raggiungendo le sue amichette. Si sentono le loro voci,le loro lunghe risate un po’ scioccherelle che non finiscono mai.
Marcello è preso da una profonda , inesplicabile commozione: ma non sa nemmeno lui se è per dolore o per gioia, per disperazione o speranza.
Così raggiunge il punto dove Paola ha lasciato le sue scarpe. Egli si china e le tocca; poi le prende in mano.
Sono delle povere, graziose scarpine da poche lire, un po’ scalcagnate.
La commozione di Marcello è struggente.
Guarda laggiù, nel mare fermo e luminoso, le ragazzette che impazzano felici misteriose messaggere di una nuova vita.
Così termina il film. Che la scena sia ben scritta non c’è dubbio. Eppure… guardatevi il film. La scena non c’è più. O meglio è stata radicalmente cambiata. Così descrive il cambiamento l’aiuto regista di Fellini Giancarlo Romani:
Il finale è il cambiamento più importante. Marcello, stanco e svuotato, si stacca dal gruppetto intorno al pesce e va a sedere sulla sabbia poco lontano. A questo punto Paola, che sta giocando con altre bambine oltre la foce di un piccolo fiume, lo vede e lo chiama. Marcello non la riconosce e il rumore del mare gli impedisce di sentire quello che lei gli grida. Così i due sulle due rive del fiume, si guardano a lungo sorridendo e cercando di capirsi con la mimica. (…) Finché la pittrice tedesca si stacca dal gruppo degli amici e prende Marcello per mano riconducendolo tra loro.
( Questo testo, come il testo della sceneggiatura, sono stati tratti dal libro La Dolce Vita, a cura di Tullio Kezich, Cappelli Editore 1959).
Insomma: da una scena molto parlata, con un lungo dialogo, a una scena muta e simbolicamente molto più efficace: i due sono separati da un fiumiciattolo, non possono raggiungersi, non riescono a sentirsi, vorrebbero comunicare, ma è impossibile. Non solo per il rumore del mare: sono troppo diversi. Quella allegra ingenuità, per Marcello è seducente, ma inattingibile. Una sua amica lo riporta nel gruppo.
Non si torna più sul pesce, ormai è veramente passato, non è più importante. La ripetizione sarebbe stata troppo voluta, forzata. Non c’è più la commozione, un po’ troppo patetica e retorica, di Marcello. Tutta la scena viene concentrata su un unico momento simbolico: Marcello non potrà mai ritrovare l’innocenza. Non ha neppure il tempo per rifletterci, per dolersene. E’ un fatto. Viene portato via e lui si lascia trascinare. Non può andare altrove.
Cosa se ne può dedurre? I dialoghi possono a volte spiegare troppo e così presumendo, aggiungere, divagare, allontanarsi dal centro espressivo, dire cose che non servono a niente ( lavoro alla pensione Amalfi), e venire sottolineati/contrappuntati troppo didascalicamente da immagini simboliche inequivocabili: il pesce non stupisce più nessuno, è un povero pescione morto; le scarpine di Paola raccolte da Marcello, trascinano metafore (ingenuità=povertà=semplicità); la commozione di Marcello comporta una presa di coscienza un tantino tardiva e ipocrita, una piangina da paradiso perduto che certo si attaglia poco al personaggio finora descritto e pare quasi una concessione a quel moralismo che il film di per sé rigetta. Se l’innocenza dev’essere “nuova innocenza”, qualcosa di indefinibile che sorge , allora non deve essere spiegata ricorrendo al passato, non può essere rimpianta. La speranza non sta in un ritorno agli antichi valori smarriti.
Di nuovo, il segreto è la sintesi. Bisogna stare molto attenti a non voler dire troppe cose, perché si rischia di sommergere l’unica che conta veramente. E’ la situazione di per sé che dev’essere esemplare. Se la si spiega troppo, la sua magia sfugge. Basta lasciar parlare le immagini. C’è un detto popolare che recita: “ A furia di togliere foglie da un carciofo alla fine non resta niente.” Carmelo Bene giustamente rovesciò il detto: “ A furia di togliere qualcosa resta.” Il lavoro del cinema è questo: giungere all’essenziale, fosse pure questo essenziale l’inafferrabilità di una visione. Certo non si può chiedere a uno sceneggiatore esordiente di pervenire subito a questo risultato. Ma fin dal principio è bene tenere in mente che per scrivere un buona sceneggiatura, bisogna imparare a togliere, a sottrarre. Non dovete dimostrare di saper scrivere tanto, ma di saper scrivere quello che conta, di centrare sempre il focus espressivo. Date un ritmo, un divenire alla scena. Non cercate di simulare il tempo reale, trovate il tempo giusto di quella scena. Non è indispensabile raccontarla inquadratura per inquadratura. Lo stile americano ( cui si ispirava il manualetto di Vermeiren sopra citato) è molto utile per conferire un ritmo al racconto e per farvi familiarizzare con la dinamica della “narrazione per immagini”. Lo stile classico italiano (come si può vedere dalla sceneggiatura di Fellini) è ricco di indicazioni per gli attori e di sfumature letterarie, molto attento nel precisare il senso di una scena, più libero nel non-suggerire inquadrature, ma d’altra parte ha anch’esso bisogno di tempi e scansioni precise, non può diventare (come purtroppo sta diventando da anni) un puro canovaccio. Il senso che volete dare alla scena e ai suoi singoli momenti dev’essere molto chiaro sulla carta. Può anche essere sbagliato, si potrà revisionare con una riflessione successiva. Ma è bene che sia preciso. Se il tracciato è chiaro, sarà chiaro anche nei suoi inciampi. Si presterà ad essere discusso e migliorato, anzi stimolerà gli attori e il regista in questa direzione. Se è indeterminato e vago produrrà sbagli molto più gravi, frutto dell’improvvisazione del momento, sbagli o passi falsi che poi non si potranno più correggere.
ESERCIZIO- In molti dei contributi e delle prove di sceneggiatura che mi giungono da voi, risulta evidente una scarsa attenzione all’immagine, tanto che basta leggere i dialoghi per capire la storia. Ma un film non è una sequenza di dialoghi . Il cinema nasce in assenza di dialoghi. Provate a riprendere in mano quello che avete scritto e pensate per un momento d’essere tornati all’epoca del muto. Fate in modo che siamo le immagini e quello che accade (o non accade) a raccontare la storia. Provate a narrare la stessa scena senza il dialogo.
La prossima lezione sarà dedicata ai dialoghi ed esamineremo cos’è un dialogo cinematografico e in cosa si differenzi dal dialogo scritto di un romanzo o dai dialoghi e/o pensieri di un fumetto.
9° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Uno dei più strenui detrattori del Metodo Syd Field che abbiamo analizzato nella scorsa lezione è il regista/autore brasiliano Ruy Guerra, che insegna cinema all’Università di Rio de Janeiro e lamenta, come molti autori europei del resto, l’influenza dominante di certi modelli industriali americani di narrazione cinematografica. Alla base dell’insegnamento di Ruy Guerra ci sono acute riflessioni sullo spazio e sul tempo nel racconto cinematografico. Qui lasciamo perdere lo Spazio che attiene a scelte di tipo registico più che di sceneggiatura e ci concentreremo sul Tempo. ,Traggo le informazioni dal documentario/intervista A linguagem do Cinema purtroppo non disponibile in italiano, ma se qualcuno di voi conosce il portoghese (o legge le didascalie in inglese) può trovarlo tra i contenuti speciali del Dvd Opera do Malandro (Coinceito Audiovisual), un musical del 1985 con musiche di Chico Buarque. Ruy Guerra osserva anzitutto che in un film, qualsiasi film, anche il più realistico, di realistico non c’è nulla. Di fronte alla proiezione di un film noi assistiamo ai fatti con una percezione assolutamente diversa da quella che abbiamo nella vita normale. Le diverse immagini sono inquadrate da più punti di vista (nella realtà noi ne abbiamo uno solo): la continuità e l’ordine tra questi differenti punti di vista è frutto del lavoro di montaggio. E’ inesatto sostenere che noi vediamo il film attraverso la macchina da presa. Noi vediamo un unico spettacolo che è il risultato della mescolanza di punti di vista differenti (inquadrature diverse), esperienza che non ci è dato vivere nella realtà e nemmeno sul set. Nel montaggio si attua una sintesi tra molti punti di vista, anche opposti (campo/controcampo) e tra tutti i punti di vista “girati” alcuni vengono scartati. Sullo stesso tema, ma da un’angolatura differente, anche Sergio Citti ebbe a dire: “appena si dice azione, la verità è finita.” Il regista romano, proprio lui per il quale le etichette di realismo, neo-realismo, realismo grottesco, si sono sprecate, voleva con ciò intendere che un film, qualsiasi film, non è una riproduzione della realtà, ma la raffigurazione di una realtà fittizia che ha regole diverse da quelle della vita quotidiana. Di questa realtà fittizia fa parte il Tempo del cinema, che non è lo stesso della vita reale. Nella vita reale, in cinque minuti non riusciamo a farci nemmeno un caffè, in un film in cinque minuti possono accadere moltissimi avvenimenti. Gli eventi in una sceneggiatura non potete raccontarli con i tempi della vita reale, bisogna stringere, concentrarsi sul momento focale della scena, sintetizzare il dialogo cercando la massima efficacia in poche righe. In altri casi, una sequenza che in sceneggiatura descrivete in due righe, può venire dilatata per esigenze espressive. Voi scrivete per esempio: “Lo Sceriffo attraversa la Main Street deserta”, ma ciò può dar luogo nel film a un’alternanza di inquadrature che ci fanno vivere la tensione del momento, la solitudine dello sceriffo, la desolazione di una città già fantasma, anche se il peggio deve ancora venire. E il ticchettio inesorabile di un orologio scandisce l’attesa rendendola più angosciosa. (Il film è High Noon, cioè Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann, 1952).
Esercizio - Infilate il VHS di un film qualsiasi nel vostro lettore e fatelo andare ad avanzamento veloce. Vedrete che mentre certe scene riuscite a coglierle, altre diventano illeggibili perché l’alternanza delle inquadrature nel montaggio è troppo rapida. Quasi sempre, sono le scene d’azione ad esigere un numero maggiore di punti di vista (e di inquadrature) montati in modo serrato.
Questo significa che il tempo di un film non è affatto uniforme: una scena ferma di dialogo tra due personaggi seduti al tavolo di un bar può durare di più di una scena d’azione nella quale all’improvviso delle bande criminali fanno irruzione nel bar e scatenano una sparatoria (un maestro di questa alterazione dei tempi è Michael Cimino, il film è Year of the Dragon del 1985). La durata del dialogo rispetto all’azione, non significa affatto, narrativamente, che il dialogo è più importante di quanto accade dopo. Il dialogo è dilatato perché ciò conferisce più potenza all’inferno che si scatena successivamente. Il contrasto tra questi due tempi rende trascinante l’intera scena. Essere presenti sui set dove si girano i film è un’esperienza che tutte le scuole di sceneggiatura giustamente raccomandano agli sceneggiatori debuttanti perché si abituino a capire cos’è un film in concreto, nel suo farsi giorno dopo giorno, frammento dopo frammento. Ma altrettanto utile, forse anche di più, è per un aspirante sceneggiatore frequentare una sala di montaggio per capire quale lavoro si fa sul ritmo delle immagini, sui tempi della narrazione ( e quante sequenze si scorciano per ottenere una resa più efficace). Il lavoro dello sceneggiatore è più vicino a quello del montatore (il quale monta le immagini con la sceneggiatura sotto mano) che a quello del regista. A sua volta il regista spesso si trova a ripensare una scena scritta e a girarla in un altro modo perché ha in mente un certo montaggio, un certo tempo della narrazione. Se lo sceneggiatore è consapevole di queste esigenze, potrà scrivere una sceneggiatura più adeguata.
2. Tempi del dialogo
Umberto Eco, nelle postille al Nome della Rosa e in diverse interviste, ha sostenuto che il suo romanzo si prestava particolarmente al cinema, perché scrivendolo aveva immaginato i dialoghi in tempo reale. Ad esempio si era raffigurato il cortile di un convento con una certa lunghezza e nel suo romanzo aveva condotto il dialogo tra due monaci nel tempo (reale) del loro percorso lungo il cortile. Secondo Eco, questo è cinema. No, questo è il contrario del cinema. Il cinema non basa i suoi tempi sui tempi reali, ma sul tempo scandito dal montaggio (e preparato in sceneggiatura). Questo Tempo non ha nulla, ma proprio nulla di realistico. Riguardo specificamente al dialogo, ciò non vuol dire che il dialogo debba diventare un puro codice, un linguaggio neutro e/o di maniera, telegrafico e rivolto soprattutto a fornire informazioni essenziali alla comprensione della storia. Anche se la realtà del cinema è altra cosa rispetto alla vita, un film racconta comunque i rapporti tra persone, non tra burattini. Quando uno sceneggiatore scrive un dialogo “neutro” senza caratterizzazioni oppure troppo letterario, si sentirà quasi sempre dire dall’attore che deve interpretarlo: “adesso devo mettermelo in bocca”, il che significa che l’attore cercherà di fare propria la battuta, di darle un’espressività consona al proprio personaggio, un contento emotivo più evidente, di cambiarla rendendola meno scritta e più parlata. Nei “parlati” della vita reale ci sono una quantità di pause, ripetizioni, interruzioni, parentesi. Di rado il discorso è univoco, centrato su un obiettivo definito, spesso circoscrive un problema, ma non va dritto al suo centro. Questo nei dialoghi di un film risulterebbe noiosissimo: presumere che si possa tranquillamente trasferire un dialogo quotidiano in una scena cinematografica è in linea di massima sbagliato. Ma sarebbe sbagliato anche spogliare il linguaggio da ogni senso di veridicità, facendo adoperare ai personaggi una lingua di pura convenzione che non esiste in nessuna conversazione reale. Inflessioni, caratterizzazioni, pause,vanno sfruttate perché sono preziose sotto il profilo della veridicità e dell’espressività. Sui problemi del dialogo torneremo più avanti, ma suggerisco fin d’ora un esercizio utile ai fini di individuare i giusti tempi di un dialogo.
Esercizio – Infilatevi un registratore in tasca e registrate una conversazione di nascosto. E’ meglio se non siete coinvolti nella conversazione, anzi l’ideale sarebbe che le due o più persone che stanno conversando e che state registrando fossero per voi dei perfetti sconosciuti. In questo modo vi mettete dal punto di vista di uno estraneo (lo spettatore) che cerca di capire non solo i contenuti della conversazione, ma la personalità di chi sta parlando, i retroscena, cioè quel non detto che tra le persone che dialogano è dato per assodato, ma che noi non conosciamo affatto. Trascrivete la conversazione. Vi renderete conto anzitutto che una banalissima conversazione può nella realtà durare quanto un film intero, e poi che in molti passaggi il contenuto non è affatto chiaro, che la comunicazione spesso divaga, si avvita, che si impiegano troppe parole, qualche volta anche sbagliate, per esprimere concetti semplici. Noterete però che qua e là nel dialogo affiorano delle vere perle espressive: linguaggio non scritto e neppure abituale perché legato alla personalità di chi parla, ma capace di rendere una situazione, uno stato emotivo, in poche, efficaci parole. E i punti in cui l’altro interrompe, per sollecitare chiarimenti, per obiettare, non sono casuali. Nella conversazione tra due persone non c’è solo la comunicazione di un contenuto “oggettivo”, ma vi si esprime la relazione tra due caratteri, il loro interagire. Adesso prendete la trascrizione della conversazione e cominciate a ridurla, in modo da concentrarla progressivamente sul suo contenuto espressivo essenziale. Se una conversazione a tavola nella vita può durare per tutta la durata del pasto, in cinema sarà una scena di un minuto. Non è un semplice riassunto/sintesi che dovete fare, ma una specie di “dado”: il brodo c’è lo stesso, ma concentrato. Dicendo che il brodo c’è lo stesso, voglio intendere che le pause, le caratterizzazioni, le incertezze, le asperità di una normale conversazione devono restare, ma in un tempo ristretto. Il brodo va in qualche modo “solidificato”. Ma state anche bene attenti a non perdervi quelle “perle” che di per sé sono delle “epigrafi” , sono “scolpite”, cioè sanno rendere efficacemente il contenuto essenziale (della conversazione come del rapporto in atto tra le persone che conversano) attraverso una metafora, un motto, una definizione colorita che può assumere un valore esemplare (es: “i furbetti del quartierino”). E’ importante imparare dalle conversazioni reali, essere ladri di linguaggio. Proprio perché la lingua di un film è parte di una narrazione, cioè di una realtà fittizia, è essenziale che risulti credibile e che conservi quella stessa capacità di inventare linguaggio che è propria delle conversazioni quotidiane . Il doppiaggio ci ha abituati a un linguaggio di codice estremamente lontano dalla vita reale, una lingua che nessuno parla. Ma se ascoltate lo stesso dialogo in originale scoprirete facilmente quanto sia più ricco di sfumature, di inflessioni e di “veridicità” (insisto su questo termine perché “veridico” è in cinema l’unico possibile equivalente di “vero”). Se scrivete i dialoghi di un film scansate con cura la tentazione di scrivere nella lingua generica del doppiaggio: scrivendo nella nostra lingua, dobbiamo usare la lingua delle persone che ci circondano. La lingua è nostra in quanto collettiva, ri-conoscibile.
3. I tempi emotivi
Che la narrazione cinematografica debba essere rapida (abbiamo a disposizione un’ora e mezza o due per raccontare la nostra storia, non possiamo farla durare quanto pare a noi) non significa affatto che debba essere frettolosa e superficiale. Prendiamo ad esempio due film, molto diversi e lontani tra loro. Il primo è The Penalty di Wallace Worsley, con Lon Chaney (1920). E’ stato di recente pubblicato in Dvd dalla Kino Video e se anche lo ordinate in edizione originale senza conoscere l’inglese… è un film muto, dunque potete godervelo lo stesso. Se sapete l’inglese, però, è meglio perché nel Dvd , tra i contenuti speciali, c’è una Scene Comparison cioè un confronto tra le pagine del romanzo (da cui il film è tratto), quelle corrispondenti della sceneggiatura e le scene/inquadrature realizzate nel film. Questo confronto vi farà capire perfettamente i passaggi tra le differenti versioni della stessa storia (romanzo, sceneggiatura, film). (I film muti, sia detto per inciso, non vanno trascurati, perché la scansione dei tempi della narrazione cinematografica inizia da lì. E lì si sono affrontate e vinte le battaglie in teoria più impossibili: ad esempio trarre un bellissimo film da un complesso capolavoro letterario come L’Uomo che ride, senza neppure potersi avvalere dei dialoghi. Altro che chiacchierate in tempo reale!). Il secondo film è invece molto più recente e apparentemente non ha nulla a che vedere con il primo. E’ L’Uomo Ragno di Sam Raimi. Ma come cercherò di mostrarvi confrontando due scene di questi due film, ci sono regole della narrazione per immagini che a ottanta e passa anni di distanza non sono cambiate e che hanno a che fare con l’argomento di questa lezione: il Tempo del Cinema. E in particolare con un aspetto: come rendere i passaggi emotivi che caratterizzano lo sviluppo di un’azione.
a) The Penalty
Lon Chaney interpreta nel film uno spietato gangster incattivito con il mondo intero perché quand’era ragazzo, dopo un incidente che gli era occorso, un giovane medico inesperto, lo aveva curato con frettolosa imperizia, amputandogli le gambe. A distanza di anni, Chaney scopre che la figlia del medico (ormai diventato un rispettato professionista), appassionata scultrice, cerca un modello per un scultura molto particolare: un busto di Satana. Chaney riesce a farsi prendere come modello, in fondo chi meglio di lui: non solo è una figura davvero diabolica, ma è per tragica ironia un busto umano vivente. Chaney vuole attuare una sua strategia vendicativa: affascinare la figlia del dottore, magari suscitando la sua pietà, per legarla a lui e vendicarsi così dell’operazione subita da parte del padre della ragazza (il piano in realtà è più intricato, ma qui è inutile addentrarsi nella storia). La scena che analizziamo è assai complicata. Ormai il lavoro è quasi finito. La ragazza dice al suo modello: “Come posso ringraziarvi per l’aiuto che mi avete dato?” Lui ha un fremito, quasi di tenerezza ( dunque si è innamorato!) e ne resta confuso. Risponde: “A lavoro finito, restiamo in contatto.” Lei ha uno sguardo perplesso e diffidente. Lui si lancia in un’appassionata dichiarazione d’amore. Lei ne resta sorpresa e raggelata. Prova sentimenti contrapposti : incredulità, spavento, pietà… finché scoppia in una risata isterica. Lui incupisce. I suoi lineamenti si distorcono in un’espressione di odio. Cerca di afferrare la ragazza e cade a terra. Si risolleva inferocito e si trascina verso di lei che fugge atterrita per poi bloccarsi sulla soglia, in ansia. “Quasi istantaneamente “ (precisa la didascalia) lui realizza d’aver perso il controllo, rivelando la sua natura malvagia e i suoi scopi vendicativi. Finge di sentirsi male, simula un’intensa sofferenza interiore, prende tempo cercando di rimediare all’errore commesso. Si batte il petto e si proclama disperatamente infelice, chiede perdono per aver pensato a lei come oggetto dei suoi impossibili desideri. Lei si calma. Lui spiega che la risata di lei per lui è stata come acido versato sulle ferite interiori. Scruta l’effetto delle sue parole. Lei si torce le mani, a disagio. Gli spiega d’aver riso nervosamente: lui l’aveva spaventata. Rientra nella stanza. Lui capisce d’avercela fatta. Di nuovo le chiede perdono.
Siamo dunque di fronte a un’azione molto barocca e difficile da rappresentare (nel Dvd potete confrontarla con la corrispondente descrizione del romanzo e con la prima traccia di sceneggiatura) dove si passa per stati d’animo contrapposti e per contrapposte azioni: è tutto un esprimere e un dissimulare. Quanto tutto ciò sia ben lontano dalla vita reale dovrebbe esservi evidente: nella realtà un simulatore contiene le sue emozioni, sempre, qui invece non si contiene affatto: è sincero quando si infuria, è esageratamente teatrale quando finge, è esplicito nei passaggi perché le sue passioni intime si rivelano nelle espressioni del suo volto e nel suo atteggiamento. Questa non è solo la grammatica del cinema muto, è la grammatica del cinema: didascalie o meno, l’interiorità va esteriorizzata perché il pubblico possa capire. L’atto rivela l’animo, il discorso interiore , i pensieri intimi, si fanno esteriori, manifestandosi in comportamenti ed espressioni. La scena è condotta su una dinamica emotiva. Nella sua brevità, non trascura nessun singolo passaggio. C’è in questa scansione sequenziale minuta qualcosa del fumetto: un congelare i singoli istanti in frammenti inequivocabili, ciascuno di quali descrive figurativamente un meccanismo psicologico in atto. Se l’azione è rapida, non è tuttavia sbrigativa. Ogni singolo passaggio viene espresso in un tempo concentrato. Non si cancella la dinamica psicologica, la si esplora per rapidi frammenti.
b) L’Uomo Ragno
Il giovane Peter Parker manifesta all’improvviso i suoi superpoteri. Non essendo ancora consapevole d’essere diventato un Uomo-Ragno, è talmente sconvolto dalla scoperta che fugge e si nasconde in un vicolo. L’espressione del suo volto rivela che non ha capito cosa gli è accaduto e che se lo sa chiedendo. Si guarda il polso, dove ha una strana cicatrice a forma di ragnatela. Là dove è stato punto da un ragno, è rimasto uno strano arrossamento della pelle. Cambia l’inquadratura, ora è più all’alto, con in PP una grossa ragnatela. Peter alza il capo e la guarda. Ha un sospetto. Torna a guardarsi la mano. L’inquadratura adesso è un macro-ingrandimento quasi da microscopio.Notiamo delle bizzarre inflorescenze che spuntano dai pori della mano di Peter: non sono esattamente peli, somigliano a zampe di ragno, con appendici prensili. Peter appoggia il palmo della mano contro il muro. Avverte che i suoi polpastrelli hanno acquisito un tocco “da ventosa”. Comincia a risalire il muro. Ci riesce. Esulta.
Come vedete, anche se siamo in un film sonoro, abbiamo anche qui una sequenza muta, persino più muta di quella di The Penalty, perché senza didascalie e perché c’è un solo personaggio in scena, in preda a turbamenti interiori. Uno sceneggiatore distratto probabilmente lo avrebbe fatto parlare da solo, perché esprimesse ad alta voce il suo sconcerto “cosa mi sta succedendo?” , “cos’è questa cicatrice?” “Sì, qui è dove mi ha punto il ragno” eccetera. Ma la sequenza avrebbe perso efficacia. Noi pubblico dobbiamo vedere quello che vede Peter Parker e fare lo stesso ragionamento che sta facendo lui. Così la rappresentazione è veramente efficace. Anche qui, come in fumetto, ogni singolo passaggio viene mostrato, ogni azione corrisponde a un tempo psicologico, a un ragionamento. Le singole fasi, dallo sconcerto iniziale alla riflessione, dalla rivelazione all’esultanza finale, ci sono tutte. Nulla di tutto ciò è realistico: nel tempo reale passare da un trauma alla scoperta che ciò che ci è capitato e che ci ha spaventato è invece una nuova opportunità, un potere acquisito di cui essere fieri e felici, è un processo molto lungo e complesso. Qui viene sbrigato in un minuto. Eppure è verosimile, ci appare tale, perché nessun passaggio viene trascurato. Questo è il tempo concentrato del cinema.
Esercizio – Riprendete il vostro protagonista. Qualunque sia il percorso narrativo che avete previsto per raccontare la sua storia, ci sarà senz’altro (deve esserci) un momento in cui il protagonista entra in conflitto non solo con le difficoltà esterne, ma anche con se stesso. E’ un momento cruciale, in cui egli affronta le proprie contraddizioni e le supera dopo un conflitto interiore. Provate a scandire i singoli momenti, le fasi di questo conflitto. In altre parole , scalettate una singola scena , frammentandola in istanti, e cercate di esprimere in ciascuno di questi istanti la soluzione che si fa largo nella mente del protagonista. Potrebbe essere una scena a due (le esitazioni, gli avanti e indietro, i passi falsi in una dichiarazione d’amore), oppure un “a solo” (cosa devo fare? Come posso uscire dalla situazione problematica in cui mi trovo). Ma ricordate che questo conflitto dev’essere “esternato”, espresso in atteggiamenti esteriori che rendano chiaramente decifrabile al pubblico il percorso psicologico attraversato dal protagonista. In sceneggiatura, precisate i singoli passaggi. Non si tratta tanto di fornire indicazioni all’attore, ma di scandire la scena perché il racconto risulti verosimile ed efficace.
8° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
E’ un po’come alla scuola guida. Le lezioni che insegnano i componenti e il funzionamento del motore, possono venire considerate da chi le segue noiose e superflue: “Sono qui per imparare a guidare. Insegnami i comandi e i segnali stradali da rispettare, non mi interessa come l’auto funziona in sé, nei suoi meccanismi. Se non funziona bene o se si scassa ci penserà il meccanico.”
1. La curva dell’attenzione
Durante il servizio militare ebbi occasione di assistere alla proiezione di un filmato didattico prodotto dalla NATO. Sorprendentemente, ogni tanto il filmato veniva interrotto dall’apparizione di Mickey Mouse che suonava la tromba per risvegliare l’attenzione assopita degli spettatori. Ci venne in seguito spiegata la teoria che stava alla base di questa “trovata”. L’attenzione del pubblico ha un ciclo di circa venti/venticinque minuti. Parte abbastanza sostenuta e raggiunge il suo picco dopo i primi sette/dieci minuti, poi cala costantemente fino a raggiungere il minimo dopo, appunto, venti/venticinque minuti. Se la lezione continua oltre questo limite, l’attenzione risale mantenendosi abbastanza costante per altri venticinque minuti, ma non raggiunge mai l’apice dei primi dieci minuti. Lo sforzo di un comunicatore, dunque, deve essere duplice: usare i primi dieci minuti per fissare le informazioni fondamentali nella mente dello spettatore, e poi rallentare la caduta dell’attenzione, mantenendola alta con piccole “scosse”, “svolte narrative” o “colpi di scena”. Dato che i militari non vanno tanto per il sottile, il trucco escogitato ( l’apparizione divertente di Topolino e lo squillo improvviso di tromba) presuppone che a quel punto l’allievo (dopo il bombardamento informativo dei primi dieci minuti) abbia ormai le palpebre semi-abbassate e stia per crollare nel sonno. E’ evidente che siccome alla base dei processi di attenzione c’è la motivazione del soggetto, un conto è assistere per obbligo a un noioso filmato didattico, tutt’altro conto è andare al cinema, pagare il biglietto per uno spettacolo che si è scelto, e, in un ambiente raccolto che non consente molte distrazioni, assistere a un film che si presuppone di proprio gradimento. Tuttavia la Curva dell’Attenzione è stata presa molto sul serio dagli studiosi delle tecniche di comunicazione verbale, dai pubblicitari , dai produttori di programmi televisivi e, in misura crescente nel corso degli anni dal cinema americano, sempre più orientato all’Industria dell’Intrattenimento, più che alla creazione artigianale/artistica . Prendiamo ad esempio un film recente: Van Helsing di Stephen Sommers, che pare in preda a una vera ossessione di “mantenimento dell’attenzione”, cosa che si crede di ottenere con l’accumulo di scene d’azione al limite della congestione, supportate da musiche roboanti. E’ questo per la verità, un eccesso che può facilmente portare all’effetto contrario. I vecchi maestri dell’horror sapevano bene che le punte massime di tensione si ottenevano con il silenzio. Esagerare gli effetti visivi e acustici può condurre lo spettatore a una sorta di sonno ipnotico: il cervello, per difendersi dall’aggressione,”stacca” e lo spettatore si addormenta. Supporre che l’attenzione possa essere mantenuta alta con continue e aggressive “trovate” invece che con l’interesse del racconto e una sapiente regolazione dei ritmi narrativi, è pericolosissimo per chi fa cinema. Nelle scuole di sceneggiatura americane hanno però preso piede nel tempo teorie di segmentazione di ogni istante del racconto che sempre più rigidamente fanno riferimento agli studi sull’attenzione, prescrivendo passaggi obbligati di racconto al fine di stimolare costantemente il pubblico. La più celebre e influente di queste teorie è dovuta a Syd Field, lettore di sceneggiature e consulente di molte grosse major, docente di numerosi corsi per aspiranti sceneggiatori e autore di diversi libri e manuali sul tema. Ne potete trovare una puntuale spiegazione, con esercizi,nel suo libro The Screen-writer’s Workbook ( Exercises and Step-by-Step Instructions for Creating a Successful Screenplay) (Dell Publishing) , che qui di seguito analizzeremo sinteticamente e criticamente. Già fin dal titolo, comunque, risulta molto chiaro che per Syd Field, il successo di un film risiede in una sceneggiatura che applichi in ogni suo segmento delle precise regole di comunicazione.
2. Il metodo di Syd Field
a) Il modello base
Syd Field definisce un modello base di film: durata due ore circa di proiezione, suddivise in centoventi scene, dunque della durata media di un minuto. E un minuto di narrazione visiva corrisponde all’incirca ad una pagina di sceneggiatura. Dunque la lunghezza media di una sceneggiatura di un film di due ore, è di circa centoventi pagine.
Nulla da eccepire, fin qui. Un simile modello può venire definito “medio” ormai da molti anni, anche se il cinema delle origini conosceva una varietà molto maggiore di format ,varietà che l’attuale produzione di film in video sembra poter riportare in auge. Comunque, a questo modello possiamo tranquillamente attenerci.
Una prima istruzione si può già ricavare: i tempi narrativi di un film sono molto stretti e concentrati. Non dimenticate mai che dovete raccontare la vostra storia in un paio d’ore. Un film non è un romanzo che può durare quanto pare a voi. Ogni fase del racconto deve venire sviluppata in riferimento al tempo globale della narrazione. In sostanza: evitate di scrivere scene troppo lunghe. I tempi di un film, anche del più realistico dei film, non sono affatto “realistici”, non imitano cioè quelli della vita reale, li ricreano. Quando scrivete una scena, buttatela pure giù come vi viene, ma poi controllate quante pagine vi ha preso, rileggetela da capo figurandovela nel suo svolgersi, recitatene i dialoghi ad alta voce, cronometrate la sua durata. Se la scena si prolunga per troppi minuti , se occupa troppe pagine, cancellate tutto quanto è superfluo concentrandovi sul suo contenuto essenziale, su quel che serve veramente al racconto e sulle punte espressive. Se, per esempio, tutte le volte che un personaggio viene a contatto con un ambiente, voi lo fate entrare, ci descrivete il modo in cui si presenta agli altri, ciò che fa e che dice, e poi concludete con la sua uscita dall’ambiente e magari proseguite con una scena di passaggio in cui si sposta da questo all’ambiente successivo, be’ tutto questo risulterà alla fine di una lentezza mortale, ammorbante per lo spettatore. Meglio mostrare il nucleo dell’azione già in corso, eliminando testa e coda. Inoltre evitate, se non strettamente indispensabile, di allineare le scene con un ordine prevedibile e scontato. Luis Bunuel disse: “Se alla conclusione di una scena un personaggio dice all’altro: ci vediamo all’Hotel Ambassador, la scena successiva non può essere ambientata all’Hotel Ambassador. Dovunque, ma non lì.” Questo genere di raccordi tra scena e scena possono essere comodi e a volte anche utili, ma se insistiti, finiscono per negare una regola fondamentale del cinema: il racconto procede a stacchi. Su questo punto torneremo in seguito.
b) Suddivisione della sceneggiatura
- I Tre Atti
Syd Field suddivide una sceneggiatura in tre momenti fondamentali, cioè tre Atti. Nel Primo Atto, la presentazione del /dei protagonisti e della situazione (d’ambiente e di tema); nel Secondo Atto lo sviluppo, cioè il complicarsi della vicenda con l’ingresso di altri personaggi e con l’insorgere di conflitti e difficoltà; nel Terzo Atto, lo scioglimento, cioè da un lato il compimento delle premesse implicite nell’inizio, dall’altro il superamento delle difficoltà incontrate in senso positivo (il protagonista ce la fa) o negativo ( il protagonista soccombe).
Si può osservare che la divisione di un racconto in questi tre momenti, non è specifica del cinema, ma può applicarsi a molte altre forme di racconto ( musicale, letterario, teatrale) . Ogni racconto, ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Questa è certamente una struttura fondamentale, anche se bisognerebbe aggiungere che non è affatto, al contrario di quanto comunemente si crede, l’unica forma possibile di racconto. La struttura di un racconto può essere, ad esempio, anche circolare ( nel caso in cui il finale riproduca l’inizio) , oppure per frammenti, o anche trasgredire un ordine narrativo cronologico con un prima e un poi, o ripercorrere sempre la stessa vicenda, ma da diversi punti di vista, a partire dai quali la vicenda non ci appare mai come la stessa. Non è nemmeno infrequente che il racconto resti totalmente aperto e non si concluda affatto. Tuttavia la divisione in tre atti resta la struttura fondamentale di un racconto e specie in chi comincia ad affrontare i problemi della scrittura, è consigliabile attenervisi se non altro per dare un ordine alle idee e alle diverse fasi del racconto. Dunque quando pensate una storia e ne scrivete il soggetto, tenete sempre presente questa tripartizione e fissate in modo chiaro quali debbano essere l’inizio, lo sviluppo e la conclusione. Questo primo schema non esclude che in corso di scrittura voi poi non possiate cambiare questo previsto a priori per le singole parti. Per molti scrittori è molto più importante la scrittura stessa che la programmazione, cioè per questi scrittori le linee fondamentali di una storia emergono nel concreto, mentre la storia viene scritta. E’ scrivendo che spesso vengono in mente sviluppi e svolte che a freddo non avevamo previsto. Altri scrittori invece non riescono proprio ad andare avanti se non hanno chiaro fin dal principio il percorso complessivo degli eventi, per loro la scrittura è l’esecuzione di un progetto. Nessuno può sostenere che sia migliore uno scrittore del primo tipo o uno scrittore del secondo tipo. Questo non ha nulla a che fare con l’Oggetto Racconto, ha invece a che fare con il Soggetto Scrittore . Finché non avete scoperto bene che tipo di scrittore siete, è saggio mantenere una via mediana e cioè: scrivete una scaletta di quanto vi proponete di raccontare, a partire dai tre momenti fondamentali ( inizio, sviluppo e conclusione) e mettendo in ordine, all’interno dei singoli momenti, le diverse cose che prevedete debbano accadere, ma non applicate troppo rigidamente questa scaletta e all’occorrenza cambiatela se dalla scrittura concreta emergono in voi idee e spunti che vi spingono a modificare (con maggiore o minore radicalità) il progetto originario.
Tuttavia questa suddivisione in Tre Atti, come si è osservato al principio, non ci dice ancora nulla sulla specificità del racconto cinematografico e dunque Syd Field non si limita a questa prima indicazione, spingendosi oltre, nell’esame scrupoloso di ogni singolo Atto ( nella sua specificità cinematografica) e delle diverse fasi narrative all’interno di ogni singolo Atto.
Qui le indicazioni diventano estremamente minute e richiederebbero troppo spazio per essere esaminate. Mi limiterò dunque ai cenni fondamentali, rinviando chi fosse interessato ad approfondire, al testo sopra segnalato di Syd Field.
- Equilibrio delle parti
Anzitutto Syd Field ripartisce così i tempi dei tre Atti. Primo Atto , dalla scena 1 alla scena 30. Secondo Atto, dalla scena 31 alla scena 90. Terzo Atto dalla scena 91, alla scena 120. Cioè nell’equilibrio generale, lo sviluppo (il Secondo Atto) deve occupare pari spazio al Primo e al Secondo Atto sommati. Cioè significa , come indicazione agli aspiranti sceneggiatori, che la Presentazione non deve prolungarsi troppo, per non tradire l’attesa del pubblico che si entri nel cuore della vicenda vera e propria, e che la conclusione non deve essere “sbrodolata” . Anche qui, come indicazione di massima può risultare utile, ma non sta scritto da nessuna parte che obbligatoriamente un racconto cinematografico debba essere scandito così e con questi tempi. Né è obbligatorio che il racconto debba essere per forza equilibrato nelle sue parti, questa è una scelta che riguarda l’autore, è un fatto eminentemente stilistico che non può venire prescritto, pena la riduzione di ogni autore ad esecutore di progetti industriali pre-formattati nei dettagli.
Ora: è proprio questa seconda opzione che viene scelta da Syd Field,il quale proseguendo nell’esame dei singoli Atti, prescrive ad esempio, nel caso del Primo, una ulteriore tripartizione: tre momenti di dieci minuti ciascuno, dedicati alla progressiva individuazione del focus narrativo, cioè dai primi dieci minuti in cui necessariamente la presentazione è più generale e generica, ai secondi dieci minuti in cui si individuano con maggiore precisione il carattere del protagonista e il tema da narrare (quello che ci interessa di più tra i tanti possibili), al terzo segmento in cui si stringe ancora di più su un protagonista che ha ormai definito il suo obiettivo e sul nucleo centrale della vicenda.
Ma Syd Field non si ferma a questo. Prescrive ai suoi studenti di stendere una scaletta estremamente precisa e dettagliata, al punto da suddividere la vicenda nei suoi singoli istanti, cioè tutte le cose che devono accadere, una per una, ciascuna da appuntare su un foglietto separato e numerato. Si prescrive anche un certo numero di foglietti per ogni segmento dell’ Atto, in modo da poter assegnare un ritmo preciso e ordinato alla narrazione.
Esaminerò nella prossima lezione alcune reazioni degli autori di cinema a questo modo di intendere e di organizzare il lavoro di scrittura, qui per non rendere troppo astratto il problema, ho cercato di sottoporre la indicazioni di Syd Field a una verifica sperimentale, cui egli stesso invita i suoi allievi.
Cioè per stabilire se queste indicazioni servano davvero a individuare il Modello Vincente di racconto, cioè la Sceneggiatura di Sicuro Successo, ho scelto abbastanza a caso quattro film, di epoche, di stile e di genere molto diversi tra loro, ma tutti egualmente premiati da un indubbio successo sia sul piano commerciale che su quello dell’apprezzamento estetico. Ho esaminato questi film al videoregistratore, cosa che ciascuno di voi può fare, per vedere se effettivamente il loro modo di scandire la vicenda corrisponda allo schema tracciato da Syd Field.
- A qualcuno piace caldo ( di Billy Wilder)
Il film inizia come un film d’azione tipicamente gangsteristico: inseguimenti, sparatorie, irruzioni della polizia in bische. Dopo una decina di minuti così, si presentano i due protagonisti (due musicisti di jazz) Jack Lemmon e Tony Curtis che scappano nel corso di una retata e poi cercano, invano, un altro ingaggio. Al quindicesimo minuto, apprendono che l’unico ingaggio possibile è in un’orchestra femminile. L’altra protagonista del film, Marilyn Monroe, compare solo al minuto 24 (in singolare coincidenza, si può osservare, con la prevedibile flessione della curva dell’attenzione. Nel caso, bastano altre curve a risollevare subito il pubblico).
Grosso modo si può affermare che questo film non smentisce affatto il modello di Syd Field, anche se presenta una sua indubbia originalità per esempio presentandoci un lungo prologo d’azione, quasi che non si trattasse affatto di una commedia, ma di un film di gangster. Nei primi dieci minuti , i veri protagonisti non ci sono neppure. Questo film è dunque un prezioso esempio di come lo schema possa ( debba, direi) venire interpretato con la massima libertà creativa e non venir inteso come una “gabbia” entro la quale incastonare gli avvenimenti.
- L’esorcista ( di William Friedkin)
Dopo un misterioso flash urbano iniziale (notturno, su una casa normale, ma immersa in un’atmosfera spettrale) il film si sposta su un lungo prologo assolato nell’Iraq del nord, dove sono in corso scavi archeologici nel corso dei quali Max Von Sidow rinviene una statuetta di un demone e ha in seguito oscure premonizioni e visioni, si torna poi con uno stacco brutale allo scenario metropolitano. Dopo questi primi dieci minuti di racconto, ci vengono presentati i personaggi della madre di Reagan e di Reagan stessa ( un ragazzina posseduta dal demonio, ma non lo sappiamo ancora) . La madre è un’attrice e sta studiando un copione per la scena che dovrà girare il giorno dopo e , verso l’alba, viene destata da strani rumori che sembrano provenire dalla soffitta. Reagan, appura la madre, non si è svegliata e pare dormire placidamente nel suo letto. Il film prosegue con un tono di racconto del tutto anti-avventuroso, come una normale storia di vita quotidiana. Il percorso narrativo è reso in modo non lineare , anzi del tutto spiazzante, quando vediamo che il film in cui la madre di Reagan recita, è un film tipicamente anni 70 sulla Contestazione. Il racconto prosegue molto lentamente da qui in poi, facendoci intendere che Reagan soffre di qualche misterioso disturbo che richiede esami clinici, ed è solo dopo 45 minuti di film che questo genere di disturbi si manifesta in un’azione davvero inquietante: Reagan appare in camicia da notte nel salotto dove sua madre intrattiene degli ospiti e piscia sul tappeto.
Questo film non prolunga il prologo oltre i dieci minuti e in questo senso, ma solo in questo senso, può venire letto alla luce dello schema di Syd Field, ma poi prosegue con uno stile narrativo tutto suo, che spiazza continuamente il pubblico con salti di genere e di ritmo, quasi fosse un montaggio di film diversi, e che prima di entrare nel vivo della vicenda prolunga la nostra attesa a dismisura.
Il rigido schema di Syd Field è inapplicabile alla lettura di questo film.
- Il sorpasso ( di Dino Risi)
I protagonisti compaiono fin dai titoli di testa e ci vengono presentati nel contesto di una Roma deserta, in piena estate. La svolta del decimo minuto è rappresentata dall’uscita dei due da Roma, a bordo di una veloce macchina sportiva. La guida di Vittorio Gassman è così disinvolta che il suo compagno di viaggio Jean Louis Trintignant, osserva: “ Sono nelle mani di un pazzo!”. Si entra insomma nel pieno della vicenda, con una scena che è già una premonizione dell’incidente stradale che chiuderà drammaticamente il film. Ma questo il pubblico non lo sa ancora, non può ancora leggere questa scena e quella battuta come un “segnale”, perché questo evento è raccontato in assoluta fluidità con quelli che lo precedono e lo seguono. In altre parole, il pubblico non ha alcuna chiara percezione che il racconto sia entrato in una nuova fase. Non c’è nessun colpo di scena , nessun salto narrativo, nessun “cambiamento apparente di genere” che ci segnali che stiamo entrando in un’altra fase del racconto. Il sorpasso ci insegna qualcosa di molto prezioso: lo sceneggiatore deve avere una scaletta ( senza una scaletta che già prevedesse quel finale, la scena dell’uscita da Roma con l’auto che strombazza e va a gran velocità e la battuta di Trintignant non sarebbero state significative) , ma il pubblico non deve essere costretto a riconoscerla. La struttura di una narrazione deve essere ben presente a uno sceneggiatore consapevole, ma il pubblico non deve necessariamente accorgersene, anzi in una narrazione fluida è bene che non la avverta neppure.
- Shrek ( di Andrew Adamson e Vicky Jenson )
Nei primi dieci minuti si presentano l’Orco Shrek (protagonista del film) e il suo asino, in una scena molto animata in cui li vediamo vittime della persecuzione e della paura di contadini superstiziosi.
Dopodiché quando ci spostiamo nel rifugio di Shrek il film svolta presentandoci una vera e caotica irruzione di personaggi di favole diverse: la Bella Addormentata, il Pifferaio Magico, Cappuccetto Rosso eccetera. Il vero tema del film è appunto “il mondo delle favole” che visto come un insieme, anarchicamente mischia racconti separati in un’unica narrazione, avventurosa , ironica e parodistica.
Anche questo film corrisponde solo in modo molto libero alla scaletta di Syd Field.
- In conclusione
Dagli esempi di cui sopra, risulta insomma chiaramente che ( si faccia o meno riferimento alla curva dell’attenzione) il criterio secondo cui dopo dieci minuti di film si deve entrare nel vivo della vicenda e far “decollare” la narrazione, non è senza fondamento. Ma che prescrivere uno stile di narrazione punto per punto, minuto per minuto, oltre a violentare la libertà stilistica del narratore, non è affatto di per sé garanzia né di Successo, né di Qualità. Casca a fagiolo una citazione di Piaget, il grande pedagogo, che ha tra l’altro studiato attentamente i meccanismi dell’attenzione nei bambini: “Ascoltare una sinfonia è ben più che ascoltare una serie di note musicali separate”. In altre parole il ritmo , la fluidità, l’equilibrio oppure gli squilibri che vogliamo introdurre in una narrazione, non attengono affatto alle singole parti della narrazione e non possono venire stabiliti a priori, pena una semplificazione letale della comunicazione espressiva. Filosoficamente il problema può venire accostato al celebre paradosso di Zenone della Freccia Ferma. Cioè , se si considera il tracciato compiuto dalla freccia scoccata, essendo esso composto da un insieme infinito di punti, c’è sempre un punto che dovrà venire attraversato dalla freccia prima del successivo, dunque la freccia non si muove affatto e il suo movimento è pura apparenza. Ora: una pellicola cinematografica è composta da fotogrammi e il movimento è appunto frutto di un’illusione. Fotogrammi di per sé immobili, proiettati a un certo ritmo,vengono percepiti dall’occhio in una sequenza mobile. Ma se noi facciamo il procedimento inverso e frammentiamo il movimento nelle sue singole componenti, fino al singolo fotogramma, il risultato di questo modo di procedere è che il film non esiste più! Il singolo fotogramma , di per sé, non ha neppure la dignità estetica di una fotografia, in quanto non è fatto per essere visto nella sua singolarità, ma in sequenza.
Dividere la sceneggiatura in singoli istanti parcellizzati, può avere l’effetto, del tutto rovinoso, di distruggere il movimento, la fluidità narrativa, la percezione del racconto come un unicum. In altre parole, se l’assunto di Syd Field era quello di educare i suoi studenti a un racconto unito ed equilibrato, il risultato è l’opposto: un racconto macchinale che procede a scatti, prevedibile in ogni sua fase ( se non altro perché visto applicato pedissequamente in centinaia e centinaia di film) , senza vere alterazioni di ritmo e senza movimento alcuno. Il Motore Immobile.
-Esercizio: come affrontare la Scaletta.
Il consiglio che mi sento di dare agli sceneggiatori esordienti è dunque di studiare sì una partitura del film nei suoi momenti essenziali, ma di non applicare una struttura troppo rigida e vincolante al racconto.
Ci sono ben altri vincoli strutturali di cui un film deve tenere conto e questi li vedremo nella prossima lezione.
Nell’attesa, cominciate comunque ad esercitavi a scrivere una scaletta della vostra storia, dividendola in tre atti al fine di poterla intendere come un percorso d’insieme nel quale ogni momento (ogni cosa che deve succedere) sia pensato in rapporto con il tutto e con la durata complessiva. Ma tenete anche in conto che quasi mai la scaletta coincide con il momento ispirativo di un film. Lo stimolo per un racconto può essere fornito anche da una sola scena, da un singolo momento espressivo. A uno sceneggiatore molto di rado capita di incontrare un regista che gli racconti una storia nel suo completo percorso. Molti registi, non necessariamente “visionari”, possono dirvi: nel film deve esserci questo, e vi raccontano una situazione. Per esempio, per riferirsi a un noto film di Dario Argento: il protagonista assiste a qualcosa di terribile, vorrebbe chiudere gli occhi, ma non può, perché le sue palpebre in qualche modo sono bloccate. Al regista interessa raccontare questa situazione angosciosa. Il punto è come arrivarci, come collocarla nell’insieme del film, come elaborarla ( studiando ad esempio come poter realisticamente bloccare le palpebre del protagonista o a quale evento terribile egli venga fatto assistere e da chi, perché eccetera). Insomma : il più delle volte in partenza ( quando si pensa a un film) non c’è affatto, non c’è ancora un racconto, ma c’è una situazione fortemente emotiva, attorno alla quale costruire racconto. Spesso queste situazioni sono molte di più di una e dunque occorre scoprire come legarle tra loro in un racconto unitario. Se parto da singoli momenti climax, situazioni fortemente espressive, e poi costruisco il racconto, allora la scaletta è il risultato di un’elaborazione di elementi sparsi da approfondire e chiarire. Dunque i famosi foglietti da mettere in fila possono anche essere scritti prima della scaletta e approfonditi ben più che in una riga essenziale. I momenti dominanti di un film possono venire intesi non come scansioni del racconto, ma come momenti fondanti del racconto. In questo caso, il racconto dipende da loro, non sono loro a dipendere dal racconto.
Schematizzando: un modo di raccontare è partire dalla storia e poi piazzare ogni tanto un Mickey Mouse che suona la tromba, giusto per dare qualche scossa al pubblico. Resta però il fatto che in questo modo la forzatura si avverte, perché Mickey Mouse non c’entra nulla con la storia che sto raccontando. Anzi la storia di per sé potrebbe venire raccontata senza Mickey Mouse, se fossi in presenza di un pubblico molto motivato che non ha bisogno alcuno d’essere costantemente risvegliato.
Un modo completamente opposto di raccontare è: la storia mi serve solo per arrivare a Mickey Mouse, che è comunque la parte più divertente del film, più Mickey Mouse ci sono, meglio è, la storia è mero pretesto.
E infine c’è un modo più “equilibrato” di raccontare, che non consiste affatto nel dedicare un minutaggio fisso alle singole parti di un film, ma nell’articolare la narrazione fluidamente in modo che ( come nell’esempio del Sorpasso) i singoli episodi e gli scatti narrativi di un film non siano semplicemente assemblati e neanche siano percepibili come momenti distinti dal pubblico. Lo sceneggiatore deve avere in testa una struttura, ma il pubblico deve assistere a una storia, mentre la struttura può benissimo risultargli invisibile. E la storia è altrettanto importante dei singoli elementi che la compongono e la scandiscono. L’insieme e i singoli momenti si tengono l’un l’altro.
Non intendo dare un giudizio di merito su queste tre procedure, ciascuna a suo modo legittima, ma mostrare che il cosa e il come raccontare non sono mai riconducibili a un unico modello.
Cosa voglio raccontare? E’ la prima domanda da porsi: riguarda la scelta del tema centrale, la definizione del protagonista, del genere, di quello che mi preme mostrare, anche di singole scene o situazioni. E’ una fase libera e anarchica, da affrontare con la massima carica esplorativa, senza preoccuparsi di incongruenze, passi falsi, digressioni . In cinema è la fase in cui “si va a ruota libera” , occupata da lunghe conversazioni anche senza centro apparente, anche apparentemente improduttive, ma assolutamente fondamentale per trovare un’intesa tra sceneggiatori, tra questi e il regista e/o il produttore e/o l’attore protagonista. E’ la fase in cui anche lo sceneggiatore attraversa il caos per afferrare gli elementi veramente essenziali su cui fondare il proprio racconto.
La seconda è: Come voglio raccontare? Quale ritmo, quale stile espressivo esprime meglio il senso ( non solo contenutistico, anche emotivo) di questo film? Anche questa fase è esplorativa. Non la si decide semplicemente a priori ma sperimentando nel concreto la scrittura, per esempio, come suggerito dalla prime lezioni di questo corso, provando a presentare il protagonista , studiando il modo più efficace di rappresentarlo in una situazione definita. Questo genere di esercizio è quello che avete fatto scrivendo la prima scena del vostro film e sottoponendola a revisioni fino a trovare la versione per voi più convincente e corrispondente al racconto che avete in testa. Le scelte che fate nei primi dieci minuti di film, vi condizioneranno per tutto il racconto. Una falsa partenza non è recuperabile, va ripensata e riscritta.
Soltanto dopo aver chiarito a voi stessi e con il regista questi aspetti fondanti del film allora potete passare alla stesura di una scaletta che rappresenti un primo ordine da dare agli elementi del racconto e che vi funzioni da modello di riferimento nel corso della sceneggiatura vera e propria.
1. La prima impressione è quella che conta
Analizzeremo più avanti i problemi di struttura narrativa , ma accenno subito a una questione importante che ci permetterà di approfondire il tema del protagonista. Gli studi fatti sull’attenzione da parte del pubblico, anche indipendentemente dal cinema, hanno avuto una notevole evoluzione nel corso degli anni, ma almeno su un punto restano concordi, ed è questo: l’attenzione del pubblico è più alta all’inizio di una rappresentazione ed è dunque all’inizio che gli sceneggiatori devono affidarsi per sottolineare gli elementi portanti della storia, quelli insomma che fondano il racconto e che devono rimanere fissati nella mente dello spettatore. Per quanto riguarda il protagonista questo significa che esso deve essere presentato in un modo che lo caratterizzi inequivocabilmente da subito. Questo non significa affatto che poi nel corso del film il protagonista non possa subire delle evoluzioni o dei cambiamenti anche traumatici, ma va sempre tenuto presente che la prima impressione è quella che conta. Se la prima volta che vediamo apparire il nostro protagonista questi, per esempio, è arrabbiato e sta litigando con qualcuno, dobbiamo tener conto che questa sua apparizione lo marchierà e cioè il pubblico lo interpreterà come un incazzato sempre pronto ad esplodere. La situazione di partenza definisce il protagonista, non può essere un momento occasionale e secondario. Quando dunque ci troviamo da sceneggiatori a fare apparire il nostro protagonista dobbiamo studiare una situazione, un atteggiamento, un modo di essere che già lo presenti compiutamente nel suo “essere”. Abbiamo, nelle precedenti lezioni, citato molti esempi in proposito, per esempio il personaggio di Dustin Hoffman ne Il Laureato, presentato subito con l’aria persa e confusa di un ragazzo sbalestrato che si trova a dover affrontare qualcosa di nuovo per lui, un rientro a casa che è anche un ingresso nel mondo degli adulti, e che lo fa sentire un estraneo. Queste sono le caratteristiche fondamentali del personaggio che vogliamo raccontare, quelle che ci guideranno durante tutto l’arco della storia. ( Se ancora non siete riusciti a procurarvi il film, è appena uscito su DVD e VHS in allegato a Repubblica e L’Espresso). La storia di questo personaggio è anche una storia di scoperta della sessualità (con la signora Robinson prima, con sua figlia poi) ma questa storia il film la racconta all’interno di un tema più grande , cioè l’uscita dall’adolescenza e il senso di estraneità generazionale proprio di molti ragazzi del 68. Se il film fosse iniziato con Dustin Hoffman in aereo che lancia qualche occhiata furtiva al sedere della hostess, avremmo finito per raccontare un film completamente diverso, cioè la storia di un giovane arrapato alle prese con le proprie timidezze. L’inizio insomma condiziona non solo il personaggio, ma tutto il senso del racconto e un inizio sbagliato può portarci fuori strada, ma soprattutto confondere il pubblico.
Riepilogando in modo più semplice quanto spiegato la volta scorsa sulla base dei consigli di sceneggiatura di Stuart Kaminski, la prima cosa che dobbiamo fare è chiarirci il ruolo del nostro protagonista, ruolo da cui dipende l’atteggiamento che dovrà assumere.
2. Ruolo del protagonista.
Per chiarirci subito le idee ci sarà utile distinguere tra alcuni ruoli fondamentali :
a) Ruolo Attivo (o Eroe)
b) Ruolo Passivo (o Seguace )
c) Ruolo Reattivo (o Anti-Eroe )
a) Un personaggio da Ruolo Attivo è un leader, cioè un uomo o una donna che a qualsiasi età scegliamo di rappresentarlo, ha una sua natura di leader naturale rispetto al gruppo. E’ un personaggio che coltiva dei progetti ed escogita soluzioni per realizzarli. Questo genere di personaggio, che ha il suo scenario favorito (anche se non esclusivo) nei film d’azione, appena entra occupa il centro della scena ( e dell’inquadratura). L’attore che nella storia del cinema americano ha in qualche modo codificato questo ruolo e questo modo di apparire è James Cagney. Se recuperate qualcuno dei suoi film, vedrete che questo “essere al centro” anzi “occupare il centro della scena” è applicato alla lettera. Cagney entra in un ambiente e subito va a disporsi al centro, sicuro di sé e dominatore, spesso inquadrato a mezzo busto e leggermente da sotto, per sottolinearne la natura , appunto, dominante. Il primo piano è più spesso dedicato a personaggi costruiti su una psicologia sottile o misteriosi, il mezzo busto è il modo di apparire dell’eroe, da Cagney allo Stallone di Rocky e Rambo . Come si può facilmente dedurre, il protagonista non si limita a presentarsi, non solo chiarisce la propria centralità, ma si colloca anche in un preciso quadro di “genere”. Il protagonista di un film comico, soprattutto se è un comico che usa molto il suo fisico , cioè non puramente verbale, compare di preferenza a figura intera ( confrontate per esempio le entrate in scena di Jerry Lewis o di Jim Carrey) cosa che gli consente di esprimersi compiutamente attraverso il suo modo di muoversi. Simili scelte di inquadratura, certo, competono più al regista che allo sceneggiatore, ma è bene che lo sceneggiatore ne sia consapevole nel costruire la scena , anche se è intenzione sua e del regista, trasgredirle. La situazione che mettiamo in scena deve essere tale da fare cogliere immediatamente al pubblico che è entrato in scena il personaggio “centrale”, un personaggio che crea gerarchia, rispetto al quale tutti gli altri hanno ruoli ben diversi: di contorno, di supporto, di ostacolo, di antagonismo, ma comunque tutti definiti rispetto a lui. Considerate ad esempio la presentazione del personaggio di Charles Bronson nel film di Sergio Leone C’era una volta il west. Leone non usa affatto una presentazione tradizionale alla Cagney e trasgredisce in molti modi, eppure il modello narrativo è molto preciso. Vediamo dei brutti ceffi in attesa in una stazioncina sperduta del west. Tra loro anche volti di caratteristi molto noti agli appassionati del cinema western. E’ subito chiaro che si tratta di “cattivi” , ma il pubblico viene condotto a pensare che siano dei cattivi fondamentali nella storia che inizia: Leone ce li mostra uno per uno, ne riconosciamo bene i volti, in PP, ce li presenta mentre fanno azioni minutamente descritte ( uno ad esempio gioca con una mosca che lo infastidisce fino a imprigionarla nella canna della pistola) .Tutto farebbe pensare che si tratti insomma di personaggi fondamentali, tanto vengono caratterizzati. Insieme avvertiamo che dato che si trovano tutti in attesa, non sono dei protagonisti perché il loro ruolo dipende da colui che essi aspettano, da quell’eroe ancora invisibile che sarà il vero protagonista. Anche se stanno zitti, con la loro stessa attesa, ci “parlano di lui”, ce lo fanno attendere da pubblico esattamente come lo attendono loro da personaggi. Arriva un treno. I personaggi si alzano, pronti a vedere spuntare l’eroe-nemico tanto atteso, che però non scende dal treno. Attesa delusa. Il treno riparte e scivola come un sipario teatrale per mostrarci dal lato opposto del binario, Charles Bronson. Dopodiché i personaggi che lo hanno introdotto, restano tutti uccisi sotto i suoi colpi. Leone ci sorprende perché da un lato porta all’esasperazione la nostra attesa, dall’altro smentisce le attese più prevedibili perché quelli che avevamo considerato come cattivi fondamentali, vengono invece spazzati subito via dall’eroe , al principio del film. Questo ci dice anche molto sul protagonista-eroe. Se ha eliminato così alla svelta dei professionisti, chissà a cos’altro ci farà assistere nel seguito della storia. Inoltre: se è sceso dall’altro lato del treno, è un uomo che ragiona, che ha un suo piano e che sa contrastare quelli altrui. Infine, non è uomo facilmente prevedibile: sembra che tenga in mano una valigia, ma nella stessa mano ha già pronta la pistola e la estrae in modo da sorprendere i banditi e noi stessi che non l’avevamo notata. Più attivo di così il protagonista non potrebbe essere, anche se le sue azioni sono tutt’altro che frenetiche e la sua posizione quasi statica. E’ attivo perché la situazione non esiste senza di lui, nessun altro personaggio potrebbe essere attivo senza di lui ( si limitano ad aspettarlo) e perché è un calcolatore, ha un progetto ed è pronto ad eseguirlo freddamente e con successo.
b) Il protagonista della nostra storia può anche non avere caratteristiche da eroe, essere un uomo della strada che nella scala gerarchica non occupa la prima posizione. Tuttavia dobbiamo subito chiarire che è lui che ci interessa raccontare, non il suo capo. Qui bisogna fare molta attenzione: se il nostro protagonista è un subordinato, non deve però apparire come una “spalla”. Watson non potrà mai essere il protagonista. Watson esiste perché racconta Sherlock Holmes . La spalla è altra cosa dal Protagonista Passivo, la spalla non può esistere indipendentemente dall’Eroe . Il Protagonista Passivo invece è un uomo o una donna che, al contrario dell’Eroe, subisce gli eventi , a volte impara a fatica a reagire, altre volte preferisce ignorarli richiudendosi in se stesso o sfuggendoli. Non è un uomo che fa progetti , ma che subisce e segue i progetti degli altri e cerca di adattarvisi o di scansarli. Un esempio di questo genere di personaggio possiamo trovarlo nel ruolo di Marlon Brando nel film Fronte del Porto di Elia Kazan. E’ il membro di una banda di gangster, un ex pugile un po’ rincoglionito, che non conta nulla e viene spesso preso in giro dagli altri, se e quando viene considerato. Cioè tutto il contrario di un eroe. Gli autori ce lo presentano ai margini (letteralmente) del suo gruppo d’appartenenza, schivo, con il volto che sembra voler evitare la macchina da presa. Rispetto a un Cagney che va ad occupare il centro della scena, Brando ( e James Dean) ci presentano un protagonista che se ne sta ai margini e che si lascia scoprire (anche dalla macchina da presa) solo un poco per volta. Nel corso della storia, saranno più gli eventi che la sua volontà a imporgli un ruolo “eroico”, lui non ha fatto nulla per volerlo e subisce persino questo, come una sorta di Calvario non accettato, ma fatale, imposto dal destino. Confrontate l’entrata in scena di Brando in Fronte del Porto e quella dello stesso Brando ne Il Selvaggio e vi sarà subito facile capire che non si tratta puramente di scelte attoriali, ma di racconto. La rappresentazione de Il Selvaggio non potrebbe essere più classica: a mezzo busto, alla guida della sua moto e al comando della sua banda di motociclisti. Tutt’altra cosa cioè dal suo comparire marginale, quasi inosservato, semi di spalle, all’inizio di Fronte del Porto.
c) L’Anti-eroe porta alle estreme conseguenze il ruolo di Brando in Fronte del Porto. Non si tratta solo di un marginale, si tratta di un totale estraneo al suo contesto e persino a un ruolo codificato dalla tradizione. Tutte le caratteristiche dell’eroe in lui sono capovolte. Se un eroe è forte, lui è un debole. Se l’eroe è un modello di virtù, lui ha mille vizi. Se l’eroe sa sempre cosa fare, lui è sempre in balia del momento e delle occasioni. Ciò non significa che non riesca a reagire, ma che le sue soluzioni dovranno essere anch’esse estranee a quelle dell’uomo comune. Saranno le reazioni di Dustin Hoffman in Rain Man, di Peter Sellers in Oltre il Giardino, del già citato in una precedente lezione detective Monk, o di un Forrest Gump. L’immagine-simbolo di Forrest Gump ce lo presenta seduto su una panchina. Fate attenzione, non su una sedia, ma su una panchina, cioè un tipo di sedile pubblico, destinato ad ospitare più persone, sul quale un uomo in solitudine già di per sé ci appare incongruo. Sembra fin da questa immagine che non siano gli altri, il coro, ad aspettare lui, ma lui ad aspettare gli altri, altri che non arrivano. Ma Forrest Gump non ha neppure l’atteggiamento e l’espressione di chi soffre la propria emarginazione. La sua panchina è anche un punto d’osservazione, il punto (pubblico) da cui guarda il mondo e su cui si espone agli sguardi del mondo. Guarda noi e viene guardato da noi. Isolato, eppure centrale, come un eroe. Seduto eppure attivo. Estraneo, ma disponibile a tutto ciò che può accadere. Non è ovviamente indispensabile che un simile personaggio sia border-line, matto, autistico… abbiamo già visto ne Il Laureato che può anche trattarsi di un ragazzo qualunque, sperduto come qualunque altro ragazzo della propria generazione, che se e quando reagisce lo fa non nel modo previsto dal codice e dalle regole sociali, ma in modo creativo nel senso più letterale del termine, cioè inventandoselo sul momento, senza riflessione, né preparazione, senza cioè il calcolo caratteristico dell’Eroe. Un esempio recente e italiano di Anti-Eroe è il protagonista del film di Paolo Sorrentino Le conseguenze dell’amore, magistralmente interpretato da Toni Servillo. Se non avete ancora visto questo film, be’ allora l’esercizio di questa lezione è :comprate il DVD e studiatevelo attentamente, perché sono molto rari gli esempi di cinema italiano attuale così espressivi e attenti sul piano del racconto. Un uomo isolato e silenzioso, nell’ovattato ambiente di un albergo svizzero, che attende non si sa cosa, che è lì non si sa a fare cosa, che osserva e si lascia osservare quasi avesse rinunciato a vivere. Eppure è un eroe, nel senso che all’occorrenza, sta studiare progetti e strategie e portarli al successo, ancorché un successo non certo da happy end, e che segue il suo destino senza tuttavia supporre di poterlo governare. Uno straordinario personaggio che era difficilissimo non solo raccontare,ma presentare. Studiate come le scelte di rappresentazione e i movimenti della macchina da presa ci facciano da subito entrare in sintonia emotiva con il personaggio. La macchina da presa gli gira intorno. E il nostro sguardo circolare è come il suo, come lo sguardo del protagonista che si guarda lentamente intorno, non vago , ma sempre centrato su un focus preciso: scruta le cose e le persone, cerca i dettagli e insieme se ne tiene fuori.
Nella prossima lezione cominceremo ad affrontare i problemi di struttura del racconto, con un breve excursus sugli studi relativi all’attenzione, come accennato nelle prime righe di questa lezione. Ho verificato durante questo primo ciclo che i vostri contributi ed esercizi sono stati numerosi e vivaci, potete continuare a mandarli e ora che il panorama delle opzioni narrative dovrebbe esservi più chiaro, potete anche riprendere in mano i vostri primi scritti e lavorarci di nuovo con maggiore consapevolezza. Ho notato invece una grande disattenzione rispetto a quanto qui più volte raccomandato e cioè lo studio dei film. Applicarsi a leggere un film, seguirlo nei suoi sviluppi, scoprire le soluzioni di racconto, svelarne i difetti e le inadeguatezze oltre che i pregi, è fondamentale. Il miglior repertorio di tecniche e soluzioni narrative non è, né può essere un manuale, ma i film stessi. Se non si confronta mai ciò che abbiamo in testa con i modi espressivi altrui, difficilmente si progredisce sul piano espressivo. Il punto non è affatto copiare (anche perché come diceva Totò: “a inventare sono capaci tutti, è copiare che è difficile.”) ma comprendere che raccontare non è qualcosa che appartiene semplicemente al talento e alle disposizioni più o meno naturali di un individuo, ma è un patrimonio collettivo da conoscere ed esplorare. Il ruolo di chi crea e il ruolo di chi “fa la critica” sono distinti, ma solo in un senso, cioè che chi crea deve anche imparare ad essere critico (di se stesso oltre che degli altri) mentre un critico può tranquillamente fare a meno di essere un artista.
6° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Quando leggo che "Con la sua scelta, Welles esprime con grande efficacia che il centro di una rappresentazione non può essere un Tema, ma deve essere un Uomo" mi viene in mente una frase di Hitchcock: "Più riuscito è il cattivo, più riuscito sarà il film". Infine, quando leggo "Diffidate di chi sostiene che le forme di rappresentazione ereditate dal passato sono “vecchie” e come tali da abbandonare. Si tratta invece di archetipi, di fondamenti della rappresentazione, di cui uno sceneggiatore deve avere consapevolezza, imparando a svilupparli e ad adattarli di volta in volta alle proprie esigenze di racconto" mi vengono in mente due frasi, la prima ancora di Truffaut: "Non potrei girare esclusivamente sceneggiature originali, perché sono troppo realista", l'altra nuovamente di Hitchcock: "Se durante l'attività creativa sentite che state sprofondando nel dubbio e nell'incertezza, andate subito a rifugiarvi nel vero e in ciò che è già stato sperimentato".
(Marco Sommariva, scrittore.)
* Ho letto la prima lezione e sono molto contento di quello che scrivi sui personaggi. Pochissimi sceneggiatori lo condividono. Io sono sempre stato convinto che i personaggi facciano le storie e credo che i buoni romanzi siano tali perché sono un'esplorazione all'interno dei protagonisti. Un intervistatore chiese a Balzac qual era il perfetto personaggio da romanzo, lo scrittore rispose: "E' lei, sono io, è uno che passa per la strada. Ma è un personaggio che va sempre fino al fondo di se stesso." Questa frase è un po' la mia bibbia. Mentre leggevo il modello, pensavo a come "I soliti sospetti" di Bryan Singer sia un film impostato per intero sul "dicono di lui", che tra l'altro ricorda molto "Rapporto confidenziale", sempre di Welles, che ricorda sempre "Quarto potere". La leggenda del cattivo Keyser Soze prende forma grazie ai racconti dei sospetti, è proprio questo che consente il colpo di scena finale. Anche qui i punti di vista sono univoci, nessuno aggiunge niente su Soze che resta una macchietta e tutti raccontano solo qualche aneddoto in più. A mio giudizio la storia per eccellenza sul "dicono di lui" resta "Il grande Gatsby" di Fitzgerald. Non so se i tre adattamenti cinematografici, in particolare quello di Jack Clayton, riprendano lo stesso modello narrativo della prima parte del romanzo, in cui le opinioni dei personaggi di contorno contribuiscono a costruire un protagonista indelebile. Il lettore si forma un'immagine talmente precisa di Jay Gatsby prima di vederlo, che quando entra in scena, stenta a riconoscerlo. E con questo sistema Fitzgerald spiazza il lettore. Non so se è già stato detto o scritto da qualche parte, ma ho sempre pensato che il modo in cui viene introdotto Bruce Wayne su "Batman" di Tim Burton fosse l'adattamento dell'introduzione di Jay Gatsby nel romanzo. Anche Wayne viene raccontato dalle opinioni degli altri e poi gioca a presentarsi allo spettatore senza rivelarsi. Stessa cosa vale anche per i primissimi minuti del film quando i due criminali parlano di Batman accrescendone la leggenda con aneddoti irreali. Si continua poi a parlare dell'uomo pipisterello anche dopo che lo spettatore l'ha visto, per continuare a renderlo qualcosa di non tangibile, che appartiene il mito. Questo ultimo sistema è il più comune per creare attesa riguardo a un personaggio. E più generalmente credo che il modulo "dicono di lui" risulti sempre efficace quando si deve infondere in un personaggio un'aura di leggenda. Se Jay Gatsby è un ottimo esempio di quello che chiami un "modello antico", cioè archetipo, Keyser Soze e Batman sono il suo adattamento a contesti e tematiche contemporanee. Keyser è incarnazione del male assoluto, mentre Batman è addirittura un supereroe, entrambi esempi di come applicare un modello classico a qualcosa di moderno e farne postmoderno.
(Alessandro Bilotta, sceneggiatore)
* Ritengo che l'esempio di "Citizen Kane" (narrare e non narrare) corrisponda al metodo più stimolante per descrivere un personaggio. Ricordo "Desperado" di Robert Rodriguez: nella prima scena un giovanotto (Steve Buscemi) entra in un bar e racconta di un massacro a cui ha assistito in un altro locale e compiuto da un Killer violento e implacabile, ovvero Antonio Banderas, protagonista della pellicola. In questo modo il personaggio viene identificato immediatamente come un soggetto pericoloso e vendicativo, abilissimo con le armi da fuoco e freddo come la morte. Dopo i titoli di testa, però, scatta il trucco: il giovanotto è AMICO del Killer e il racconto serviva ad ingigantire la fama del soggetto e incutere timore (lo dice lo stesso Banderas: "Hai esagerato"). Non so se una descrizione simile sia "onesta" ma, a mio parere, è funzionale: il Killer di Banderas è DAVVERO implacabile e abilissimo con le pistole, ma non solo...la descrizione corrisponde al lato più appariscente e violento della sua personalità, il resto (le sue pulsioni più romantiche e altruistiche) emergeranno più tardi... ma dato che il tema della vendetta violenta è al centro della storia introdurre il protagonista mettendo l'accento proprio sui dettagli più consoni al soggetto non è affatto da disprezzare, secondo me.
(Roberto Gallaurese, studente universitario )
* Dopo avere letto la prima lezione del suo corso di sceneggiatura, mi fa piacere esternarle il mio immenso gradimento per l'impostazione e il contenuto della sua iniziativa. Ci voleva. Ci voleva davvero. Finalmente un "professionista" che dice la "verità" ovvero che sono i Personaggi che fanno le storie e non viceversa e che a volte nel lettore prende piede molto di più il personaggio che l'autore aveva considerato come semplice comprimario. In un mondo fumettistico italiano sempre più avaro di sbocchi e belle iniziative come la sua attendo con ansia la prossima ispirata lezione e nel frattempo andrò a recuperarmi Citizen Kane. Mi permetto di suggerirle una piccola cosa: perché non crea una newsletter per questa sua iniziativa in maniera tale da creare un vero forum di interessati? Avere degli advisor via mail che ti tengono costantemente informati è importante per il pubblico di internet visto la "pigrizia" virtuale che lo contraddistingue.
( Giorgio Messina, Studio Cagliostro )
* Modello 1. L’ingresso ritardato “dicono di lui”. Esempio.
Ho scelto il film I Bucanieri (the buccaneers) del 1958. Regia di Anthony Quinn. Con Yul Brinner nei panni del pirata Jean Lafitte e di Charlton Heston nei panni del generale Jackson. Claire Bloom ne è la protagonista femminile. Non considero certo questo film un capolavoro del genere avventuroso, però penso che sia interessante un confronto con La Maledizione della Prima Luna, citato come esempio, in quanto quasi 50 anni separano i due film. E poi in analogia con Quarto Potere si parla di un episodio, molto romanzato, di vita di un personaggio veramente esistito. Infatti sebbene il film si intitoli “I Bucanieri” possiamo a buon ragione considerare unico protagonista Jean Lafitte, storico pirata vissuto a cavallo fra il settecento e l’ottocento, (ma voglio sottolineare che del realismo storico del film non mi sono preoccupato!)
Scene iniziali:
1) i titoli di apertura scorrono lentamente su una inquadratura fissa dell’oceano. La musica che accompagna i titoli di inizio ci descrive nelle sue variazioni i vari momenti del film.
2) Dopo i titoli alcuni testi ci introducono il personaggio. La sua ambiguità è messa in risalto.
3) Nella prima scena l’immagine di Lafitte è filtrata attraverso la mentalità di quello che potrebbe essere considerato il suo opposto: il generale Jackson. I due uomini non hanno nulla in comune se non il senso dell’onore e della parola data. Jackson è un militare, rigido, pratico e semplice. Gli americani si stanno contendendo con gli inglesi il controllo degli stati del sud attorno alla foce del Mississippi, nel 1812. Gli americani sono in brutte acque e il bivacco in cui troviamo Jackson respira un’aria di sconfitta. La flotta inglese mira al controllo dei mari interni. Assicurarsi l’appoggio di Laffitte e della sua flotta potrebbe significare la vittoria sugli inglesi. Ma Jackson è inamovibile: “Trattare con lui? È un pirata! Lo impiccherò!” Commento di un sottoposto: “Se Jackson dice che lo impiccherà è meglio cominciare a fare il cappio”. Jackson alla fine sarà quello che salverà Lafitte dal cappio!
4) Poi ci spostiamo nel territorio dei bucanieri… I bucanieri di Lafitte vendono in mercati improvvisati i preziosi depredati, ai ricchi e agli altolocati di New Orleans. L’atmosfera del mercato di Lafitte è allegra, guascona e spensierata. Contrasta visibilmente con quella precedente del bivacco dei soldati. C’è tutta la simpatia del regista verso il mondo dei bucanieri. Gli stessi bucanieri non si sentono dei fuorilegge. E’ emblematico il commento di Dominique, fanfarone finto ex-ufficiale napoleonico che striglia un bucaniere che ha rubato la borsa ad una dama: “Quando rubi in mare sei un bucaniere quando rubi sulla terra sei un ladro!” Insomma qui non c’è nessun dubbio: i bucanieri sono visti come ribelli simpatici e romantici al pari dei compagni della foresta di Robin Hood. Sappiamo poi una cosa fondamentale. Persino la figlia del governatore di New Orleans è innamorata di Lafitte!
5) Insomma quando arriva Lafitte sulla scena, nella personalità magnetica e affascinante di Yul Brinner, spada in pugno per sedare una rissa, noi incondizionatamente siamo già dalla sua parte! E lo resteremo per tutto il film anche quando il passato di Lafitte tornerà a oscurarne il fascino…
Da notare:
1) L’Oceano ci dà dimostrazione della sua straordinaria capacità di essere sempre diverso. Superficialmente potremmo definire il panorama noioso, dipende da quanto ci piaccia o no il mare!, ma le variazioni della luce, che si riflette sull’acqua, e il continuo incresparsi della superficie, ci offrono un mondo che non è mai uguale a se stesso, che non dà garanzie di solidità come la terra e che è la patria sterminata di uomini liberi. E’ il regno dei bucanieri e di Jean Laffitte. Il mondo in cui il pirata tornerà dopo aver tentato, per amore, di inserirsi nella società e riscattare il suo passato criminoso. L’oceano e la propria nave è l’UNICA possibile patria di Laffitte. Ho compreso il significato di questo inizio solo alla fine del film. A mio parere è un po’ ingannevole perché mi aspettavo una successione di abbordaggi e battaglie navali, che occupano invece solo la prima parte della pellicola. La musica invece non è ingannevole, presagisce tutto quello che vedremo: romantica, come il personaggio, guerresca, un momento centrale del film descrive battaglie terrestri e poi malinconica, alla fine Laffitte rinuncerà al suo sogno di diventare un americano nella società americana perché sarà sempre considerato un pirata e non potrà mai liberarsi del suo passato.
2) I testi introduttivi danno un equilibrato contributo alla personalità di Lafitte come pirata e criminale. Si sottolinea il fatto che il suo contributo sia stato fondamentale per la libertà dell’America. Il tutto viene poi riassunto da una frase di Byron: uomo di mille crimini e una virtù.
3) Jackson ci dà la visione di Lafitte che può avere un militare o un uomo autoritario: è un pirata e lo impiccherò. L’unica espressione netta e decisa. Ma anche lui cambierà idea dopo che Lafitte salverà l’esercito americano da una disastrosa sconfitta.
4) Diversa invece la posizione dei personaggi bene di New Orleans. Confortati dalla promessa di Lafitte di non attaccare navi americane, in tutto il film traspare la fascinazione del pirata verso il sogno americano con addirittura una lettura della costituzione da parte dei bucanieri, si comportano da veri ipocriti. Con il brividino nella schiena a frequentare un covo di pirati non esitano a “ricettare” i preziosi depredati alle navi spagnole e inglesi. Un commento ironico dello stesso Lafitte: Noi corriamo il rischio voi ne traete il vantaggio.
5) Conclusioni: In conclusione nella presentazione di questo personaggio, non c’è un equilibrio fra condanna e beatificazione. Il regista, Anthony Quinn dalla vita certamente avventurosa, lo ha in simpatia. A differenza del commento di Orson Welles che rimanda agli spettatori un giudizio su Kane, qui il giudizio è favorevole e ci si sforza di tacere tutte le connotazioni negative. Lafitte arriva addirittura ad impiccare un altro bucaniere perché ha depredato una nave americana e ucciso i passeggeri. Più pesante il giudizio sulla società che prende tutto l’arraffabile dai bucanieri e non esita a scaricarli alla resa dei conti.
( Vittorio Sossi , insegnante supplente di scienze)
* Come già evidenziato nella prima lezione del corso, il metodo di presentazione “dicono di lui” è tipico delle commedie teatrali, è dunque un metodo ampiamente esplorato nel passato non prossimo e di sicura efficacia. Ha l’indubbio vantaggio di preparare con accuratezza la scena all’ingresso del personaggio principale, introducendone vizi e virtù, o comunque una loro versione, ma presenta allo stesso tempo il pericolo di concentrare troppo l’attenzione sul protagonista della storia, aumentando le aspettative su di lui e distogliendo, magari, l’attenzione dallo svolgersi dei primi avvenimenti.
Da buon genovese non posso non citare il caso di “Gildo Peragallo ingegnere”, commedia del maestro Gilberto Govi (è facilmente reperibile a basso prezzo in DVD, in una collana presente in molte edicole; consiglio anzi di acquistare tutti e sei i titoli in programma).
E’ un caso da manuale. Il personaggio principale (non v’è dubbio su chi sia, il suo nome dà il titolo alla commedia) è l’oggetto di un’accesa discussione tra i primi due personaggi che entrano in scena, due donne, una giovane, da lui favorita, che si spertica in lodi al suo riguardo, e una seconda, più anziana, che spende su di lui parole acide, in netto contrasto con quanto detto dall’altra donna, insinuando oltretutto dubbi sulle intenzioni dell’uomo (che si mostrerebbe amico per concupire la giovane). Non è finita. Altri due personaggi si fanno avanti, la padrona della pensione dove alloggia l’ingegnere (affascinata dall’anziano uomo) e un nuovo pensionante. Qui i dubbi sull’identità dell’uomo, sul suo carattere, sulla sua provenienze si moltiplicano: uno lo dipinge padre di famiglia, ciarlatano e squattrinato, l’altra scapolo, ricco ed affabile. Chi è allora questo ingegnere? Ben presto si saprà: un bugiardo cronico, incapace di raccontare la verità su di sé e su ciò che lo circonda, sempre in cerca dell’occasione giusta da sfruttare a proprio vantaggio. Le sue bugie, lui le chiama “spiritose invenzioni” e anzi si vanta di portare agli altri buon umore ed allegria quando invece li getta in situazioni impazzanti e di difficile risoluzione. Ma questo si saprà poi; all’inizio della storia, invece, noi non sappiamo nulla di lui. Chi ha ragione? Chi è davvero quest’uomo? Benefattore o ciarlatano? E l’inizio ha la giusta presa sullo spettatore…
Un secondo esempio, tanto per ribadire il concetto: “Desperado” di Rodriguez.
All’inizio, Sam Buscemi entra in una squallida posada messicana, ordina una birra e, per rompere il ghiaccio, si mette a raccontare una storia. Racconta di uno strano personaggio, di una leggenda a cui gli altri (pur avendone sentito parlare) non credono fino in fondo. E il colpo di genio sta nell’accompagnare le parole di Buscemi con sequenze tratte dal suo racconto, iperboliche, esattamente come la descrizione. E allora lo spettatore si chiede: chi è il Mariachi? Esiste davvero? E se sì, è come viene descritto (una sorta di orco, gigantesco, cattivissimo, spietato) o quella è solo una versione dei fatti?
( Luca Barbie, studente )
* Mi permetterò dei consigli sull’attenzione del lettore, dello spettatore, del pubblico… la mia esperienza è legata al palco dove è fondamentale essere “interessante” da subito con il pubblico circostante altrimenti l’attenzione scema, il pubblico si distrae, ecc… Per esperienze teatrale è molto più interessante un interno famigliare dove la moglie sta cucinando ed il marito mentre rientra dal lavoro dice: “Ciao amore” e lei: “ciao tesoro ti ho fatto i cavoletti di Bruxelles alla panna come piacciono a te..” il marito mentre l’abbraccia estrae un pugnale e ZAC! La uccide… commentando: “non mi son mai piaciuti! La mamma me li faceva gratinati!”Piuttosto che: “Ciao amore” e lei: “ciao tesoro ti ho fatto i cavoletti di Bruxelles alla panna come piacciono a te..” il marito mentre l’abbraccia: “lo sai che ti adoro…” e la bacia…Ovviamente (a parte la tematica più “Dyladoghiana”) non è niente di nuovo quello che ti sto scrivendo però è interessante a volte spostare il proprio punto di vista dalla parte del pubblico. Io mi annoierei? Io mi divertirei? Vedendo quelle scene… leggendo quelle righe… Spesso ci dimentichiamo del pubblico e siamo vogliosi di inserire emozioni così personali al quale il pubblico poi non si ritrova, non fa sue…C’è una conoscenza collettiva ed una personale: dobbiamo distinguerle nitidamente e attingere da quella personale per descrivere con interesse una situazione collettiva, così facendo emozioniamo il pubblico. Quando faccio un pezzo comico… al di là dell’abitudine da addetto ai lavori… mi viene da dirmi: “ma se io fossi il pubblico a questo intervento riderei? Oppure rifletterei? O che altro?”
(Davide Colavini, cabarettista)
- Caro Davide, hai ragione nel dire che bisogna assumere il punto di vista del pubblico, però è sempre bene farlo in seconda istanza, preoccupandosi prima di quello che si vuol dire e di come lo si dice. Poi bisogna saper essere giudici di se stessi, anche spietati, non solo assumendo il punto di vista del pubblico genericamente inteso, ma anche quello della sua parte più critica. Io credo che anche negli sketch e nei monologhi comici un'eccessiva preoccupazione di piacere al pubblico e di far ridere chiunque e a tutti i costi, sia sbagliata, non solo perché il pubblico non è tutto uguale, cambia sera per sera e non sempre le risposte sono le stesse, e poi perché se ci si preoccupa solo degli effetti gratificanti, si trascurano quelli "urtanti" che sono altrettanto importanti nel lavoro comico ( e non solo per Lenny Bruce). La ricerca forzata del consenso, della risata e dell’applauso, distrugge l'originalità del proprio lavoro e spesso ci appiattisce sul luogo comune. Un comico deve anche chiedersi: perché si ride se parlo di cacca? E a volte deve anche chiederlo al pubblico per stimolare una riflessione anche sulla nostra presunta spontaneità che spesso è solo riflesso condizionato, frutto di pregiudizi ( vedi le barzellette sugli ebrei, tanto per dirne una) . Il lavoro comico comunque richiede doti di improvvisazione simili a quelli del jazzista . Nell’improvvisazione, come disse il grande musicista B.B.King, l’importante non sono le note, ma gli spazi tra le note, i silenzi. Queste pause, questi silenzi, servono anche a fermare la pulsione a ridere per poter riprendere il discorso. Quando cominciavo questo lavoro ho avuto tra l’altro la fortuna di vedere le prime esibizioni teatrali di Benigni che spesso alternava ad esplosioni di battute, lunghi silenzi che creavano non solo attesa, ma imbarazzo nel pubblico, e lo tenevano in questo modo spasmodicamente legato. Lo stile del cabarettismo televisivo, compresso in brevi sequenze di tormentoni a raffica, distrugge rovinosamente questo clima di comunicazione con il pubblico e preclude al lavoro del comico , che è comunque anche un lavoro di testi, ogni vera “narratività”. Qui noi ci stiamo preoccupando di drammaturgia : cioè si tratta di imparare a strutturare un racconto. Questo ha un suo rilievo anche nel lavoro comico perché non sempre la risata è frutto della battuta o del paradosso, ma di una costruzione di situazioni e di incastri tra personaggi che è quanto di più “meccanico” ci sia, in senso buono, nel senso cioè di una struttura ferrea che trascina il pubblico nell’imprevedibile, cosa caratteristica del grande teatro comico, da George Feydeau a Dario Fo. Persino i comici di Zelig, almeno nei casi migliori, vengono da una formazione di tipo teatrale. Bisio ha studiato alla scuola del Piccolo Teatro ( la Paolo Grassi) e l’ho visto rappresentare anche testi drammatici. E’ importante che un comico sappia essere anzitutto attore e acquisti dimestichezza con i ritmi dettati da un testo. E’ testo anche la costruzione di una gag fisica. Molti dei grandi comici americani, da Jerry Lewis fino a Jim Carrey hanno raccontato d’essere cresciuti grazie alle lezioni di Stan Laurel, le cui gag incatenate ( che scatenavano cioè reazioni a catena) erano studiatissime e comportavano un durissimo lavoro di preparazione. E’ molto pericoloso, se si vogliono raggiungere dei buoni risultati, trascurare che tra comico e pubblico c’è qualcosa in mezzo: cioè quello che si recita, che include testo e azione (G.M.)
1. Commento generale ( di G.M.) I vostri commenti e le vostre integrazioni hanno chiarito molto bene che a partire da un modello si possono sviluppare narrazioni molto diverse e che lo stesso modello può venire sviluppato in molte varianti. Ne voglio aggiungere una, davvero notevole. E’ il magnifico e celeberrimo inizio di “Sentieri Selvaggi” di John Ford. Dall’interno di una casupola buia, alla luce della prateria , seguiamo una donna che esce un po’ in ansia, come per un presentimento. In fondo alla prateria spunta un cavaliere solitario, irriconoscibile alla distanza. Piano piano tutta la famiglia esce all’aperto, in attesa silenziosa, sguardo all’orizzonte. ( E chi mai sarà? Il messia? Perché quell’attesa quasi sacrale? ) Qualcuno mormora un nome: Ethan. Non ne è ancora sicuro, esprime una speranza, ma labile, dubbiosa, che nessuno si sente di confermare. Finalmente Ethan, il protagonista, giunge alla vista. Indossa una divisa sudista. E’ tornato dalla guerra . Due bambini sorridenti lo chiamano zio e allentano la tensione.
Rispetto al modello: (1) Qui il coro non dice una sola parola, a parte il nome del protagonista e un primo riferimento che lo indica come zio dei bambini . (2). Il fatto che tutti lo attendano con tanta trepidazione ne rivela l’importanza. (3). Sorpresa: non è come ce lo aspettavamo, non si presenta come un eroe sorridente, sicuro di sé, è stanco, impolverato e porta sulle spalle il peso di una sconfitta. L’eroe è anche un anti-eroe.
Questa variante rivela quanto sia importante avvolgere nel mistero il protagonista, come si possa caricare l’attesa della sua entrata in scena anche senza parole, e come sia fondamentale lasciare che sia il pubblico, seguendo la storia, a formarsi un suo giudizio e fornire allo spettatore informazioni puramente visive che non richiedono spiegazioni supplementari. E’ dalla divisa sudista e dal suo atteggiamento che capiamo che Ethan è un reduce, che è un uomo forte, che ha attraversato un dramma e che non torna da vincente. (E anche se poi, a parole, Ethan /John Wayne assicurerà che la sconfitta non ha lasciato strascichi in lui, noi potremo capire che la durezza del suo carattere e la brutalità di certi suoi comportamenti successivi, hanno il sapore amaro di una rivalsa ).
2. Un’integrazione sul metodo. Carla Redaelli che legge e revisiona sceneggiature per professione ( e che collaborerà a questo corso esaminando e commentando quando è il caso i vostri esercizi), mi ha mandato un interessantissimo articolo/saggio di Lewis Cole, docente di sceneggiatura della Columbia University di New York e trainer del Mediterranean Film Institute, di cui Carla ha seguito un corso. Il saggio (Toughts about some essentials of screenwriting ) è in inglese e non ho l’autorizzazione a pubblicarlo, ma voglio citarne almeno un passo, opportunamente tradotto, che riguarda l’uso da fare dei manuali di sceneggiatura. Dice Cole: “ Attualmente ci sono una quantità di libri che vi insegnano come scrivere una sceneggiatura ( i più rinomati sono quelli di Syd Field). Ci sono molte utili idee in questi libri, ma il problema è che possono rafforzare una convinzione letale per la qualità. Che cioè la sceneggiatura sia un “prodotto”, da creare sulla base di regole certe. Ma chiunque ami il cinema, sa bene che le buone sceneggiature, come del resto qualsiasi altro lavoro creativo degno d’essere ricordato, vanno ben oltre la confezione del “prodotto” e non possono essere scritte seguendo semplicemente delle regole, perché per ogni regola definita, ci sono decine di esempi di rottura della regola.” Se si prende sul serio questa giustissima indicazione, ne consegue che il metodo d’insegnamento non dovrebbe, a mio avviso, predisporre degli esercizi da “eseguire” , per esempio delineando in poche righe un personaggio e/o un’azione e chiedendo agli studenti di “metterlo in scena” , come si fa abitualmente nei manuali di sceneggiatura. Non voglio dire che questo esercizio non sia utile, anzi è utilissimo se si considera che uno sceneggiatore nella stragrande maggioranza dei lavori che affronta, opera su commissione, cioè viene incaricato di sceneggiare idee o spunti di altri ( il regista, l’attore, oggi persino il produttore e/o funzionario televisivo) e dunque è bene che si abitui alla massima disponibilità e si attrezzi a saper raccontare le idee degli altri. Se si riesce a raccontare bene l’idea di un altro, è più facile raccontare le proprie. O almeno dovrebbe essere così. Se però all’aspirante sceneggiatore non si lascia neppure al principio la libertà di raccontare quello che vuole lui (una sua idea) lo si condiziona alla “confezione del prodotto” invece che aiutarlo a seguire un proprio cammino. Per chi tiene il corso poi, diventa difficile capire chi ha di fronte, qual è la sensibilità, quali sono gli orientamenti creativi dello studente. Ecco perché l’esercizio che ho proposto in questa prima lezione, vi ha lasciato assolutamente liberi di scegliere il vostro personaggio, la vostra situazione. Se oltre a indicare un modello narrativo ( da seguire e all’occorrenza modificare o trasgredire) vi avessi anche dato una traccia di personaggio o di azione, le cose forse per voi sarebbero state più semplici, ma non vi avrei aiutato a seguire il vostro libero percorso creativo, né avrei avuto modo di capire cosa siete più interessati a raccontare. Nella sezione esercizi, troverete alcune prove molto interessanti da questo punto di vista, proprio perché intrecciano uno studio di tipo tecnico, con temi e personaggi ben radicati nell’esperienza di chi ha scritto. E insieme, in questa sezione di commenti, segnalazioni e integrazioni, si può notare come l’attitudine di ciascuno a narrare una storia che in qualche modo “gli corrisponda”, non è affatto alternativo all’amore per il cinema, tutto il cinema, senza confini prestabiliti di genere e/o di livello, né di scelta di tema o argomento.
Dopo la prima lezione sono arrivati parecchi esercizi. A tutti è stato risposto individualmente. Qui pubblicheremo soltanto gli esercizi che hanno avuto uno svolgimento più compiuto e la cui lettura può essere utile a tutti. Pubblicare tutti gli esercizi ricevuti avrebbe reso confusa la lettura. E’ normale che al principio alcuni esercizi siano fuori tema o svolti troppo in fretta, però vi raccomando di mandare i vostri scritti solo quando siete ragionevolmente certi che “funzionino”. Prendetevi il tempo necessario, riscriveteli più volte senza accontentarvi della prima idea, esplorate direzioni diverse e scegliete infine quella che vi convince di più. Curate con scrupolo la forma e correggete i refusi. Precisate bene la situazione. Non scrivete dialoghi indiretti e vaghi, ma battute vere e proprie, non usate formule generiche del tipo “che adesso sarebbe troppo lungo descrivere” o “eccetera”. Insomma, non inviate semplici appunti, ma svolgimenti completi. A volte vi chiederò delle revisioni, non solo per correggere i difetti più evidenti, ma perché la revisione è parte integrante del lavoro dello sceneggiatore e bisogna prenderci l’abitudine. E’ anzi bene preoccuparsene per primi e migliorare il proprio testo prima ancora che siano altri a chiedercelo. Lo sceneggiatore usa molte meno parole del romanziere, perché la lettura deve risultare semplice, chiara e non sollevare equivoci. Il testo di una sceneggiatura, serve anche da indicazione per la messa in scena, per i reparti, per gli attori. Tutto questo lo si imparerà un po’ per volta, però cominciate a figurarvi mentalmente la situazione che volete raccontare, proiettatevela in testa, cercate di vederla. Disponete gli elementi in ordine, non tutti insieme, ma nell’ordine in cui vanno visti.
E’ bene riassumere in poche righe cosa intendete raccontare, e stilare un breve profilo del protagonista, prima di scrivere la scena di presentazione, che altrimenti diventa impossibile da valutare.
E ora passiamo agli esercizi di questo mese.
* DUE ESERCIZI DI PAOLO MADDONNI
Premessa - Non sono un cinefilo e i miei film al cinema sono casuali e negli ultimi anni molto orientati all'infanzia, per via dei miei due figli. Proprio con loro ho visto di recente in DVD "Billy Elliot" di Stephen Daldry del 2001. A scuola di mio figlio Silvano Vento, 2° elementare, alcuni bambini si erano rifiutati di realizzare alcune semplici coreografie per la recita di fine anno, perché il ballo "è da femmine". Mi sono ricordato del film di cui avevo sentito parlare e lo abbiamo visto assieme. A parte il contenuto emotivo del film, mi sono soffermato sull'inizio, che mi è sembrato calzante per questo secondo esercizio. Del resto il film si intitola con il nome del protagonista, per cui è difficile sbagliare. Allora i titoli di testa si sviluppano sul primo piano del ragazzo che salta sul letto al ritmo della musica che fa girare su un LP (la prima immagine è proprio della mano che posiziona il braccetto del giradischi). Di seguito il ragazzo lo vediamo in una cucina molto disordinata che prepara alla meglio un vassoio con la colazione. La situazione è allegra, il ragazzo sembra pieno di vita, gioca con le cose appese e il tostapane. Apre una porta scorrevole con il vassoio in mano: si vede un letto vuoto e il ragazzo di gran furia corre fuori per il quartiere, evidentemente di classe operaia. In un prato trova chi stava cercando, la vecchia nonna svampita e trascurata. Billy con molta tenerezza le dice semplicemente: "Le tue uova, nonna. Sono Billy, vieni". Sull'uscita di scena dei due, si distinguono sullo sfondo dei poliziotti in tenuta antisommossa, pronti a intervenire contro i minatori in sciopero.
Mi è sembrata una buona e rapida presentazione del protagonista e del contesto della situazione in cui si muove. Certo i buoni sentimenti si toccano subito, l'assenza della mamma, il grigiore dell'ambiente sociale, nonna, padre e fratello con caratteristiche marcate, tutto fa già immaginare o ben sperare nel lieto fine a cui il protagonista ci porterà passando comunque attraverso prove difficili e rapporti personali particolari (la maestra di danza, l'amico omosessuale).
ESERCIZIO 1 – presentazione del protagonista a ingresso ritardato
Un soggiorno ammobiliato senza gusto particolare. Ambiente poco illuminato, forse una mansarda. Atmosfera di generale trascuratezza e disordine. Un divano consunto, un televisore. In bella vista una cornice con una grande fotografia di una vistosa ragazza bionda in posa provocante. Una scaletta conduce ad un soppalco non visibile. Si vedono la porta d'ingresso, quella della cucina e quella di un'altra camera.
PIO (trentenne, piccolo e longilineo), steso sul divano letto, senza scarpe ma in camicia e cravatta. Fuma lentamente una sigaretta. Si é appena risvegliato dalla "siesta", canticchia.
Improvviso rumore di passi dal piano soppalcato.
PIO - Leo! Gran ciccione, prima o poi verrai giù senza passare per le scale! Mi sono addormentato anche oggi: in questo buco alle tre di pomeriggio sembra di essere in piena notte... Leo! Avanti, sono le tre, si riparte!
Da sopra cessano i rumori, Pio si alza e si sistema i vestiti, infila le scarpe.
PIO - Prima o poi dobbiamo farglielo capire a Pellizzari che l'orario spezzato non va più di moda... chiusura dalle 13,00 alle 16,00 e poi avanti fino alle 20,00. E a noi ci frega tutta la giornata! Leo, cos'hai? Fai il gioco del silenzio? Anch'io ogni tanto ci provavo da ragazzino. Cercavo di battere il record di tempo in silenzio dal momento in cui mi svegliavo. Uscire di casa senza dire una parola ai miei, era facile. Con i compagni di scuola dovevo lottare di più. Il record personale l'ho stabilito una mattina che mi interrogò la professoressa di filosofia: una stupenda scena muta fino alle nove e mezza!
Un forte ansimare dietro la porta di ingresso, e il rumore di qualcuno che cerca di infilare una chiave nella serratura. Pio spegne la sigaretta e si alza brandendo una scarpa.
Si spalanca la porta ed entra LEO (qualche anno più di Pio, grande e pesante) sudato e paonazzo, trascinando una pesante valigia.
PIO - Leo!?
Leo crolla a terra svenuto. Pio si scuote e si precipita a sollevare l'amico e a trascinarlo verso il divano. Con fatica raggiungono il divano dove rimangono per un istante sdraiati e avvinghiati.
PIO - Leo, ma sei matto...la pressione...non...non devi fare sforzi, lo sai...che poi li fai fare pure a me...
LEO -...uff...odio... le scale...
PIO - Pensavo fossi in casa, di sopra. Mi era sembrato di sentire dei passi e dei rumori. Ho parlato dieci minuti da solo come un imbecille... ma dove eri? E questa valigia?
LEO - In effetti non eri solo...(Esita, poi d'un fiato ad alta voce)... è-arrivata-all'improvviso-mia-cugina-dal-paese-deve-dare-un-esame-all'università -domani-e-per-stasera-la-ospito-io-qui-ti-dispiace-no-vero-sei-un-amico-lo-so.
PIO – Come?
LEO – Prima, mentre dormivi, sono sceso a prendere una boccata d'aria e l'ho incontrata sotto casa. Per non svegliarti ho accompagnato prima lei su di sopra e poi sono risceso a prendere la valigia.
PIO - La cugina di campagna? In due anni che abitiamo insieme non me ne avevi mai parlato...
LEO - Non la vedo praticamente mai, di solito va da una zia che però oggi è dovuta correre al capezzale di un altro parente...insomma...si chiama... Ada ... Ma non dobbiamo andare? Pellizzari ci taglia la testa se arriviamo tardi (si alza e fa per uscire).
PIO - E Ada?
LEO - Rimane qui, si riposa...studia. La vediamo stasera. Dai, andiamo!
(Spinge Pio verso al porta ed escono). La sera dopo. Leo e pio fuori della porta di casa.
PIO - ...ma perché non vuoi venire? Ci facciamo svelti due uova, se proprio hai fame!
LEO - No...no.. non mi sento tanto bene, preferisco cucinarmi qualcosa con calma. Poi più tardi faccio una telefonata ai miei...mi va di stare tranquillo.
Entrano in casa, soggiorno.
PIO - Ma dai, che lo so che ti sta antipatico Alvaro. Certo ci va pesante quando ti prende in giro, ma ti assicuro che è il suo modo di farti partecipare alla compagnia! Poi una volta tanto potresti anche giocare!
LEO - Ma voi giocate a poker tutti seri come dei professionisti. (Mentre parla, di nascosto a Pio, estrae un foglietto dalla tasca e lo mette sul televisore)…a me se viene un tris mi sudano le mani e mi cadono le carte! Un'altra sera ci vengo, te lo prometto… Ada! Ci sei?... Ah guarda, un messaggio. "Scusatemi ancora una volta ma resto di sopra a studiare: domani ho la seconda parte dell'esame e non mi sento affatto sicura. Buonanotte, Ada".
PIO - Senti, ma esiste davvero questa cugina? Fino ad adesso ho visto solo messaggi: ieri sera era già andata a letto, stamattina è uscita all'alba, oggi a pranzo recuperava lo stress dell'esame e stasera studia di nuovo!
LEO - Ma scusa con l'esame...
PIO - Vorrei almeno presentarmi, farmi vedere, dirle in bocca al lupo o che ne so...vado su un attimo solo a salutarla
(Va verso la scala).
LEO - (gridando) No!!
PIO - Ma sei matto? Perché urli così? E poi perché no? Quanto sei nervoso... Io mi sono fatto due ipotesi sulla cugina Ada, entrambe che partono dal fatto che non sia per niente tua cugina. La prima è che sia la figlia segreta di Marilyn Monroe e che tu sia geloso di me -giustamente eh, eh, eh-.
LEO - Eh, eh, eh! Ma se stanotte ho dormito sul divano...
PIO - La seconda è che al contrario sia la sorella del mostro di Lochness e che quindi tu ti vergogni a farmela vedere. Sinceramente preferisco la prima!
Pio sale di corsa alcuni scalini.
LEO - (gridando) La seconda!
PIO - Lochness vero? Lo temevo, conoscendoti...
LEO - Come sarebbe?
PIO - Dai, non t'offendere... però la potrò salutare lo stesso, no? Non sono così debole di stomaco!
LEO - NO, per piacere. Ti prego, la cosa è più seria di quanto tu non pensi. Ada è… è… una mia amica… ecco, un mia carissima amica… di infanzia, siamo andati a scuola insieme, pensa. Alle medie, ecco alle medie. Beh, il suo problema è il naso... anormale... vistoso... deforme... orrendo! A scuola la chiamavano… "cavatappi". Proprio così! Crescendo purtroppo la situazione non è migliorata, anzi... praticamente Ada ha cominciato ad uscire di casa solo in inverno con una grande sciarpa sulla faccia. Ora ha preso il coraggio di venire in città per consultare uno specialista di chirurgia plastica. I primi esami sono andati bene, domani si sa l´esito dell’ultima analisi e se tutto è a posto nel pomeriggio potrebbe già entrare in clinica. Mi ha chiesto di non farle conoscere gente nuova fin quando non avrà un nuovo aspetto... però capisco che tu ci rimanga male, adesso la chiamo e...
PIO - No, no per carità, non la disturbare... la sua scelta è comprensibilissima... e poi sto andando, anzi Alvaro e gli altri mi staranno già aspettando. Penso che … farò tardi. Ciao!
Pio esce di gran fretta.
LEO - Ciao, Pio.
Leo va in cucina, torna asciugandosi le mani con uno strofinaccio, va verso il televisore, trova il telecomando e sta per usarlo quando sente dei passi sul soppalco e alza lo sguardo e sorride.
LEO - Ada!
VOCE DI ADA - Ho una lettera per te.
LEO - Cos´è una raccomandata? Allora sarà l´assicurazione, devo pagare la rata e...
VOCE DI ADA - No, ti ho scritto io.
LEO - Ah, sì? E come mai? Da ragazzino ero appassionato di lettere. Ero amico di penna di dodici ragazze di tutto il mondo. Non ne ho mai incontrata nessuna. Una abitava all’isola Mauritius, quella dove ci si va in viaggio di nozze...A un certo punto mi mandò una cartolina da Israele, dove era emigrata con suo fratello...chissà che fine ha fatto...
VOCE DI ADA - Caro Leonida,...
LEO - Capirai, solo all'anagrafe sono "Leonida"!
ADA - ...ti scrivo per confessarti che la storia che ti ho raccontato ieri non è vera, o meglio deve essere corretta. Ti ringrazio immensamente per avermi accolto in casa tua, nonostante mi avessi conosciuta per caso solo qualche minuto prima. Lavoravo in un albergo, questo è vero, dove restavo anche a dormire. Non è vero però che me ne sia andata perché il padrone mi aveva messo le mani addosso...Toh, leggi tu!
Una mano spunta dal soppalco porgendo un foglio, Leo lo prende e legge.
LEO - "...in realtà ha scoperto, non so come, che sono un transessuale e mi ha cacciata per difendere il buon nome dell'albergo. Sono scappata dal paese dieci anni fa. Per i miei sono come morta. Ho battuto il marciapiede per tanto tempo, poi, finalmente, sei mesi fa mi sono potuta operare. Ora sono una donna, sola. Mi sembrava giusto dirtelo, prima di andarmene. Ada".
ADA donna senza età precisa, capelli scuri e lunghi, lineamenti anonimi e regolari (naso compreso) scende dalle scale, si avvicina a Leo.
ADA - Guardami, fammi vedere che faccia fai.
LEO - Sei...sola...
ADA - Scusami, faccio fatica a liberarmi del passato. Te ne ho parlato perché ho ancora la necessità di affermare questo mio passaggio. Mi sento come rigenerata, liberata... Che bella sensazione finire gli aggettivi in "A" invece che in "O"! Lo facevo anche prima ma inconsciamente mi sembrava una forzatura e.... ma avrei fatto meglio ad andarmene senza dirti niente!
Prende la lettera, l’accartoccia con rabbia. Leo si riprende dalla sorpresa, è subito allegro.
LEO - No... hai fatto benissimo, anzi... vieni in cucina, hai fame? Ho scongelato la polenta, e adesso faccio una frittata. Ti va di preparare un'insalata? Ih, che curioso! Mangiamo tutte cose che finiscono in "A"!
Ridono entrambi.
Ada continuerà, in una lunga serie di dialoghi sempre a due, ora con l’uno ora con l’altro dei personaggi maschili, a raccontare con molto realismo e partecipazione versioni completamente differenti ma sempre drammatiche della propria vita e dei motivi che l’hanno portata ad essere sola e bisognosa di rifugio. Telefonate e messaggi dall’esterno infittiscono il mistero. I due uomini sono fortemente intrigati e, ognuno a proprio modo, si innamorano di Ada sconcertati da una donna che distrugge tutti i loro punti di riferimento sul mondo femminile. Mantengono però una diffidenza vicina alla paura che li porta a frugare assieme tra le sue cose, senza per altro trovare nulla di chiarificatore. Scoperti sul fatto da Ada, si ritrovano di nuovo soli, con la loro vita tranquilla e sicura ma con l’impressione di aver perso l’occasione di volare più in alto.
ESERCIZIO 2 – come si presenta il/la protagonista
La storia è quella di un intellettuale in un paese africano appena uscito da una feroce guerra interna, ai giorni nostri. Si fanno i conti con il passato, il presente e il futuro.
1° versione
Tharcisse posa i fogli con il notiziario sul tavolo e va a sedersi sul divano, che era vecchio già prima della guerra, si toglie gli occhiali e si stropiccia gli occhi affaticati. Cinquant’anni portati bene, dicono tutti, ma, come dicono tutti, agli africani non sai mai che età dare. Riapre gli occhi e si guarda attorno.
Tharcisse - Bosco!
Bosco - Sì?
Tharcisse - Domani mattina, puoi provare per piacere a sistemare un po' questa stanza? Per comperare un divano nuovo è ancora presto, ma almeno un'atmosfera più pulita in questa radio potremmo cercare di crearla, no?
Bosco – Direttore, io ci provo, ma è la stagione secca, c'è sempre polvere in giro!
Tharcisse - Riprovaci Bosco. Con la stagione delle piogge ci sarà sempre fango, in giro!
2° versione
Tharcisse rilegge i fogli del suo notiziario. Le sue mani nere di africano posano lentamente i fogli, e su questi gli occhiali. Le mani stropicciano gli occhi. La stanchezza e il dolore passano in un lampo, le mani riprendono fogli e occhiali. Tharcisse entra deciso in sala radio.
Esercizi di Paolo Maddonni, volontario di Legambiente
Commento di Gianfranco Manfredi
Non ho molto da eccepire sui tuoi esercizi perché la valutazione non può prescindere da quello che intendi raccontare. Questo non è comunque un rilievo secondario, perché le presentazioni grosso modo possono essere di due tipi: c’è chi intende la presentazione come prologo a sé. E’ l’uso più tipicamente cinematografico. Un esempio possono essere le presentazioni che Sergio Leone fa dei protagonisti dei suoi western ( per esempio Il buono, il brutto e il cattivo, o C’era una volta il West). Queste presentazioni sono dei brevi film nel film. Hanno un inizio e una conclusione. Gli esempi de Il Laureato o di Io la conoscevo bene sono anch’essi dello stesso tipo: la scena o le scene in cui si presenta il/la protagonista hanno qui una loro circolarità. Vedi come viene usato l’acquario ne Il laureato (insieme apertura e chiusura dell’interno casalingo e dilatazione di quanto lasciato intuire all’inizio dall’espressione persa e quasi “autistica” del protagonista). Vedi l’apertura del film di Pietrangeli con la Sandrelli distesa sulla spiaggia e poi, dopo una breve corsa, di nuovo distesa nel negozio. Struttura circolare,chiusa in sé. Un perfetto ritratto. Questa è personalmente la forma che preferisco. La presentazione del protagonista è un film nel film, un prologo in qualche modo autonomo. A dirla in termini musicali, una ouverture.
C’è un altro uso, più corrente nel cinema italiano di questi anni, in cui la presentazione del protagonista non è una scena distinta, ma sono, per così dire, le prime righe di una narrazione, il puro starter. In questa forma, la prima scena non è una scena conchiusa , è legata al seguito, da sola dice poco. Questa forma , secondo me, è molto meno espressiva. Può adattarsi a racconti in cui il protagonista è colui che ci conduce nella storia,non è né il centro, né la vera guida della storia. Il vero protagonista è, in questo caso la storia, della quale il protagonista è o tende ad essere mera funzione. Nel tuo primo esercizio, i dialoghi (interessanti e ben scritti) sono piuttosto lunghi per una sceneggiatura cinematografica . Dialoghi lunghi non sono in assoluto sconsigliabili, ma presentano una controindicazione: una certa stasi che contrasta con il movimento e la rapida scansione ritmica, propri del cosiddetto cinema/cinema. La presentazione di Ada (i discorsi su di lei, la sua mano che sbuca dalla letto, lei che infine appare) è suggestiva. Tuttavia la scena mantiene un che di non concluso, resta racconto allo stato fluido. Ciò è ancor più evidente nel secondo esercizio. Qui i due diversi sviluppi ti pongono di fronte a un bivio. Non hai ancora scelto quale direzione prendere, ma questa scelta è fondamentale per chiarirci il protagonista. Nel primo caso, Tharcisse reagisce alla sua melanconica stanchezza, buttando la sua frustrazione all’esterno ( il suo collega che non ha pulito, l’ambiente sempre in disordine); nella seconda, invece, non si lamenta di nulla e di nessuno, si riscuote e con passo deciso comincia la sua giornata di lavoro. E’ evidente che si tratta di due sottolineature opposte. Quale corrisponde meglio al carattere di Tharcisse? E’ un capo naturale che cerca di dare compiti agli altri e trova all’esterno, nella pratica, la soluzione ai propri dubbi, oppure è un individuo che è abituato a reagire da solo, a fare anzitutto i conti con se stesso? Il modo in cui hai descritto la situazione “la stanchezza e il dolore passano in un lampo” potrebbe suggerire anche un terzo risvolto psicologico: il protagonista tende a mettere sotto il tappeto i propri problemi, a reagire con un “fare” piuttosto cieco. Insomma la non chiarezza della presentazione iniziale, riflette il fatto che non hai ancora scelto quale tipo di protagonista vuoi raccontare. Ecco perché in genere io consiglio e preferisco una presentazione “chiusa”, a tutto tondo, perché non lascia equivoci sulla natura del protagonista, sulla sua psicologia. L’altra soluzione per uno sceneggiatore è sempre molto rischiosa: presumiamo che poi tutto si chiarirà nel corso della storia, ma riusciremo a farlo, se non ce lo siamo chiarito prima noi? Oppure la storia ci prenderà la mano e il protagonista sarà solo funzionale a quello che vogliamo fargli fare, smarrendo così la credibilità psicologica?
* ESERCIZIO DI LUCA DE GASPARI
IL CONIGLIO AZZURRO
IL PERSONAGGIO- Luca Tresi é l’uomo del momento, famosissimo per le sue performance televisive, venerato da tutti come un Dio e da tutti considerato come un uomo arrivato. Lui, da parte sua, si sente davvero un divo, è arrogante e presuntuoso, disprezza la gente comune incurante del fatto che a loro e solo a loro deve il suo successo, maltratta la sua compagna e spende i suoi molti soldi in ville, auto e tutto quello che serve a dimostrare di essere il più ricco.
Naturalmente sotto la copertura di un velo di apparente disponibilità verso tutti. Un giorno è costretto a tornare al suo paese natale per il matrimonio della sorella.
Tresi è nato in un piccolo paese della provincia di Treviso, non più di mille abitanti dalle possibilità, ma anche dalla mentalità, ristrette e dal quale è “fuggito” in cerca di fortuna. Dopo aver sfondato non ha più avuto né voglia né occasione di tornarci per cui non rivede la famiglia e gli ex amici da anni.
Il suo arrivo in paese provocherà non pochi attriti con gli abitanti, i quali lo considerano comunque l’orgoglio del paese ma che lui deluderà profondamente, soprattutto quello che un tempo era il suo migliore amico e che adesso è sposato con la ragazza che Tresi ha abbandonato appena arrivato al successo; l’amico è l’unico a non celebrarlo, proprio perché lo conosce bene, ma è sempre stato considerato invidioso dalla gente del paese.
Solo alla fine il pubblico scoprirà che Tresi, in televisione, fa la parte di una sorta di gabibbo incapace ( vestito da coniglio azzurro) e gira la ruota in un quiz televisivo, niente di cui andare fieri ma comunque venerato da un pubblico televisivo sempre più condizionato e sempre meno esigente. Questa in breve la storia completa
Tresi) chiacchierare con una donna più o meno della stessa età (la madre di Luca). A entrambi si legge in faccia la soddisfazione e l’orgoglio che provano mentre riportano alla memoria frammenti del passato del figlio quando da ragazzo viveva in paese, dimenticando ovviamente gli aneddoti negativi. I due ricordano il giorno della prima comunione <piccolo, quant’era carino con quel vestito bianco e come andava fiero del passo importante che stava per compiere…>, il suo andamento a scuola <se lo vedesse ora il professore di fisica, quello che lo considerava poco più di un babbeo e che lo accusava sempre di essere un lavativo...> , come anche il suo successo con le ragazze <… e quella ragazza… Carla mi pare, non ricordo, come le voleva bene, era davvero innamorato… ha fatto bene però a lasciarla… accusarlo così di averla tradita senza nessuna prova...>.
La scena si alterna con quella che vede Roberto, l’ ex migliore amico di Luca, seduto a tavola con la moglie Claudia (ex fidanzata di Luca) mentre discutono dell’imminente arrivo di Luca.
Roby <che c’è, tu non vai ad accoglierlo alla stazione? Non vuoi avere l’ onore di salutare per prima il grande Luca Tresi?>
Carla <ma non ti vergogni a parlarne così? Una volta eravate inseparabili, guai se qualcuno parlava male di lui, ed ora guardati, invidioso di lui solo perché è arrivato dove voleva arrivare>
Roby <invidioso io di uno che appena vede la celebrità se ne strafrega degli amici? Invidioso di uno che lascia la sua ragazza solo per essere libero di scoparsi produttrici e chissà….. magari anche produttori…>
Carla <io e lui ci siamo lasciati per altri motivi, motivi che non ti riguardano…>
Roby <hai ragione non mi riguardano… ma sta di fatto che per me si è comportato da vigliacco…nei miei confronti, nei tuoi e di tutto quel paese che adesso lo crede un padreterno…>
Nuovo stacco. Ora si vede un primo piano di un uomo, sui 25-30 anni, seduto sul sedile di un
treno mentre guarda fuori dal finestrino. In profondità di campo due ragazzine puntano l’uomo con il dito e parlano tra loro, eccitate dalla sua presenza (si capisce che si tratta proprio del protagonista).
Esercizio di Luca De Gaspari, studente
Commento di G.M.
La traccia va bene, ma dovresti curarla di più, a cominciare dai dialoghi. Il tuo dialogo è troppo scritto, le persone nella vita reale non parlano così. Per esempio nessuno direbbe “guardati, sei invidioso di lui perché è arrivato dove voleva arrivare”, è più diretto ed efficace un semplice “guardati, crepi d’invidia”. Inoltre questo secondo dialogo ( tra Roberto e Carla) spiega troppo. E’ meglio scoprire dopo, nel corso della narrazione, il retroscena , cioè il fatto che Roberto era il miglior amico di Luca e Carla la sua ex ragazza. I dialoghi non devono essere didascalici, cioè utili solo a dare informazioni al pubblico, ma sono l’espressione dei personaggi. Ciascuno deve avere il suo modo di parlare, esprimere il suo carattere attraverso il proprio linguaggio.
Trattandosi inoltre di abitanti di un piccolo paese, la cosa sarebbe più esplicita se ogni tanto usassero qualche espressione dialettale.
Circa l’apparizione del protagonista, leggi bene la seconda lezione. Così come lo vediamo, senza nessun tipo di sottolineatura, il personaggio è uno qualsiasi, chiacchierato, mostrato a dito,ma qualsiasi. Devi trovare il modo di far capire al pubblico chi è, non tanto e non solo come identità , ma lo stato d’animo in cui si trova in quel momento.
Sarà bene che tu ti chiarisca anche un altro punto. Come mai il tuo protagonista arriva in treno? Se vuoi farlo apparire come un vanitoso che vuole dimostrare a tutti il suo successo, sbarcare da un treno locale non è certo il massimo. Se invece arriva in treno, dovresti trovare il modo di giustificarlo (è capitato qualcosa alla sua macchina o cos’altro? Nessun personaggio famoso prende un treno locale, piuttosto noleggia una macchina). E una volta sul treno , cerca di farsi notare in tutti i modi per appagare la sua vanità, oppure cerca di passare inosservato? In quest’ultimo caso, magari gli sta sulle palle il suo paesino d’origine e quel viaggio obbligato per il matrimonio della sorella per lui è una seccatura, e gli è seccato ancor di più dover prendere il treno. Si è messo gli occhiali neri, con il solo risultato di farsi notare di più. E poi concludi la scena. Per esempio le ragazze gli si avvicinano per chiedergli se è davvero lui “quello che sta in televisione” (il pubblico di rado conosce i nomi di chi vede in TV, storpia persino quelli dei famosissimi) e lui nega, sgarbato. Così rimarcheresti il suo carattere scostante.
Ho molti dubbi sul fatto che soltanto alla fine si sappia che Luca si esibisce in Tv vestito da coniglio. Un finale così andrebbe bene per un cortometraggio, ma per un film sarebbe un peccato scoprirlo solo alla fine. Lui per tutti è e deve essere il coniglio azzurro. ( Se hai notato, visto che non avevi dato un titolo al film, mi sono permesso di darlo io, e l’ho chiamato proprio così ). Qualcuno potrebbe anche chiedergli di esibirsi in costume alla festa del matrimonio. Insomma l’idea ti darebbe occasione per parecchie situazioni nel corso della narrazione, perché buttarla via? La sorpresa finale non è indispensabile in questo genere di film. Stai tracciando un profilo psicologico, il vero problema è se Luca, dopo il suo ritorno in paese, cambierà oppure no, recupererà il rapporto con gli amici o lo manderà all’aria. E soprattutto , data la metafora del coniglio, avrà coraggio con gli altri e con se stesso o continuerà a rifugiarsi nell’ipocrisia?
* ESERCIZIO DI LUCA BARBIE
RAVEN RIPLEY ( UN WESTERN)
Nella piatta desolazione di una pianura semi-desertica cavalca lentamente una donna.
Ciò che colpisce immediatamente di lei è l’espressione del viso, un misto di immensa stanchezza e di triste malinconia. Ha l’aria di chi ha appena attraversato a piedi l’inferno e sa che deve tornare indietro a prendere qualcosa che ha dimenticato. Nondimeno nel suo occhio (unico occhio) brilla una scintilla di rabbiosa determinazione.
La donna è bella, sensuale; dimostra circa una trentina d’anni, anche se l’impressione che da è quella di chi abbia vissuto fin troppo a lungo, di chi sia stato in un certo modo prosciugato dalla vita.
Ha una benda nera che le copre l’occhio sinistro; il destro risplende di un azzurro intenso, come un lago di montagna che riflette l’immensità del cielo che lo sovrasta. E’ limpido, ma non sereno. Si muove inquieto, a scrutare l’orizzonte, alla costante ricerca di un pericolo. Il contrasto nero-benda/azzurro-occhio è analogo a quello della splendida Darryl Hanna in Kill Bill; a Raven manca però la malvagità che traspariva palese dalle espressioni di quel personaggio.
I capelli sono corvini, lunghi e sciolti sulle spalle; sono poco curati, non per trasandatezza, comunque, ma per gli ovvi disagi del viaggio. Li copre un vecchio Stetson dalla tesa larga e floscia, con una penna di gallo infilata nelle cuciture, unico segno di vanità nell’apparire della ragazza.
Il vestito, concepito per essere comodo e non elegante, è di cotone grezzo, simile a quello dei peones messicani; è nero, ma talmente logoro e impolverato che il colore ha stinto, virando su un’imprecisa tonalità scura.
La donna cavalca un pezzato; è abbandonata sugli avambracci che poggiano sul collo dell’animale.
Tutto di lei ha il sapore del vecchio, del vissuto, di qualcosa di stanco che più che camminare, barcolla, ma va ugualmente avanti.
Solo le armi che porta con sé danno un’idea di perfetta efficienza: luccicano al sole, sono ben oliate, per nulla sporche o rugginose. Un Winchester modello 73 dal calcio intarsiato in argento e avorio è legato alla sella, di traverso, insieme ad una coperta arrotolata e ad un cinturone con due fondine dalle quali spuntano i calci di due Colt. Quest’ultimo dondola dalla sella, oscillando come un pendolo mortale che scandisce il pigro ritmo del viaggio. Alla vita, legata da un laccio di cuoio, fa bella mostra di sé una navaja dal manico in osso.
Insieme alle armi e alla coperta, legato da una corda di canapa alla sella, dondola un sacco di iuta dal contenuto misterioso. I legacci sono però leggermente lenti e, con un po’ d’attenzione, si può intuire, più che vedere, una forma leggermente allungata, simile al cranio di un uomo; qualcos’altro, poi, sagome incerte: una croce metallica e multicolori piume d’uccello; così pare, almeno. Il sacco è comunque piuttosto voluminoso e deve perciò contenere molte altre cose.
Ultimo particolare: la donna ha legata sulla schiena, alla maniera indiana, una culla di vimini intrecciati. La testolina di un bimbo sbircia il panorama, opportunamente protetta da un panno. E’ difficile dare un’età al bambino: apparentemente dimostra circa un anno, ma lo sguardo è duro e fermo come quello di un uomo adulto.
I due, madre e figlio, cavalcano verso una città ai margini del deserto. In tasca una lettera che reclama i loro servigi e un rotolo di banconote come incentivo. Sulle loro teste, da secoli, una maledizione che li ha privati dell’anima.
di Luca Barbie
COMMENTO DI G.M.
Va bene, nessun particolare commento da fare. Interessante l’idea di presentare la protagonista per dettagli e il fatto che l’ultimo particolare (il bimbo sulla schiena) chiuda la presentazione con un tocco di sorpresa finale. Il tipo di stile che hai usato però è più da soggetto che da sceneggiatura. In sceneggiatura si descrive ciò che si vede dunque non hanno alcun senso notazioni come quelle dell’ultimo paragrafo. Due dettagli mi sembrano da evitare: 1. non bisogna mai in una sceneggiatura, e non è consigliabile neppure in un soggetto, fare riferimenti espliciti ad altri film (nel caso, quello a Kill Bill). Questi riferimenti,abituali in una sceneggiatura per fumetti, in un copione cinematografico invece di orientare disorientano , non aiutano a precisare il nostro film ,a meno che questo film non sia pensato proprio come un insieme di citazioni sottolineate. Per un attore che legge la sceneggiatura, poi, venire associato a un altro attore è offensivo. L’attrice protagonista,può pensare, nel caso, che la “prima scelta” fosse la Hanna e poi si é ripiegato su di lei. In ogni caso andrebbe in confusione : ma cosa devo fare? Interpretare il mio personaggio o fare l’imitazione di Darryl Hanna? 2. La descrizione del quasi-neonato è un tantino ridicola: che cosa vuol dire che il suo sguardo è “duro e fermo come quello di un adulto”? E’ Rosemary’s Baby? Come lo rendi questo effetto , come fai a evitare che risulti comico? Qui tu cumuli due effetti in uno. Il primo effetto è che la fosca pistolera ha un inatteso risvolto materno e caritatevole (il bimbo sulla schiena che, in questo caso, dovrebbe essere un bel bimbo placidamente addormentato). Il secondo effetto, lo sguardo “adulto” del bimbo, casomai dovrebbe scattare dopo ( il bimbo apre gli occhi di scatto e negli occhi brilla una luce oscura,per esempio, il che aiuterebbe a chiarire che “è privo dell’anima”, cioè per essere efficace dovrebbe essere più esasperato di un semplice “sguardo da adulto”. Tra l’altro, cosa dovrebbe fare il povero regista? Dire al suo attore di un anno “fai lo sguardo da adulto”? Deve trattarsi per forza di un effetto speciale). Ma a cosa ci porta questo secondo effetto? Il bambino a un anno, di certo non spara. Dunque? Qual è il suo ruolo? Guarda le spalle alla madre e la avvisa mettendosi a berciare quando vede arrivare qualcuno? E’ un bimbo da difendere, non è ha bisogno, o è lui a difendere la madre? E come? Ha i superpoteri ? Insomma questo dettaglio è tutto da chiarire in funzione dei suoi sviluppi. Se non comporta scelte narrative successive (umoristiche, drammatiche o grottesche) è inutile e rischia di essere controproducente. Ma soprattutto: ne vale la pena? Questa è una questione molto importante. Un fumetto si disegna, un film è un’operazione molto concreta che ha costi economici. Ogni parola che scriviamo in sceneggiatura comporta una spesa e un problema pratico: i cavalli costano, costa l’affitto della sella costa ogni singolo colpo sparato. Un bambino di un anno in scena (sotto il sole, tra l’altro) è un carico molto gravoso, anche quando è presente solo per pochi secondi in un film, figuriamoci per l’intero film. Ci sono leggi a tutela dei minori , tanto per dirne una. Di fronte all’uso di un bambino vero di un anno come co-protagonista, il produttore che legge la sceneggiatura stai sicuro che la richiude subito. Persino in “Tre Uomini e una culla” nella maggior parte delle scene, il neonato è un bambolotto Allora, il nostro è un bambino di Rambaldi? Anche questo costa una cifra che sottrarrà denaro ad altre scene o situazioni del film. Uno sceneggiatore esordiente può pensare che al cinema ci si può permettere di tutto. Non è così. Un film fin dal momento della scrittura dev’essere condotto all’interno di un budget oggetto di mille controlli. Attenzione a non scrivere dei film velleitari che comportano costi esagerati per realizzare situazioni non fondamentali per il film. Magari il produttore farà finta di niente, ma poi state certi che quelle scene verranno eliminate. Quando scriviamo dobbiamo sempre tenere in testa che il film deve essere “fattibile”.
Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com (5/05)
* Esercizio di Vittorio Sossi
Modello 1: L’ingresso ritardato “dicono di lui”. Esercizio.
Il protagonista:
Protagonista della storia è una professoressa di italiano del sud in un liceo classico a Roma, che chiameremo Simona; vive da sola e ha instaurato uno splendido rapporto con i ragazzi. Non è vista di buon occhio dai colleghi più anziani per la sua scarsa attenzione alla disciplina. Ma è di carattere socievole e allegra, non si tira mai indietro nelle attività e ha saputo superare reticenze e convinzioni antiquate. Fino a quando si innamora di un ragazzo ripetente dell’ultimo anno e, quando si sparge la voce della relazione, viene mandata via dalla scuola. Nessuno prende le sue difese.
La storia inizia in questo momento. L’ideale continuazione è raccontare l’antefatto della relazione e alternativamente la prosecuzione.
Ispirazione e citazione dovuta la canzone di Ivan Graziani “Signorina”.
Informazioni che intendo dare.
- La protagonista è una professoressa relativamente giovane e sola.
- È stata cacciata dalla scuola a causa della sua relazione con questo ragazzo ventenne.
- La sua storia non è stata “leggera” come credono tutti.
Approccio 1: intervento di un co-protagonista che fa da collegamento fra il presente e il passato della professoressa.
Siamo nell’istituto scolastico, il primo giorno di assenza di Simona. Inizio delle lezioni..
Un supplente viene chiamato a sostituire Simona. Si informa in segreteria o dal preside, sui motivi e la durata dell’assenza. Ottiene alternativamente sorrisini e sottintesi, o reazioni sdegnate ma niente di chiaro. Si rende conto che l’insegnante è stata allontanata per motivi disciplinari.
L’insegnante di ginnastica, il classico provolone che ci prova un po’ con tutte e che ha ricevuto un garbato rifiuto da Simona, con un linguaggio molto colorito racconta che la professoressa “se la faceva” con un alunno ed è stata allontanata. Noi e il supplente potremmo farci l’idea di una squallida situazione. Ma nel cassetto dell’insegnante il supplente scopre di conoscere la donna, compagna di università e vecchia fiamma; il quadro che gli hanno delineato non corrisponde. Oltre al programma rinviene nel cassetto una lettera per il ragazzo: Raimondo. Evidentemente Simona non aveva avuto il coraggio di dargliela oppure l’aveva dimenticata lì.
Si reca in classe. Risponde alle domande dei ragazzi su quel poco che sa dell’insegnante e sul fatto che almeno per un po’ non tornerà; fa finta di non sapere nulla e saggia le reazioni. Consegna la lettera al ragazzo, solo e silenzioso, che va in bagno a leggerla.
Simona gli scrive che hanno sbagliato tutto, che la loro è una relazione impossibile in quanto infrange le regole: anche se il ragazzo ha vent’anni è pur sempre un suo alunno. Gli spiega che lei andrà via il giorno stesso e tornerà dai suoi in Calabria. Cercherà di dimenticarlo e di ricominciare ad insegnare. Mentre il ragazzo legge vediamo lei che fa le valige e si reca alla stazione.
Il ragazzo scappa di scuola e cerca di raggiungerla alla stazione, ma non arriva in tempo.
Raimondo viene sospeso e decide di raggiungere Simona. Il supplente insegue il suo amore perduto che cerca di rivivere nel ragazzo e i due partono per la Calabria e durante il viaggio si raccontano a vicenda di Simona.
Note: questo è il mio preferito. Possiamo farci un’idea di quello che è successo e delle reazioni nella scuola. L’intervento di Raimondo e del supplente controbilanciano le opinioni generali negative sulla professoressa. La limitazione è che in questo modo si dà già una direzione alla storia e che i due uomini potrebbero diventare più importanti della protagonista.
Approccio 2: La scena dell’ultimo giorno di scuola della professoressa viene vista attraverso i suoi occhi con telecamera in soggettiva. Simona è testimone in prima persona delle reazioni dello scandalo negli alunni e nei colleghi.
Inquadratura dalla finestra del bagno dei professori. Attraverso di essa si possono vedere e sentire gli alunni fuori che aspettano di entrare.
Intuiamo che è il primo giorno di scuola dai loro discorsi e dall’abbigliamento estivo. I ragazzi, soprattutto ragazze, parlano degli insegnanti. Nominano la professoressa di greco e latino e sappiamo che è anziana, severa e antiquata. Hanno paura di lei, lo esprimono con disappunto e termini coloriti. Del professore di ginnastica hanno invece le opinioni più sordide. Si chiedono come sarà il supplente di italiano quest’anno nella cattedra vacante. Fanno le ipotesi più bizzarre.
Sfumiamo.
Stessa inquadratura ma ora siamo in febbraio. Gli stessi ragazzi parlottano davanti all’entrata. Sono eccitati, divertiti ma anche sconcertati. Hanno solo un argomento e parlano della professoressa di italiano, Simona per l’appunto e della sua presunta relazione con Raimondo. Alcuni maschi fanno commenti grossolani e pesanti ma da smargiassi, non cattivi. Le ragazze esprimono opinioni più pungenti e contrastanti. Chi è delusa, chi sconcertata, chi cerca di capire. Finiscono comunque tutti a ridere sull’accaduto.
Arriva la professoressa di latino e il professore di ginnastica. Evidentemente hanno udito in parte i discorsi dei ragazzi. La professoressa di latino interviene decisamente in favore della collega. Sostiene con forza che si è trattato di un malinteso e che tutto verrà presto chiarito dal preside. Loro non devono permettersi di sparlare di un professore.
La telecamera si allontana dalla finestra e notiamo una borsetta sul davanzale.
Dalla porta del bagno entrano la professoressa di latino e un’altra professoressa. La borsetta sul davanzale non c’è più. La professoressa di latino è fuori dai gangheri. E’ infuriata. Inveisce contro Simona e capiamo che prima non ha difeso lei ma cercava solo di difendere l’onore della scuola. Uno dei bagni è chiuso. Bussano ma nessuno risponde. Concludono che sia fuori servizio. Esprime commenti taglienti mentre si lavano le mani. (tipo)
“Ti rendi conto! Approfittare della sua posizione, per abusare di un ragazzo…”
“Anni che insegno in questa scuola e mai e poi mai ho assistito ad una simile vergogna.”
La prima continua…
“Ho parlato con il preside e ci sarà un consiglio di istituto per discutere l’argomento”
“Mai e poi mai voglio vederla più insegnare… Sarebbe da denunciare…”
L’altra più giovane gli dà ragione senza convinzione. E’ più preoccupata della sorte di Raimondo
Le due escono e scopriamo che nel gabinetto chiuso singhiozzante c’è una donna che intuiamo sia Simona. Tiene in grembo la borsetta che era sul davanzale. Ha udito sia le opinioni dei ragazzi che dei colleghi. La donna fugge dalla scuola…
Note: Molto più drammatico. Far vedere direttamente a Simona le conseguenze della sua storia con Raimondo. Capire che qualsiasi cosa di buono abbia fatto è stata spazzata via e nessuno è pronto a prendere le sue difese. Toni forse un po’ troppo tristi. Manca l’ambiguità di giudizio e la condanna è quasi unanime.
Commento di G.M.
Il tuo spunto di partenza è interessante e lo svolgimento attento e vivace. Però c’è troppa carne al fuoco. E’ evidente che non ti è ancora perfettamente chiaro dove vuoi andare a parare con la storia e stai riflettendo su opzioni diverse. Il risultato è una partenza indecisa e che unisce opzioni molto differenti. La prima variante assegna, di fatto, il ruolo del protagonista al supplente. E’ lui (anche se non gli dai un nome, come se per te fosse solo uno “starter”) il vero motore/punto di vista della vicenda che ci conduce a Simona. I commenti del “coro” non sono uditi direttamente dal pubblico, ma dal supplente che fa dunque da tramite (narratore) tra gli stessi commenti e il pubblico. Il pubblico cioè non li ascolta “oggettivamente”, ma attraverso la percezione del protagonista. Questo insinua un dubbio sul seguito della narrazione: se infatti vuoi raccontare la storia di come il supplente cerca di riannodare un rapporto con Simona, e trova invece un’identificazione con Raimondo, allora l’inizio può anche andar bene. Se invece i riflettori della storia sono puntati su Simona e Raimondo, allora l’inizio non va bene perché il supplente ruba loro la scena. Il tuo inizio si presterebbe bene a un film che potrebbe essere persino intitolato “Il Supplente” perché la traccia è proprio questa: un uomo si trova a supplire ad una assenza (quella di Simona) cui lui non ha mai saputo fino in fondo supplire , perché non si tratta semplicemente di una collega, ma di una donna con la quale ha condiviso una relazione e che in qualche modo rimpiange. Inoltre, come insegnante, si troverà di fronte a Raimondo, corresponsabile della vicenda che ha provocato l’allontanamento di Simona. Certo il nostro insegnante non potrà mai, per Raimondo, supplire a Simona e dal canto suo il supplente come si rapporterà con il ragazzo? Da insegnante? Da rivale? Quali conflitti, non solo professionali, susciterà in lui il dover fronteggiare una situazione del genere? Ce n’è più che abbastanza per un film. Certo un film non facilissimo da scrivere, da condurre con grande attenzione psicologica, ma comunque molto interessante e fertile, che si potrebbe avvicinare, come genere e tipo di scrittura, all’”Ora di religione” di Marco Belloccio, con Sergio Castellitto, film che appunto intreccia due momenti: il rapporto individuo-società ( libero pensiero versus pregiudizi) e il ritratto psicologico del protagonista diviso tra istanze diverse (comprensione e rifiuto). Nella seconda variante che proponi (quella più drammatica e che vede subito sicura protagonista Simona, senza intermediari) secondo me indugi troppo al principio. E' più forte partire direttamente dal bagno e dalle opinioni espresse dalle insegnanti, per poi staccare su Simona che piange di nascosto e ha evidentemente udito tutto. E’ una scelta piuttosto coraggiosa quella di partire da un cesso, tu scegli un approccio più normale , dissimulando il bagno con una visione ( dalla finestra, in soggettiva) del cortile della scuola , inquadratura che ci chiarisce subito l’ambiente. Il fatto però che all'inizio gli studenti parlino di un'altra insegnante, ingenera equivoco e rallenta (è un doppio ritardo). E circa l’uso della soggettiva in apertura: questa è sempre una scelta molto delicata , nel senso di “estrema” e fortemente condizionante sul seguito. Appartiene a un altro modello che affronteremo più avanti, a partire da un esame dell’apertura, appunto in soggettiva, di Taxi Driver di Martin Scorsese. Prova invece a pensare che la scena parta proprio all’interno del bagno con le due insegnanti che si scambiano commenti mentre si lavano le mani o si rifanno il trucco allo specchio. Non sappiamo ancora che ci troviamo in una scuola, ma dai riferimenti sparsi nel dialogo, possiamo gradatamente intuirlo. L’ambiente relativamente neutro però (perché in teoria potrebbe trattarsi del bagno di un qualsiasi posto di lavoro) segnala implicitamente che la nostra storia non è poi così specificamente scolastica, che cioè un rapporto affettivo e/o sessuale tra una donna che riveste un ruolo “ufficiale” e un ragazzo molto più giovane che “dipende” in qualche modo da lei, viene socialmente censurato in generale, in qualsiasi ambiente di lavoro. E la relativa non neutralità dell’ambiente se si considera che è un cesso, rende visivamente quanto è implicito nel dialogo (e nel giudizio dell’autore) e cioè che certi pettegolezzi da mobbing e giudizi moralistici sbrigativi, liquidatori, sono appunto roba da cesso. Dunque anche la preoccupazione della seconda insegnante per il ragazzo deve suonare ipocrita (e il dialogo dovrebbe essere più preciso ed espressivo a questo riguardo). Non preoccuparti se i giudizi appaiono troppo concordanti. In questo genere di racconto è giusto che i giudizi per quanto con sfumature diverse, siano univoci, proprio perché certe condanne frutto di pregiudizio ( vedi “Sedotta e abbandonata” di Germi) sono unanimi. Come è evidente questo è un film completamente diverso da “Il Supplente”, inizia “sociale” e dunque l’inizio corale è assolutamente coerente, e prosegue ponendo al centro una questione di nuovo sociale di cui la vicenda privata di Simona e Raimondo è (deve essere) ritratto esemplare. In conclusione: nelle tue due opzioni racconti due storie diverse. La prima è la storia del supplente, la seconda è quella di Simona. Questo doppio possibile percorso, che pone lo sceneggiatore a un bivio , tra due scelte possibili, è molto utile a fare riflettere su quanto dicevo nella premessa sulla necessità di approfondire il personaggio protagonista. La scelta di chi deve essere il vero protagonista è preliminare . Usando il modello “corale” il protagonista sarà sempre e inevitabilmente la persona oggetto dei commenti. Ben altra cosa accade però se il coro ha un personaggio “giudice” alle spalle, perché in questo caso il protagonista è lui e non possiamo perdercelo per strada, anche il resto della storia deve venire raccontato attraverso di lui (“Il Supplente”). Il secondo possibile film è un tipico soggetto “liberal”, cioè da cinema civile, quale si ritrova ad esempio in un famoso film con Shirley McLaine e Audrey Hepburn che interpretano due insegnanti legate da un tenero affetto e censurate socialmente come lesbiche. Il film è Quelle due (The children’s hour) di William Wyler (1962). Quando si sceglie un tema civile, è onesto che l’autore si schieri chiaramente dalla parte del diritto individuale calpestato. Solo per vicende molto più intricate e complesse da giudicare è consigliabile esplorare l’ambiguità, le sfumature e in fondo la poca chiarezza umana nel saper distinguere e giudicare, cioè i limiti stessi del nostro giudizio. In altre parole, la scelta del protagonista e del punto di vista narrativo, è intrinsecamente legata al tipo di storia che vogliamo raccontare e al senso che vogliamo dare alla narrazione. Il protagonista esprime nel suo essere, nel suo comportarsi, nei suoi dubbi, nelle sue decisioni, il senso della storia. E’ questo che fa di lui il protagonista. Scegliere bene il protagonista, vuol dire aver chiaro il senso della storia. Ti consiglierei, per esplorare meglio le possibilità del tuo spunto, di considerare anche una terza possibilità che non hai finora contemplato, e cioè che il protagonista sia Raimondo. Leggi la seconda lezione che parte dal “Laureato” con Dustin Hoffmann (e magari guardati anche un altro bel film :”Grazie Zia” di Salvatore Samperi) e poi prova sulla base di questo modello a raccontare l’esperienza di un adolescente o di un ragazzo alla soglia della maturità che si innamora della sua insegnante e vive una storia con lei . In questo film, il coinvolgimento emotivo/sessuale del protagonista avrà inevitabilmente un ruolo molto più centrale che nelle due precedenti versioni, e il tema “sociale” verrà affrontato attraverso il tema del difficile trapasso tra adolescenza e maturità.
* Esercizio di Luca Barbie
Allego le prime due tavole di una sceneggiatura per fumetti scritta qualche tempo fa per una fanzine su internet e poi abbandonata. Seguo esattamente lo schema del “dicono di lui”, in quanto il protagonista (Michel Borderò) viene presentato attraverso le opinioni di alcuni suoi dirigenti, riuniti per discutere un “caso” curioso e pericoloso. Il mio intento era creare l’aspettativa di qualcosa di anormale in un contesto molto formale e quotidiano come un ufficio ministeriale.
COMMA17/P
TAV 1
L’intera tavola è dedicata alla discussione fra cinque persone (che verranno numerate dall’Uno al Cinque per attribuire i dialoghi). Sono cinque dirigenti ministeriali, perciò piuttosto attempati ma non vecchi, ben vestiti in completi scuri, molto austeri. Dialogano fra loro in modo concitato, con una certa animosità. Sono in piedi, in un corridoio, luogo inusuale per una discussione fra dirigenti e questo fatto, adeguatamente evidenziato dalla matita del disegnatore, dovrebbe incuriosire il lettore. La tavola è fitta di dialoghi e si contrapporrà idealmente alla tavola 2, che ne è invece del tutto priva. Non indicherò, vignetta per vignetta, le inquadrature da fare; essendo una tavola da “leggere” ho intenzione di lasciare al disegnatore carta bianca per le sue valutazioni. Il mio suggerimento è di insistere su piani americani di chi parla e di chi ascolta, dopo una vignetta d’insieme che funga da carrellata introduttiva.
Vig. 1
Uno: “In ventisette anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere!”
Vig 2
Due: “E’…mostruoso! Potrebbe crearci seri problemi… problemi politici…!”
Tre: “Non esageriamo… ammetto, sì, che il fatto è curioso, ma da qui a crearci dei guai…”
Vig 3
Uno: “Stai scherzando? Se solo quel ragazzo sapesse di avere il diritto di parlare col sindacato…”
Tre: “Ma non lo sa! Si farà licenziare senza creare problemi, com’è giusto che sia…”
Vig 4
Quattro: “Dio benedica il comma 17/P!”
Due: “Lasciamo Dio fuori da queste cose…e comunque un po’ mi fa pena quel ragazzo… che prospettive vuoi che abbia, ridotto com’è? Con la sua…emmm… deformità?”
Vig 5
Tre: “Non sono affari nostri! Andrà per la sua strada e…”
Cinque: “Zitti! Eccolo!”
Vig 6
I Cinque ammutoliscono e si voltano verso un punto alle loro spalle che noi non vediamo.
TAV 2
Vig 1-2 (strip)
Dal fondo del corridoio vediamo avanzare un ragazzo di ventisei-ventisette anni, dall’aria giovanile ma col volto rabbuiato, preoccupato; è ben vestito ma non con abiti eleganti e costosi come gli altri. Tiene le mani in tasca. I Cinque lo osservano in silenzio.
Vig 3-4
Il ragazzo (si chiama Michel Borderò) si fa avanti; i Cinque si aprono, per farlo passare in mezzo a loro, ritraendosi, sempre in silenzio, come fosse un appestato.
Vig 5
Dal PV dei Cinque vediamo Michel di fronte ad una porta, di spalle. E’ la porta del Direttore, lo veniamo a sapere dalla targhetta in ottone che fa bella mostra di sé. Michel sfila la mano dalla tasca.
Vig 6
In un bel PP vediamo la mano, stretta a pugno, bussare alla porta. Ciò che non va è che le dita di quella mano sono deformi, molto grosse e tozze, come se al posto dell’ultima falange fosse cresciuto una sorta di timbro da affrancatura. Ma non abbiamo ancora la percezione di cosa sia.
La storia prosegue un flash back: in sintesi si viene a sapere che il nostro protagonista, vittima di un ignobile sfruttamento lavorativo, viene costretto a passare tutto il suo tempo in un oscuro ed enorme archivio a timbrare pratiche su pratiche, fino a che il suo stesso fisico non si adatta allo scopo e muta: le sue dita divengono timbri. A questo punto il soggetto è imbarazzante per il Ministero e viene allora “scaricato” e abbandonato a se stesso, sfruttando le pieghe del contratto e quel fantomatico comma 17/p da cui il titolo. La storia è un po’ kafkiana, ispiratami da racconti reali di miei amici e colleghi, ed aveva il dichiarato scopo di andare a scavare nel torbido mondo del lavoro atipico d’oggi giorno.
Commento di G.M.
In fumetto, rispetto al cinema, il movimento non c’è, va suggerito, e questo costituisce una differenza non da poco. In questo caso però tu mostri bene come un modello di origine teatrale, poi passato al cinema, si possa adattare anche a una storia a fumetti. In particolare nella prima tavola possiamo seguire sia la presentazione del protagonista invisibile e apprendere qualcosa di lui che stimola la nostra curiosità, quanto vedere e dunque presentare i personaggi che parlano di lui. Le differenze più sostanziali dal cinema si notano nella seconda tavola, quando cioè compare il protagonista.
In questo caso la tua presentazione usa in partenza una chiave cinematografica ( al cinema potrebbe trattarsi di una carrellata) , ma poi opera un’inversione di campo, con il protagonista di spalle e infine il dettaglio rivelatore delle sue nocche. Questo genere di inversione anche se abbastanza abituale , non sempre è un vantaggio, a volte può costituire un errore espressivo. Sarebbe sicuramente più efficace mantenere sempre, fin dal suo primo apparire, il protagonista di spalle. Questo fa aumentare il mistero su di lui, potrebbe persino far pensare che abbia un aspetto mostruoso, per poi rivelare dal dettaglio delle dita, di quale deformità si tratta. Lo vedremmo in volto soltanto dopo, quando entra dal Direttore. In fumetto una pluralità di punti di vista serve indubbiamente a risolvere un problema di movimento: non sarebbe né facile, né gradevole se tenessimo per un’intera tavola il protagonista di nuca. In cinema invece il movimento ci permette di rendere la sequenza più intensa sotto il profilo visivo.
Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com (4/05)
Ma cominciamo con il chiarire di cosa parliamo quando, in riferimento al cinema, parliamo di Tragedia. Facciamo degli esempi: i film di Clint Eastwood Mystic River e Million Dollar Baby sono chiaramente ascrivibili al modello Tragedia. Ma come per la Commedia, anche per la Tragedia, molte possono essere le sfumature di tono, di stile e di racconto. Rientra nella Tragedia il dramma sociale e/o psicologico di classici come Roma città aperta di Rossellini, Ladri di biciclette di De Sica, Fronte del porto di Kazan, o per citare esempi più recenti, Philadelphia di Demme, Le onde del destino di Von Trier, La Morte e la Fanciulla di Polanski (e ho citato apposta film estremamente diversi tra loro). Fa parte della Tragedia anche il drammone sentimentale, cosiddetto Strappalacrime (e dunque classificato tradizionalmente in un filone meno nobile), di Anonimo Veneziano di E.M.Salerno, Love Story di Hiller, Titanic di Cameron. Ne fa parte anche il dramma famigliare narrato con mano più discreta come La stanza del figlio di Moretti o Ricordati di me di Muccino. E per opposizione, anche un film come La Passione di Gibson che porta la Tragedia ai limiti del truculento. Della Tragedia è tradizionalmente fratello anche il Dramma Epico, come Apocalypse Now e Il Padrino di Coppola. E alla Tragedia si ispirano i film che trattano le biografie di personaggi illustri, come Toro Scatenato di Scorsese o il suo più recente The Aviator. Come si può vedere da questo sommario elenco, la Tragedia (almeno in senso lato) è dunque un genere più frequentato di quanto si pensi , anche se si stenta sovente a riconoscerlo come tale, perché i singoli film tendono tutti all’esemplarità, cioè ad apparire e ad apparirci come unici e dissonanti rispetto alla produzione corrente. Eppure sono film che molto più di altri, si fondano su regole di scrittura assolutamente ferree, fino all’implacabilità , e richiedono in genere nel narratore, sceneggiatore e/o regista, una totale , assoluta mancanza di pudore nell’uso, a volte persino cinico, dei “ferri del mestiere” , inclusi quelli più usati e abusati.
a) Le Origini
Anche in questo caso sarà utile cominciare da Aristotele, che nella sua Poetica, o almeno in quanto dell’opera ci è pervenuto, tratta diffusamente della Tragedia, delle sue origini, delle sue caratteristiche e della sua struttura di base. Sono talmente numerose e ricche di suggestioni le notazioni del grande filosofo greco, che ovviamente non ci è possibile esaminarle tutte. Qui ci limiteremo a quelle che possono fornirci indicazioni interessanti ai fini del nostro argomento (la sceneggiatura cinematografica e in particolare il disegno dei personaggi).
Per definire le caratteristiche della tragedia Aristotele usa questi termini:
1. azione di carattere elevato (con il termine “elevato” si intende superiore all’ordinario, moralmente esemplare, serio in contrapposizione al faceto proprio della Commedia;
2. azione completa e di una certa estensione (cioè non frammentaria, una storia narrata dal principio alla fine e con una consequenzialità rigorosa e puntuale, libera da ogni frettolosità narrativa e dunque, diremmo oggi, da un format troppo limitato nella durata) ;
3. di linguaggio abbellito ( cioè la parola ha una certa supremazia, gli argomenti vertono sugli interrogativi fondamentali dell’esistenza, i personaggi esprimono opinioni, ma anche l’aspetto tecnico e stilistico della messa in scena, cioè il linguaggio narrativo dell’autore deve rifuggire da ogni rozzezza).
Ciò spiega l’origine del luogo comune di cui si parlava sopra: cioè che i film (come i romanzi o i lavori teatrali) che si riferiscono alla Tragedia, ci sembrano più “elevati” , più seri e più degni di riconoscimento. Come ho ricordato nella precedente lezione, all’origine della rappresentazione scenica stanno i generi cosiddetti minori: spettacoli di musica e danze o di puri lazzi e sberleffi, che indulgono all’osceno, e mirano a suscitare ilarità, eccitazione o repulsione, insomma a sollecitare emozioni primarie. E’ con la Tragedia che nasce il racconto vero e proprio, la narrazione organizzata con un inizio, uno sviluppo e una fine. La Tragedia ci appare dunque come genere superiore, perché anche narrativamente più”completo”. Anche la Commedia ha avuto un’evoluzione in senso narrativo ( ne abbiamo parlato nella precedente lezione) , ma lo stereotipo della Tragedia come genere più “evoluto” e maturo è rimasto egualmente in noi ( e nella critica, la cui ignoranza in proposito è certo più ingiustificabile di quella del pubblico).
C’è poi un altro e fondamentale aspetto che, attraverso la natura dei personaggi tragici, rimanda al modo in cui il pubblico vive le emozioni, e di ciò si parla nel prossimo paragrafo.
b) I Personaggi Tragici
Può sembrare dalla classificazione Aristotelica sopra esaminata, che i protagonisti della Tragedia, persone così poco comuni, siano caratteri forti, veri dominatori degli eventi, invece è l’esatto contrario. Scrive Aristotele in uno di passi più difficili e più profondi della Poetica, spesso trascurato: “ I personaggi di una tragedia non agiscono allo scopo di rendere certi caratteri, ma assumono certi caratteri perché siano effettuate certe azioni. Le azioni sono il fine della tragedia e il fine è la cosa più importante di tutte. E se non è possibile che si diano tragedie prive di azione, ce ne possono essere invece senza caratteri.”
Per azione, occorre precisare, Aristotele intende un racconto attraverso i fatti, gli eventi. Di questi fatti ed eventi, il protagonista della tragedia è succube. Li vive come Destino ( le Onde del Destino, verrebbe da dire). La tragedia si fonda insomma su un paradosso: narra un’azione inattiva, cioè un’azione che il protagonista subisce. Egli non ne è attore, ma come sosteneva Carmelo Bene, è agito. I protagonisti apparentemente forti della Tragedia, sono in realtà l’esatto contrario. I fatti potrebbero in teoria prescindere da loro, cioè per usare le parole di Aristotele “può darsi tragedia senza caratteri”.
Se rileggete quanto abbiamo spiegato nella lezione precedente a proposito della Commedia, genere che per eccellenza non può esistere senza caratteri, perché nella Commedia i fatti e le azioni sono estrinsecazioni dei personaggi, la Tragedia è costruita su uno schema esattamente contrario: conta la storia (potremmo dire) , cioè quello che vogliamo fare avvenire, e i personaggi contano soltanto in quanto subordinati ai fatti.
Riguardo ai personaggi, scrive sempre Aristotele, cosa ci mostra la storia narrata? Il loro “cambiamento dalla infelicità alla felicità o dalla felicità all’infelicità”. Insomma i personaggi della Tragedia non possono e non devono cambiare i fatti, l’unico cambiamento da narrare è quello che i fatti, che avvengono indipendentemente da loro, determinano nella loro condizione emotiva.
Infine un passo davvero fondamentale è quello in cui Aristotele ci parla della “straordinarietà” di questi fatti. Comincia col dire che le azioni devono sorgere inaspettate per noi, però poi una volta in moto, si determinano necessariamente l’una dall’altra . E precisa: “ Tra i fatti che avvengono per caso, sembrano straordinari quelli che fanno pensare siano avvenuti a bella posta. Come la caduta della statua di Miti, in Argo, che uccise, cadendogli addosso, mentre la guardava, chi fu causa di morte dello stesso Miti. Fatti codesti che non par davvero siano avvenuti per puro caso.”
Ecco dunque spiegato cos’è un personaggio schiavo del proprio destino. Si verifica un tipico evento casuale ( una morte, una malattia) , che determina un profondo cambiamento in chi lo subisce (dalla felicità all’infelicità, nel caso) , ma il protagonista è tale che questo fatto a lui occorso non ci appare affatto casuale, ma diremmo con termine più moderno”predestinato”, ci può sembrare a volte, persino che il protagonista se lo sia meritato.
Il vero deus della Tragedia è l’autore. E’ lui a stabilire i fatti e gli eventi. E’ lui a forgiare i protagonisti prefiggendo loro un destino. Mentre nella Commedia è il carattere dei personaggi a guidare l’autore al racconto di fatti nei quali questo carattere possa meglio estrinsecarsi, nel racconto tragico il protagonista dipende totalmente dal tracciato che l’autore ha stabilito per lui.
Se dunque, nel senso comune, il burattino e la marionetta sono associati alla Commedia, in realtà sono i personaggi tragici i più manovrati, i meno autonomi, i più schiavi della volontà dell’Autore e della sequenza di eventi che l’Autore ha deciso loro di infliggere.
c) Il Fine della Tragedia
Torniamo ora al passo iniziale in cui Aristotele sostiene che nella Tragedia, il fine “è la cosa più importante di tutte”. ( E si potrebbe aggiungere che per l’Autore il fine giustifica i mezzi, e cioè ogni tecnica dev’essere spietatamente messa in campo purché il fine sia raggiunto). Ma qual è questo fine? E’ noto che per Aristotele il fine della Tragedia è “suscitando il terrore e la pietà, pervenire alla purificazione di tali affezioni.” E la famosa teoria della Catarsi. Per “tali affezioni”, Aristotele non intende la rappresentazione/imitazione delle emozioni, ma i sentimenti che proviamo nella vita reale. Per dirla rozzamente, il fatto che simili sentimenti vengano imitati e rappresentati su una scena “finta”, da un lato ce li fa rivivere, dall’altro ci conforta perché sappiamo che non sono reali e dunque possiamo in qualche modo partecipare all’emozione del protagonista senza soffrirne veramente e soprattutto senza patirne le conseguenze.
Questo è un altro motivo della segreta predilezione del pubblico (di noi pubblico) per la Tragedia. Una Commedia, come abbiamo visto, può divertirci, ma lasciarci anche degli interrogativi di non poco conto, per esempio sui ruoli sociali (quelli reali) che possono, dopo e al di là dello spettacolo, apparirci falsi, convenzionali e passibili di cambiamento. La Tragedia invece si interroga apparentemente sulle grandi e insolute questioni dell’esistenza, e dunque ci appare più profonda, ma in realtà lascia (nel suo stesso racconto) le cose inalterate, ci dice che esse nella loro ferrea dinamica non sono passibili di cambiamento. L’esistenza ci appare imprevedibile, ma poi segnata dagli eventi in modo deterministico e del tutto sottratta alla nostra volontà. Di fronte ai fatti non possiamo fare che altro che provare emozioni (felicità/infelicità), cioè Patire.
Questo patire, cioè un subire passivo in cui l’unica attività possibile è partecipare intensamente all’emozione provata, è la stessa condizione in cui si trova il pubblico che allo spettacolo assiste, e al quale può partecipare solo emotivamente. Non c’è dunque semplicemente l’effetto consolatorio della Catarsi (“dio mio quanto ho pianto, ma per fortuna era solo un film”) c’è nel dato oggettivo della presenza a uno spettacolo, un’identificazione naturale con protagonisti che come noi, subiscono e partecipano emotivamente, perché altro non possono fare.
Si è discusso molto e ancora si discute se sia davvero la Catarsi il fine del racconto tragico. Secondo molti autori, in realtà il fine è semplicemente suscitare quelle emozioni, che da pubblico, nella nostra stessa condizione di spettatori, ci permettono facilmente di identificarci con il destino dei protagonisti.
Non voglio sostenere con questo che certi drammi non ci aiutino anche a cercare di cambiare le cose. Se partecipiamo al dramma vissuto dal protagonista di Philadelphia, certo possiamo confortarci col fatto che non abbiamo perciò preso l’Aids, ma possiamo anche venire stimolati a comprendere lo stato d’animo e la condizione di chi è diverso da noi e possiamo imparare a solidarizzare con i malati di Aids. Dunque sarebbe sbagliata qualsiasi semplificazione che ci facesse pensare che la Commedia cambia la vita, mentre la Tragedia la riconferma, e che dunque la Commedia è progressista e la Tragedia reazionaria. Non è proprio questo il problema. Liberarsi dai luoghi comuni non significa precipitare in luoghi comuni speculari.
Il problema è che le due narrazioni , quella della Commedia e quella della Tragedia, nascono da un punto di vista opposto. Se scriviamo una commedia, è indispensabile partire dai caratteri. Se scriviamo una Tragedia, dobbiamo partire dai fatti. Starà poi alla nostra sensibilità di autori stabilire se la nostra Commedia intende essere sovversiva rispetto ai ruoli sociali, mostrandone l’inconsistenza, oppure (come accade in molte commedie) riconfermarli , mettendo per esempio in satira i comportamenti delle minoranze al solo scopo di irriderli. Starà alla nostra sensibilità di autori stabilire se la nostra Tragedia intende prospettare al pubblico l’ineluttabilità delle cose, oppure proprio a partire da questo vissuto di ineluttabilità, stimolare le emozioni e le idee per esaltare (come in Antigone) l’urgenza e la necessità di un riscatto e di un cambiamento radicale.
In entrambi i generi, l’autore ha a che fare con il necessario superamento dei propri pudori. Nella Commedia non bisogna temere di andare fino in fondo nell’accumulo degli equivoci e nella sagra dei mascheramenti/smascheramenti. Ma potete farlo anche restando “buoni”. Nella Tragedia ,molto più che nella Commedia, si devono fare accadere le cose meno augurabili, e non possiamo che essere “cattivi” nei confronti dei personaggi (e del pubblico).
Per fare un esempio celebre: è stato certo un trauma ben poco catartico, infliggere al pubblico infantile (e anche a quello adulto) la morte della mamma di Bambi. Che Bambi resti un capolavoro nella storia del cinema, non c’è dubbio. Ma la stessa Disney mostrò di considerarlo un errore, sotto il profilo pedagogico. E dopo quel film si usò molta maggiore delicatezza nel presentare ai bambini eventi traumatici, per esempio facendo morire il padre (come nel Re Leone), sacrificio psicologicamente meno sconvolgente di quella della madre. D’altro canto se il pudore avesse contagiato gli sceneggiatori di Bambi, magari suggerendo loro di fare riapparire la madre rediviva (come la nonna di Cappuccetto Rosso dal ventre del lupo), non solo la Tragedia sarebbe andata a farsi benedire, ma si sarebbe indebolita la forza espressiva del film.
Se non ve la sentite di uccidere la madre di Bambi, non mettetevi a scrivere Tragedie.
E’ di una crudeltà inaudita che la coraggiosa e leale pugile di One Million Dollar Baby venga non solo aggredita alle spalle dalla sua violenta, criminale e impunita avversaria, ma che vada addirittura a sbattere la testa contro lo sgabello incautamente sistemato sul ring dal suo allenatore. Ma questo snodo attua perfettamente l’insegnamento di Aristotele: l’evento casuale ( e cosa può esserci di più casuale e assurdo di uno sgabello sistemato sul ring al momento sbagliato) ci appare necessario, inevitabile, predestinato. Nel caso, nessuno lo ha meritato, né la giovane pugile, né il suo allenatore, però per tutto il corso della narrazione abbiamo visto l’allenatore cercare di dissuadere la giovane dal pugilato e ora possiamo concluderne che “si sapeva come sarebbe andata a finire, ma nessuno ha fatto niente per evitarlo.” Ne soffriamo doppiamente. E questa è la legge della Tragedia.
ESERCIZIO – Anche stavolta, come nella precedente lezione, l’argomento è troppo ampio per poter suggerire degli esercizi, ma anche questa volta vi raccomando lo studio di un film, cioè Kramer contro Kramer (1979) di Robert Benton. Il film non è una Tragedia a fosche tinte, ma esprime molto bene il tipo di Dramma per cui il cinema contemporaneo pare più portato . L’attore protagonista è lo stesso di Tootsie, cioè Dustin Hoffmann, e credo possiate trovare interessante vederlo alle prese con un copione di opposta scrittura. Il confronto tra i due film, può essere molto utile a farvi intendere quanto possa cambiare il disegno di un protagonista, e come sia necessariamente diverso il suo rapporto con gli eventi, in una Commedia e in un Dramma.
Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
In questa lezione si prendono in esame altri due modelli di presentazione del protagonista, modelli molto diversi tra loro, ma che hanno una caratteristica in comune: il protagonista è anche il narratore del film. Questa soluzione corrisponde, in romanzo, al racconto in prima persona.
I due diversi modelli sono:
1. La voce fuori campo ( o Voce Off) del protagonista si sovrappone alla scena, anche quando lo stesso protagonista già compare nella scena. E’ un modello che proviene dalla narrativa e in particolare dal “noir”, dai gialli in cui il protagonista (spesso un detective, ma non necessariamente) ricostruisce e racconta i fatti dopo che essi sono avvenuti. Il racconto è dunque racconto del passato, la voce narrante è la voce della memoria: la memoria del protagonista e la “futura memoria” di chi ascolterà il suo racconto. Billy Wilder ha usato questo modello in modo esemplare in due suoi capolavori:La Fiamma del Peccato , in cui il protagonista-narratore si confessa al registratore, già moribondo, e Viale del Tramonto in cui il protagonista-narratore è addirittura un morto, il suo racconto è dunque il racconto di un fantasma. C’è sempre un tono di confessione drammatica, anche quando il racconto non indulge affatto al sentimentalismo, in questo procedimento narrativo. Usarlo fuori da questo contesto non è in linea di massima consigliabile.
2. Il protagonista parla direttamente al pubblico, in voce e in persona, guardando nella macchina da presa e presentandosi, spesso su sfondo neutro. Questo modello proviene dal teatro, dove si chiama à part. Nella commedia dell’arte e nel teatro settecentesco derivato dalla commedia dell’arte (vedi Marivaux o Goldoni) la rappresentazione, al principio o in corso, viene come congelata e sospesa. Il protagonista fa un passo avanti e si rivolge direttamente alla platea, a volte per rivelare propri pensieri nascosti ( che devono restare nascosti agli altri personaggi) a volte per instaurare un rapporto diretto con il pubblico, uscendo così dalla storia narrata e rivelandosi come narratore, commentatore, persino come autore della messa in scena. Questo modello è tipico della commedia brillante. C’è infatti un’evidente ironia nel fatto che il protagonista prenda, come narratore, “distacco” dalla vicenda e persino da se stesso come personaggio.
Cos’hanno in comune dunque questi modelli? Il coro, che nel modello “parlano di lui” della Prima Lezione esercitava di fatto il ruolo di chi introduce al pubblico il protagonista e riferisce le premesse indispensabili a comprendere la storia che seguirà, perde la sua coralità, non è un insieme di voci, ma una galleria di figure distinte: “gli altri personaggi” . Non è il coro (la società) a narrare i fatti, ma lo stesso protagonista (l’individuo). La vicenda è tutta raccontata dal punto di vista del protagonista. L’oggettività di quanto accade è dunque una ricostruzione soggettiva.
Questo comporta una scelta che dominerà tutta la narrazione successiva. Il protagonista può raccontare solo fatti cui ha assistito personalmente o di cui è venuto direttamente a conoscenza. Dunque lo sceneggiatore non potrà facilmente staccare su un’altra situazione, su eventi paralleli che il protagonista non ha vissuto e non conosce. Il protagonista sarà sempre in scena. E quando non ci sarà dovrà comunque essere al corrente di quanto è accaduto indipendentemente da lui.
Il genere drammatico e quello comico si prestano particolarmente ai due diversi modelli proprio perché in entrambi il protagonista, le sue riflessioni, la sua esperienza di vita, sono il vero centro della narrazione. E la narrazione è anche racconto della sua “presa di coscienza”.
Questo non significa però che ogni altro personaggio debba diventare per forza di cose secondario, anzi è vero l’opposto. Nei due film di cui esamineremo in breve l’inizio, ma che vi raccomando di vedere nella loro interezza, l’esperienza del protagonista è segnata dall’incontro con una donna (con un altro da lui, anzi una sua opposizione). Fin dal titolo è chiaro che quest’altra persona è presentata dal protagonista come la vera protagonista della vicenda che lo ha visto coinvolto. Infatti il primo film si intitola Gilda e il secondo, nell’originale, Annie Hall (solo nella versione italiana è diventato Io e Annie). Il protagonista narratore ( Glenn Ford nel primo film, e Woody Allen nel secondo) mentre si presentano, in realtà cedono o “simulano” di cedere la scena alla donna che drammaticamente nel primo caso, simpaticamente nel secondo, hanno travolto la loro vita.
Insomma l’ego trip abbastanza inevitabile in questo genere di racconto viene opportunamente corretto da una sorta di cessione della scena “all’altra”, e l’autobiografia del protagonista è anche la storia di una contraddizione svelata, di un cambiamento nella propria vita, di un’irruzione “fatale” che ha spezzato il narcisismo del protagonista e compromesso/svelato la sua finta quanto esibita sicurezza di autosufficienza.
Tutte queste implicazioni vanno tenute ben presenti, quando si sceglie di usare questi modelli.
Usare la voce fuori campo come puro espediente di comodo per sintetizzare certi passaggi della vicenda è una soluzione poco efficace e piuttosto misera, che può risultare fastidiosa. Si può invece benissimo usare la voce fuori campo di un terzo personaggio che non è né il protagonista né la protagonista, ma un testimone della vicenda, una sorta di “coro” individuale . E’ la soluzione brillantemente usata da Clint Eastwood, nel suo recente Million Dollar Baby.
Usare l’autopresentazione al pubblico è anche più rischioso, anzitutto se il protagonista non è un uomo di spettacolo o un movie maker che per esprimersi d’abitudine usa la cinepresa (o la web cam) e il proprio corpo d’attore, invece della carta scritta e del semplice racconto orale. Nell’auto presentazione visiva inoltre è implicita una buona dose di spudorata “sincerità” e di esibizionismo, dunque il modello applicato a un personaggio che non abbia queste caratteristiche non risulterebbe coerente, né credibile.
In conclusione, questi modelli sono da usare con estrema consapevolezza e legano la narrazione molto di più di quelli presentati nelle due precedenti lezioni. E va anche osservato che mentre i modelli delle prime due lezioni si possono sposare (guardate per esempio l’inizio di Lawrence d’Arabia che ci presenta il protagonista in corsa folle sulla sua motocicletta per morire subito, e poi alla sua celebrazione solenne dopo i funerali, mette in scena il coro che “parla di lui”) i due diversi modelli presentati in questa lezione molto difficilmente possono venire mescolati ad altri.
1. GILDA (1946) Soggetto di E.A.Ellington; Adattamento di Jo Elsinger; sceneggiatura di Marion Personnett ( revisionata dalla produttrice/sceneggiatrice Virginia Van Upp); regia di Charles Vidor.
- Il protagonista maschile.
Johnny Farrell ci appare, scarmigliato, in un vicolo mentre gioca a dadi. La sua voce fuori campo recita: Per me un dollaro era un dollaro in ogni lingua. Era la mia prima sera in Argentina e non sapevo molto degli abitanti del posto, ma conoscevo i marinai americani e sapevo che era meglio starne alla larga.” Johnny vince una bella mazzetta di dollari e prudentemente si allontana. Verrà fatto subito oggetto di un’aggressione e la affronterà con calma imperturbabile, fin quando uno sconosciuto, un nuovo e misterioso personaggio destinato ad essergli amico e socio, giungerà a scacciare il ladro.
Il protagonista, un giocatore d’azzardo, ci viene subito presentato in azione. E’ un uomo che si gioca la vita a dadi. Esperto e abituato a fronteggiare i rischi. In un minuto di rappresentazione, il suo ritratto è già compiuto.
A rapidi stacchi vedremo Johnny passare dalle stalle alle stelle. L’uomo che lo ha salvato nel vicolo è proprietario di una lussuosa sala da gioco, nella quale Johnny fa rapidamente carriera fino a diventare braccio destro del capo. Il suo amico si fida a tal punto di lui, da lasciargli la gestione della sala, quando è in viaggio.
- La protagonista femminile.
Gilda appare dopo un quarto d’ora dall’inizio del film. La sua presentazione non è improvvisa come quella di Johnny, ma ritardata in modo esasperato. Il biscazziere amico di Johnny è tornato da uno dei suoi viaggi e Johnny lo va a trovare. C’è un’altra presenza in casa, si sente risuonare una musica dal primo piano e una voce femminile che canta. I due salgono le scale, attraversano una porta, sostano, in ascolto: Johnny è a disagio come se presagisse il peggio, l’altro è fiero ma anche stranamente mellifluo. Attraversano un’altra porta. Per primo, il padrone di casa: Gilda, sei presentabile? Finalmente lei entra in campo, in primo piano, sollevando la testa di scatto e gettando i lunghi capelli all’indietro. Sì. Nota la presenza di Johnny, si fa più controllata, si tira su una spallina, ma fa la dura e aggiunge una frasetta che suona allusiva: Lo sono più del necessario. Che significa? Ha già conosciuto Johnny? E’ stata una conoscenza intima?
Il film è un noir. Gilda ha tutte le caratteristiche della femme fatale. Non è importante sapere da dove viene, come e quando il biscazziere l’ha conosciuta, perché l’ha sposata. E’ importante vederla e coglierne il carattere: le piace il lusso, le piace cantare e curare il suo corpo, sa usare fino in fondo il suo fascino, non è una sentimentale o se lo è, lo nasconde sotto un atteggiamento sprezzante.
Commento
La prima cosa da segnalare è che la sceneggiatura di questo film è stata rielaborata fino all’ultimo, passando da diverse mani. Intere scene sono state aggiunte a lavorazione quasi ultimata e tra queste, due davvero fondamentali: i numeri musicali di Rita Hayworth ( Put the blame on me, Amado mio). Le due canzoni illuminano un contrasto interiore del personaggio, da un lato la sua fiera consapevolezza di essere “una peccatrice” (Put the blame on me), dall’altro la sua capacità di essere un’amante appassionata e devota, quando ciò è inevitabile ( Amado mio, love me forever) . Molti dialoghi vennero corretti a film già terminato. Questo per farvi capire che il lavoro dello sceneggiatore non è da considerarsi affatto concluso a copione terminato. Il lavoro dello/degli sceneggiatori è sempre suscettibile di miglioramento e accompagna il film fino all’ultimo momento utile prima dell’edizione definitiva. Questa continua revisione può certo seminare qualche incertezza e anche qualche lungaggine nel racconto ( intorno alla metà del film, il racconto di Gilda si fa piuttosto confuso e certo smarrisce la brillantezza dell’inizio), ma può anche irrobustire il film con dei momenti che risollevano l’attenzione del pubblico, narrativamente fondamentali ed espressivamente molto intensi.
Studiatevi bene le scene che intercorrono tra la presentazione di Johnny e quella di Gilda, in particolare l’incontro di Johnny con il biscazziere (Ballin Mundson) dove il dialogo pare la fiera dell’irrealtà e dell’improbabilità, scelta di grandissimo coraggio che da un lato asseconda la rapidità, dall’altra ci introduce a un mondo e a una vicenda in cui “tutto può accadere”, anche se come presto capiremo, la vicenda è predestinata, i suoi sviluppi “inevitabili”. E’ una storia che nasce e finisce sotto l’insegna del Fato. E questo dà anche ragione della scelta iniziale, cioè del farla raccontare dalla voce off del protagonista.
Seppure entrambe fulminanti, le apparizioni del protagonista (subito in campo) e della protagonista
(ingresso ritardato) sono opposte e ci mettono dunque di fronte a due personaggi contrapposti. Il protagonismo maschile è un protagonismo della presenza costante, quello femminile è protagonista anche nella sua assenza, perché sa farsi aspettare e desiderare , e poi non delude certo l’attesa, anzi la supera. E’ immagine pura, assoluta protagonista dell’inquadratura, oltre che del film.
Le prime parole dei due sono scolpite. Per me un dollaro era un dollaro in ogni lingua. Johnny si presenta attraverso la sua filosofia di vita. Sono più presentabile del necessario. Gilda non parla della sua filosofia, ma del suo corpo. La sua consapevolezza è consapevolezza fisica. La sua ironia è una lama a doppio taglio: parla di sé, ma è anche un messaggio rivolto a qualcuno.
2. ANNIE HALL (Io e Annie) (1977) Scritto da Woody Allen e Marshall Brickman. Regia di Woody Allen.
- Il protagonista maschile.
Alvy Singer ( il personaggio interpretato da Woody Allen) parla, su fondo neutro, direttamente al pubblico, di fronte alla MDP che rimane fissa su di lui.
C’è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: Ragazza mia, il mangiare qui fa veramente pena. E l’altra: Sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole! … Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita: piena di solitudine, di miserie, di sofferenze, di infelicità e disgraziatamente dura troppo poco. E c’è
un’altra battuta che è importante per me. E’ generalmente attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta all’origine al genio di Freud e che è in relazione con l’inconscio e che recita così, parafrasandola: Non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me… Questa è la fottuta chiave della mia vita di adulto nei confronti delle donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui quaranta e penso di attraversare una crisi o che so, chi lo sa… oh, io non mi preoccupo di invecchiare, non sono di quei tipi…lo so, quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo, anzi credo che migliorerò invecchiando… il tipo virilmente calvo, cioè l’esatto contrario del tipo argentato distinto, ecco… e se no, nessuno dei due, divento uno di quelli che perdono i filini di bava dalla bocca, vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo… Annie e io abbiamo rotto e io ancora non riesco a farmene una ragione.
Il protagonista, un commediografo di successo, ma in particolare un creatore di battute, si presenta senza bisogno di chiarire il suo mestiere, semplicemente dicendo una serie di battute.
Attraverso le battute ci chiarisce la sua filosofia di vita. Ci chiarisce anche il suo carattere autoironico, ma anche autoindulgente. La sua attitudine a divagare, la sua inclinazione alla logorrea. Ci mette parecchio ad arrivare al punto, ma quando lo fa è deciso, chiaro e inequivocabile. Io e Annie abbiamo rotto.
Il protagonista continua la sua auto-presentazione risalendo all’infanzia ( che vediamo in alcune divertenti scene esemplari), alla sua famiglia, al suo quartiere, al suo successo da adulto, al suo migliore amico, finché lo ritroviamo importunato all’ingresso di un cinema da qualcuno che lo riconosce vagamente per averlo visto in TV. Dall’inizio del film sono passati circa 9 minuti.
Il racconto è stato svolto a rapidi stacchi. Più di trent’anni sono passati in questi nove minuti.
- La protagonista femminile.
Alvy, fuori dal cinema, era in attesa di Annie. Sopraggiunge un taxi. Lei scende, con un abito molto anni 70, casual, curato, ma senza sfoggio di eleganza né di seduzione. Non guarda neppure in faccia Alvy.Le sue prime parole sono: Sono proprio di pessimo umore.
Il film è una commedia. L’attesa per l’apparizione della protagonista c’è, ma è un’attesa senza mitizzazioni, quotidiana. Lei scende da un taxi. La MDP non ce la mostra in PP, né da sola, ma a contrasto con l’ansia e l’atteggiamento normalmente risentito di lui, subito spezzato da una presa di distanza: niente discussioni, sono di pessimo umore. Come dire: un fatto mio, tu non c’entri niente. Lui non è un avventuriero, lei non è una dark lady. Sono due di noi.
Commento.
Nell’assoluta diversità dei due film, divisi da trent’anni, da generi opposti, da bianco e nero e colore, avrete notato le analogie narrative. Un minuto per la presentazione di Johnny, tre per l’enfatica auto-presentazione di Alvy. Un passaggio narrativo in “riassunto” per sintetizzare il vissuto del protagonista e portarci al vero punto focale della storia: l’apparizione di Lei. Di una Lei attesa. Di una Lei che si fa attendere.
Le scene “riassuntive” sono comunque, in entrambi i casi, ben lontane dalla frettolosità di una narrazione sbrigativa e puramente informativa. Sono anzi costruite, in ogni singolo stacco, come scene con un principio e una fine. Il passato è presentato per tappe e per momenti esemplari.
Il dialogo riveste una funzione essenziale. I protagonisti maschili si presentano attraverso la loro filosofia di vita. Le protagoniste femminili attraverso la loro condizione, il loro essere nell’istante.
I protagonisti maschili narrano la storia (e narcisisticamente si inscrivono nella Storia) , le protagoniste femminili sono la vita, prima e al di là della biografia. I primi “si proiettano”, le seconde “sono” (proiettate quanto si vuole, ma in fondo inattingibili). I primi rievocano, le seconde vengono evocate.
Si può legittimamente obiettare a questa differenza di “ruolo”, del tutto culturale, ma quasi sempre presentata come “naturale”, come “regola”. Non è sufficiente considerare che il primo film (Gilda) è stato scritto da due sceneggiatrici e prodotto da una donna. I ruoli definiti sono comunque quelli.
Si può raccontare una situazione capovolta? Dove cioè sia Lei a narrare, e Lui ad essere narrato? Naturalmente sì, ma senza smarrire la consapevolezza di quanta attenzione anche psicologica sia necessaria per distinguere i ruoli e presentarli (nel primo quarto d’ora del film) nel modo più coerente. L’impresa è tale da far tremare i polsi se si considera che nessuno ha finora osato fare un remake di Gilda “dal punto di vista di Gilda” , però Diane Keaton in Looking for Mr. Goodbar (In cerca di Mr.Goodbar) qualcosa del genere lo ha fatto, e con notevole efficacia.
Esercizio
L’esercizio che vi propongo questo mese ha lo scopo di verificare se qualcuno di voi si è preso la briga di studiare i film fin qui proposti. Dunque anche se potete continuare a mandare i vostri elaborati, questa volta consiglio di scegliere uno dei film fin qui esaminati e vederlo con attenzione, scena per scena. Rispondendo in particolare a questa domanda: a parte l’inizio del film, quale scena del film vi ha colpito di più? Descrivetela. E valutate: Cosa accade al protagonista in questa scena? Dove è collocata questa scena, a che punto del film? Perché secondo voi è esemplare e cruciale?
Il prossimo aggiornamento, ai primi di luglio. Nella prossima lezione, a partire da Taxi Driver di Martin Scorsese esamineremo il protagonista presentato in soggettiva dello stesso protagonista, cioè attraverso il suo modo di vedere la realtà. L’identificazione del pubblico con il protagonista,viene spinta avanti al punto di farci vedere il film con gli occhi stessi del protagonista.
Lezione 3 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Nella precedente lezione abbiamo visto il protagonista presentato dal “coro”. Qui esamineremo il modello opposto. Il protagonista appare per primo ed è lui a condurci alla scoperta degli altri personaggi. Questo genere di approccio non esclude affatto la rappresentazione dell’ambiente sociale, ma attribuisce all’individuo e alla sua psicologia un ruolo da subito più autonomo e centrale. Non è attraverso l’ambiente sociale che comprendiamo e giudichiamo l’individuo, ma è attraverso un individuo esemplare che comprendiamo e giudichiamo la società.
Porre al centro del racconto una biografia, in cinema, non significa necessariamente raccontare l’intera vita di un personaggio (come in Citizen Kane). Può bastare la narrazione di un momento del tutto particolare della vita del protagonista, un momento unico che tuttavia ce ne illumina i tratti psicologici fondamentali. Non ci interessa, in questo caso, sapere quali siano state le esperienze infantili del personaggio, né come egli sviluppi e concluda la propria esistenza. La morte del protagonista può anche essere raccontata, se necessaria al disegno compiuto della sua personalità, ma le conclusioni possono essere molte e diverse: aperte verso nuovi e possibili sviluppi, chiuse come un cerchio che torna su se stesso riaffermando una sorta di permanente “stato dell’anima” di cui il personaggio è e resta prigioniero, oppure chiuse in quanto destinate a non ripetersi perché “superate”. Lo stesso vale per la nascita o l’infanzia . Si possono raccontare se sono fondamentali per comprendere la genesi del carattere del protagonista, le contraddizioni della sua attuale condizione sociale e psicologica, ma possono anche venire considerate per “date” e implicite, soprattutto se il ritratto psicologico del protagonista non è di tipo psicoanalitico classico, ma comportamentale. Sta all’autore, insomma, scegliere il percorso. Qui ci limiteremo ad esaminare come si presenta il protagonista da subito e “in azione” e come si possa, a partire da lui, incontrare il suo ambiente e gli altri personaggi. Presenterò due esempi tratti da Il Laureato (The Guaduate, 1967) di Mike Nichols, con Dustin Hoffman, e da Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli , con Stefania Sandrelli.
2. A partire dal protagonista.
A) Il Laureato (The Guaduate, 1967) di Mike Nichols, con Dustin Hoffman. Sceneggiatura di Calder Willingham e Buck Henry , tratta dal romanzo di Charles Webb.
I dati di partenza su cui si trovano a lavorare gli sceneggiatori sono questi: Benjamin Braddock ha appena concluso i suoi studi in un college dell’Est e torna all’ovest ( a Los Angeles). Il suo periodo di formazione è concluso. Si trova a dover decidere cosa fare della sua vita. E’ confuso, smarrito.
1. Il film inizia da un primo piano di Ben in aereo. Le prime informazioni ce le da l’altoparlante di bordo. Signore e signori, stiamo iniziando il nostro atterraggio su Los Angeles (…) dopo quattro ore e mezzo di volo. L’informazione è voce di fondo. La macchina da presa (MDP) resta concentrata sul volto di Ben, sguardo nel vuoto, un’espressione insieme tesa e assente, che il giovane protagonista mantiene anche dopo l’atterraggio, quando lo vediamo (sui titoli di testa) camminare da fermo, trasportato dal tapis roulant dell’aeroporto, come un sonnambulo.
2. Ritroviamo , sempre in PP, il protagonista a casa, in camera sua, con lo stesso sguardo nel vuoto e un acquario alle spalle. Suo padre lo raggiunge, ma la MDP resta su Ben. Il padre lo vediamo entrare in campo, ma non gli sottrae neppure per un secondo l’attenzione del pubblico.
Padre: Ehi, ma che fai? Gli ospiti sono tutti giù, Ben. Sono impazienti di vederti.
Ben: Senti, puoi dire che ho bisogno di restare solo, per un po’.
Padre: Ma sono tutti i nostri amici più cari. Non ti hanno più visto da quando sei nato. Cosa c’è, Ben?
Ben: Sono un po’…
Padre: Preoccupato?
Ben: Beh…
Padre: Per che cosa?
Ben: Forse per il mio avvenire.
Padre: In che senso?
Ben: Non lo so. Io vorrei che fosse…
Padre: Che fosse come?
Ben: Diverso.
Entra la madre di cui udiamo la voce fuori campo e che sollecita il figlio a scendere e a mostrarsi agli amici di famiglia.
3. Ben è sceso in salotto. La MDP continua a non staccare mai da lui e dal suo volto. Gli altri personaggi che gli si affollano intorno sono apparizioni fugaci che lo salutano o ne commentano il passaggio con chiacchiere di circostanza. Apprendiamo da queste chiacchiere che Ben ha superato l’età dei primi amoretti (cioè che presto dovrà farsi una famiglia) che per la laurea gli è stata regalata un’Alfa Romeo (il che rimarca anche il benessere della sua famiglia), che ha vinto un premio accademico, e altre informazioni che hanno la stessa impersonale distanza delle comunicazioni dell’altoparlante all’aeroporto: è stato capitano della squadra di corsa campestre, capo del circolo dei dibattiti, condirettore e poi direttore del giornale del college. In sostanza, un ottimo studente, che riceve l’approvazione piena del suo ambiente sociale, riunito a festeggiarlo. Ma lui, per quanto cortesemente, sfugge. Un amico di famiglia lo prende da parte e gli dà un consiglio per il suo avvenire, che suona come un ammonimento: Voglio dirti una parola sola, solo una parola. Mi ascolti? Plastica! L’avvenire del mondo è nella plastica. Tra le tante presenze, ne notiamo bene soltanto una. Una signora elegante che siede in disparte, a bere e fumare , e tiene d’occhio Ben, consapevole del suo disagio (la signora Robinson). Ben si rifugia di nuovo in camera sua, ad osservare l’acquario. La porta si apre e la signora Robinson fa il suo ingresso, sicura di sé, invadente, ma come lui estranea e diversa rispetto all’ambiente convenzionale del salotto.
Da notare.
1. La prima immagine del protagonista è in aereo, sguardo nel vuoto. Ma quell’espressione non è occasionale, frutto del jet lag o dell’ansia dell’atterraggio. E’ lo stato d’animo che, senza bisogno di parole, già ci testimonia la condizione del protagonista. Si potrà osservare che questo genere di scelta ( seguire il protagonista fin dal principio in PP, concentrando su di lui e sul suo volto tutta l’attenzione del pubblico) attiene alla regia, non al lavoro dello sceneggiatore, ma in questo caso non è affatto così. Questa stessa espressione assente tornerà diverse volte nel corso del film e affiorerà di nuovo nel finale. E’ il marchio distintivo, non solo dello stato d’animo, ma del carattere del protagonista. E’ insomma una scelta narrativa.
2. Per maggiore chiarezza, quanto ci era stato espresso in modo puramente visivo, viene poi chiarito nel dialogo con il padre. Il protagonista, sollecitato, spiega di sentirsi confuso, e in sostanza “diverso”. Non è soltanto il contenuto del discorso a illuminarci sullo stato confusionale del protagonista, ma anche la forma smozzicata, incerta, delle sue risposte al padre. Però da tanta incertezza, nasce una risposta chiara, una dichiarazione esplicita. In una sola parola: diverso.
3. Le voci del “coro” , a contrasto, oltre a offrirci nuove informazioni sul protagonista, ne danno un giudizio positivo, carico di soddisfazione e di attese, ma l’imbarazzo di Ben conferma, nei fatti, il suo senso di estraneità rispetto all’ambiente. Da cosa è diverso? Dalla plastica (anche qui: una sola parola, a compendiare le attese conformiste che gli altri ripongono in lui). Il nostro protagonista non vuole fare il protagonista, rifiuta il suo ruolo. Eppure la MDP continua a seguire lui. Il protagonismo di Ben sta nella sua riluttanza ad assumere il ruolo assegnatogli socialmente. Nel suo atteggiamento, si riconferma diverso. La lunga sequenza si chiude circolarmente, riportandolo nella sua stanza di fronte all’acquario. E dall’irruzione della signora Robinson, nasce la prima e decisiva svolta del racconto.
Commento - Nel ritratto cinematografico del protagonista, i fatti, i comportamenti, le azioni o le non-azioni (ciò che si vede) precedono le spiegazioni verbali, e poi le seguono, per correggerle o rafforzarle. Il racconto cinematografico mostra prima di spiegare a parole. E’ racconto per immagini. Non dimenticate mai che il cinema nasce muto. Non è la parola , il linguaggio verbale a occupare (come alla radio, o come ancor più in letteratura) il centro della comunicazione, ma quello che si vede e che decidiamo di far vedere. Quando dunque volete presentare da subito, fin dalla prima inquadratura, il protagonista, ricordate di metterlo in una situazione/condizione che ci faccia da subito (senza bisogno di parole) capire non solo chi è fisicamente, ma come si sente, e qual è il segno distintivo del suo carattere. Questa situazione dev’essere chiara ed esemplare. Una metafora, se volete (l’aereo che sta atterrando, lo stordimento del “ritorno a casa”) ma mostrata concretamente. Figuratevi la scena mentalmente, proiettatevela. Non pensate che questo sia il lavoro del regista. Il regista potrà scegliere una diversa messa in scena, ma è bene che pur senza scendere in dettagli di movimenti di macchina e in minuzie stilistiche, lo sceneggiatore non perda comunque mai il focus del racconto: ciò che ne deve occupare, visivamente, il centro.
Per differenza. Quanti film iniziano con una panoramica della città in cui si svolge la vicenda? Con un aereo che atterra, prima di vedere in azione il protagonista? Questa sorta di inquadratura di codice, che ci informa sul luogo in cui si svolge la vicenda, o ci offre un puro prologo visivo su cui magari appoggiare i titoli di testa, non è di alcun rilievo in una storia psicologica che intende concentrarsi sul vissuto del protagonista e porre lui al centro della vicenda. Possiamo informare il pubblico circa il “dove” in altro modo, non mostrando il luogo, ma facendolo capire da voci di fondo.
E ancora: quanti sceneggiatori avrebbero resistito alla tentazione di mostrarci il Laureato al College, vedendolo nel contesto dei suoi amici per poi sottolineare la differenza tra lui e il contesto famigliare? O presentandolo magari impacciato nel ricevere la laurea in toga? Ma questo passaggio è superfluo se l’oggetto della nostra narrazione non è la differenza tra la vita studentesca e quella famigliare, ma il difficile inserimento sociale di un giovane alle prese con i propri dubbi e con i propri problemi di ingresso nel mondo degli adulti. Non cominciate mai un film con una premessa che esce dall’oggetto della narrazione. Centratelo subito, senza indugi. Si parte dalla situazione in corso, in atto. E la situazione, in questo caso, coincide con la presentazione del protagonista e del suo carattere. Non basta che il protagonista entri in scena. Come ci entra? Come ci appare? In che momento? In quale condizione psicologica? Questo è il punto. Noi dobbiamo coglierlo ed esprimerlo figurativamente. Ne stiamo dipingendo il ritratto. Non bisogna disperdersi in dettagli estranei a questo scopo.
B) Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli , con Stefania Sandrelli. Soggetto e sceneggiatura di Antonio Pietrangeli, Ruggero Maccari, Ettore Scola.
Per quanto questo film non sia tratto da un romanzo, è esplicita l’intenzione degli autori di voler raccontare una Madame Bovary degli anni 60. Invece di una vita “da romanzo”, Adriana, la nostra, illetterata protagonista, sogna una vita “da cinema”. E’ una bellissima ragazza, candida e un po’ svanita, che non considera il suo corpo, costantemente oggetto di mire maschili, come un qualcosa da esibire con fierezza o su cui speculare, ma come una sorta di dotazione naturale, vissuta senza malizia alcuna, anzi con indolenza. Il suo sogno è quello di uscire da una vita dura e ingrata, meschina, di cui pure non si lamenta, per diventare una presenza sullo schermo.
1. Il film inizia con la panoramica di una spiaggia desolata. Ombrelloni chiusi, cartacce disseminate, brutte case sul fondo, sabbia grigia. La panoramica si conclude su Adriana stesa a prendere il sole, in solitudine. Dai piedi, la MDP sale al suo costume da bagno, alla sua schiena nuda, al suo volto, con gli occhi chiusi, di ragazza assopita e inerte. Non è chiaramente lì per esibirsi visto che è sola. E’ innocente nel suo mostrarsi. Il programma musicale di canzonette che risuona dalla sua radio a transistor è terminato. Una mosca sembra svegliare Adriana che la allontana con un soffio, senza un gesto, e resta ad occhi chiusi. Si ode il segnale orario. Ore 15.30. Adriana continua a restarsene semi assopita. Cominciano le notizie del giornale radio. Importanti avvenimenti politici. Subito Adriana si alza, raccoglie le sue cose e se ne va. Pochi passi di corsa sugli zoccoli e già si ritrova in una periferia di palazzoni, strade assolate e semideserte. Si ferma a un baracchino di bomboloni, il cui maturo gestore sonnecchia. Si fa allacciare da lui il reggiseno.
Adriana: Presto, capitano, che sennò faccio tardi.
Capitano: Chi c’ha fretta, vada piano.
Adriana: Grazie, capitano.
Altra corsetta zoccolando. Un uomo sta bagnando la strada con una pompa di gomma. Adriana lo chiama per nome, si fa annaffiare per togliersi la sabbia di dosso. Lo ringrazia. Corre ad alzare la saracinesca della bottega di un parrucchiere. Entra, corre nel retrobottega. Si toglie l’accappatoio e si distende di nuovo, su un lettino. Inerte come all’inizio.
2. Stacco. Adriana al lavoro. Fa le mèches a una cliente. Fa cadere per sbaglio una lozione. Ha un rapido flash. Si ricorda di un’aggressione sessuale subita passivamente sul pianerottolo di casa da parte di un uomo che nella foga, con un calcio, ha spedito una bottiglia a infrangersi sui gradini. Riprende il lavoro, distratta, svanita. A fine turno, mentre il proprietario della bottega entra in negozio per controllare l’incasso, Adriana è ancora sul lettuccio del retro a leggere, o più esattamente a sfogliare, un fumetto di quart’ordine (Demoniak). L’uomo, più che maturo, sprovvisto del minimo fascino, le si siede accanto e le accarezza le gambe parlando d’altro. Lei continua a leggere.
Proprietario: E lascia perdere sto libro!
Si china su di lei.
Adriana: Ma non potrebbe essere più gentile?
Però lascia fare, rassegnata, indolente.
3. Stacco. Adriana si vede in compagnia di Vittorio Gassman. Si vede sullo schermo accanto a lui. E’ una sua proiezione nella proiezione. La sera, infatti, Adriana fa la maschera in un cinema. Scambia qualche piccola chiacchiera con una sua collega. Accompagna un cliente al suo posto e nemmeno si accorge che lui si stanca di seguirla e va a sedersi per conto suo.
Da notare- Rispetto al Laureato, qui non ci sono parole che confermano o spiegano fatti o circostanze inerenti al personaggio. Il personaggio compare e dal suo atteggiamento, dai suoi piccoli comportamenti, comprendiamo chi è. Un ritratto indubbiamente difficilissimo da rendere perché ricco di sottili sfumature, e che in questo caso non può avvalersi della parola per spiegarsi, perché di “parole” Adriana non ne ha a disposizione. Non è un’intellettuale: ignora il giornale radio, vive di canzoni, di fumetti ordinari e di sogni cinematografici, porta in giro il proprio corpo rassegnata alla libidine maschile. E’ abituata a cancellare i ricordi spiacevoli che riaffiorano alla sua mente. Subisce. Chiede solo un po’ di gentilezza. La stessa semplice gentilezza che caratterizza la sua ingenua disinvoltura e familiarità nei rapporti umani.
Con molta maggiore radicalità del precedente esempio e con un compito estremamente più difficile ( raffigurare la psicologia di un personaggio apparentemente sereno eppure tragico, come viene compiutamente rivelato dal suo suicidio finale, superficiale ed estremamente sensibile, sospeso tra speranza e rassegnazione, protagonista e vittima, indipendente e succube dell’ambiente) Adriana viene raccontata mostrandola, non in azioni clamorose, ma per minimi dettagli di vita, senza che mai il racconto perda di presa diventando insignificante o noioso.
Anche qui, il momento iniziale ( l’inerzia dell’abbandono del suo corpo al sole su una spiaggia marginale e disastrata) è già un compiuto ritratto del personaggio, non mera premessa a un racconto che verrà dopo. E l’inizio è anche un insospettabile preannuncio, a violento contrasto, della fine. Giace inerte sulla sabbia e giacerà sull’asfalto dopo esserci gettata dalla finestra.
Ci siamo limitati alla presentazione del personaggio, ma il film è da studiare tutto per vedere con quale mirabile fluidità vengono, attraverso Adriana, presentati gli altri personaggi, tutti maschili, che le si affollano intorno. Il coro maschile non darà mai giudizi su di lei come “persona”, tutti potranno dire, un domani “Io la conoscevo bene”, ma nessuno ha fatto il minimo sforzo per conoscerla veramente, e chi forse avrebbe potuto farlo, è passato quasi inosservato agli occhi di Adriana, permanentemente sognanti un “altrove” che non esiste, se non in immagine, un altrove “fantasma”.
Commento- I grandi personaggi vivono dal loro primo apparire. Non solo quelli che rappresentano uno “stato dell’animo”, ma anche quelli che hanno una pura evidenza simbolica. Tarzan è un uomo bianco, nudo, che compare su un albero e ulula come un animale. E’ già tutto in questa prima immagine. Dracula appare in un castello in rovina, come un’ombra inquietante che emerge dai secoli. Non c’è alcun bisogno di raccontarne l’origine. Se si vuole, lo si può fare, e lo si è fatto. Ma al pubblico cinematografico, a noi, non importa nulla di Lord Greystoke, o delle battaglie del principe valacco Vlad Drakul. Ci basta vederli apparire perché essi esistano senza vita precedente e ci parlino senza parole. La loro prima inquadratura è già fondamentale, è già una rivelazione. Una presentazione qualsiasi, sciatta, non evidente di per sé, è una presentazione mal pensata e mal scritta, in genere rivelatrice solo del fatto che noi stessi che scriviamo non abbiamo ancora chiaro chi sia il nostro personaggio. Non lasciamoci ossessionare da tutti i dettagli biografici, dalla “carta d’identità” che abbiamo stilato di lui prima di cominciare a raccontarlo, non preoccupiamoci di fornire subito al pubblico una massa di informazioni sul suo conto. Concentriamoci sul suo ritratto e cerchiamo di renderlo espressivo sin dal primo momento.
Ma in pratica, come possiamo descrivere questa prima apparizione del personaggio? Così come uno sceneggiatore può pensare (a torto) che la “messa in scena” sia compito esclusivo del regista, può anche pensare che la caratterizzazione psicologica, i gesti e le azioni più normali e quotidiani, siano dominio e competenza degli attori e che sia superfluo sottolinearli. Non è così, perché è anche dalle azioni minime che riusciamo a comprendere e far comprendere un personaggio. Questo però non significa affatto inzeppare la sceneggiatura di indicazioni. Può chiarire questo punto un altro esempio (tratto dalla sceneggiatura del film White Heat del 1948/49 , film di Raoul Walsh con James Cagney). Gli sceneggiatori descrivono così il personaggio femminile di Verna, al suo primo apparire: Verna si muove dal letto alla porta, serrandosi la vestaglia alla vita. Il suo volto è bellissimo, algido come la neve. La filosofia di Verna è semplice: e io cosa ci guadagno?
Come potete vedere, non è necessario che lo sceneggiatore, nello script, si diffonda in lunga descrizione della psicologia del personaggio e in un pignolo elenco di gesti, anzi la sua presentazione dev’essere sintetica e ficcante esattamente come la presentazione visiva e centrare subito il punto. Il regista poi, nel film, sceglierà di rappresentare Verna ancora distesa a letto, per sottolineare meglio la sua natura da “bambola viziata”, ma quelle poche righe sulle caratteristiche dominanti del personaggio ne hanno già dettato il ritratto, fisico e psicologico.
Esercizio- I due esempi sopra proposti (Il Laureato e Io la conoscevo bene) sono quasi inarrivabili nella loro perfezione stilistica, ma se si devono cercare dei modelli di riferimento è sempre meglio considerare i più impeccabili, non certo per imitarli banalmente, ma per assimilarne la lezione (e confrontandoli ad esempi meno riusciti, sarà più semplice scovare le pecche di questi ultimi).
Se avete un personaggio in testa, provate a presentarlo come se doveste raccontarlo in una sola immagine. Cercatela questa immagine iniziale e riassumetela in pochissime righe (come nell’esempio proposto da White Heat). Questo esercizio potrebbe sembrare più semplice del precedente (c’è molto meno da scrivere), ma in realtà è parecchio più difficile. Potrà esservi utile scrivere dapprincipio una descrizione lunga (vi aiuterà a chiarirvi le idee), ma successivamente riducetela della metà e poi ancora della metà, fino a centrare l’essenziale, nel modo più espressivo ed efficace.
( Nella prossima lezione prenderemo le mosse da Gilda del 1946 di Charles Vidor e Io e Annie del 1977 di Woody Allen. Nel primo esamineremo il problema della “voce fuori campo” , aggiunta alla presentazione visiva del protagonista; nel secondo quello della “voce-volto” in campo, cioè del protagonista che si presenta al pubblico direttamente, “confessandosi” alla macchina da presa. Due ulteriori gradini dell’approfondimento della Presentazione del Protagonista).
Lezione 2 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
(per la prima lezione, cliccare qui)
Quando lo sceneggiatore presenta il personaggio protagonista, si trova a dover soddisfare due distinte esigenze: una è informativa. Si tratta cioè di fornire al pubblico le informazioni di base utili a identificare il personaggio nei suoi connotati essenziali, cioè la sua “carta d’identità”. L’altra è espressiva. La semplice lettura di una carta d’identità non basta infatti a definire le caratteristiche psicologiche di un personaggio, né il suo momento emotivo, né il suo temperamento.
Troverete in tutti i manuali di sceneggiatura indicazioni sulla creazione preliminare di uno schema di definizione del personaggio, proprio sulla base del modello “carta d’identità”: età, luogo di nascita, professione, sesso, aspetto e segni particolari. I manuali precisano immancabilmente che è bene per un autore definire in anticipo anche altri dettagli, per esempio sulla famiglia del personaggio, se ha genitori ancora in vita, fratelli, figli, coniugi e altri parenti, se ha tic o gusti particolari, quale sia il suo grado di istruzione, il suo curriculum vitae, le sue principali qualità/punti di forza e i suoi difetti/debolezze. Insomma tutti i dettagli utili a comprenderlo anche se poi molti di questi dettagli non verranno affatto utilizzati nella storia. I manuali di sceneggiatura però in genere trascurano di precisare e avvertire che tutti questi utili approfondimenti del personaggio, poi condizioneranno pesantemente il lavoro dello scrittore. Umberto Eco, in una recente intervista rilasciata a Enrico Ghezzi, ha giustamente sottolineato: “quando io decido che il mio personaggio ha sessant’anni ed è nato a Padova, già mi sono in qualche modo legato. Ci saranno cose che potrà fare e altre che non potrà fare.” Insomma: ogni caratteristica fissata a priori, da un lato ci apre un possibile scenario creativo, dall’altra ci limita ed esclude altri possibili sviluppi e scenari. Nella fase di ideazione di un personaggio questo deve essere tenuto ben presente. In pratica, la narrazione potrà essere più libera se si parte da poche definite caratteristiche, da arricchire magari nel corso della narrazione, mentre sarà tanto più vincolata quanto più vasta sarà la gamma di caratteristiche prefissate. Inoltre l’informazione da dare al pubblico sul personaggio, al principio di una storia, sarà più facilmente sintetizzabile quanto meno sarà diffusa. In particolare nella scrittura cinematografica, la natura di un personaggio va mostrata in azione, cioè nei fatti e nei comportamenti, non è sufficiente, anzi è spesso stucchevole comunicarla a parole. L’informazione non deve dunque mai essere staccata dalle esigenze espressive. Non tutti i dettagli della biografia di un personaggio hanno eguale valore dal punto di vista espressivo. Bisogna scegliere quali sono i caratteri dominanti, quelli che intendiamo sottolineare nel corso del racconto, e presentarli subito in modo efficace, perché possano venire riconosciuti a colpo d’occhio, senza bisogno di spiegazioni eccessive. Esamineremo mese per mese , per aggiornamenti successivi, alcune differenti tecniche di presentazione del personaggio protagonista, tra le tante possibili. Per questo mese cominciamo con una tecnica classica e cioè …
1. L’ingresso ritardato, ovvero: “ dicono di lui”.
Questo genere di presentazione del protagonista può essere anche definito “teatrale”, in quanto l’origine è tipica del teatro e in particolare del teatro da “capocomico”. Se guardate le commedie di De Filippo o di Govi, in genere la scena iniziale presenta dei personaggi di contorno grazie ai quali cominciamo a conoscere l’ambiente (la scena) e il protagonista, che è ancora assente, ma al centro dei loro discorsi. Tutti parlano di lui. Quando poi il protagonista finalmente entra in scena, salutato da un applauso, è già al centro dell’attenzione e prima ancora che si muova e parli, il pubblico ha potuto avere delle informazioni sul suo conto e coltivare delle attese. In questo genere di presentazione “sociale”, inoltre, si offre al pubblico una pluralità di punti di vista sul personaggio. In questo modo, i pareri su di lui possono risultare contrastanti e contraddittori. Il personaggio non viene presentato solo per quel che è, ma anche per come è interpretato/vissuto dagli altri. Alla chiarezza delle informazioni si sovrappone una zona di incertezza e di mistero: il personaggio potrebbe non essere affatto come viene dipinto dagli altri, o avere risvolti occulti. Paradossalmente, la nostra curiosità cresce quanto più diverse sono le opinioni espresse sul personaggio. Da un lato cominciamo a conoscere chi è, dall’altro ci domandiamo “ma chi sarà mai veramente?”
Uno smagliante esempio cinematografico di questa tecnica di presentazione è nel trailer di “Citizen Kane” (Quarto Potere) di Orson Welles. Potete trovare questo trailer nei contenuti speciali di uno qualsiasi dei DVD della serie RKO, disponibili in italiano. Il trailer inizia con un microfono che entra in campo a captare la voce di Orson Welles, il quale, dopo una rapida e vivace presentazione del cast, lascia la scena ai personaggi di contorno, senza mai mostrare se stesso. E i comprimari esprimono tutti opinioni violentemente contrastanti sul protagonista Charles Foster Kane, alimentando in questo modo la curiosità del pubblico.
Come introduzione a questa carrellata di pareri sul protagonista, Welles ha subito precisato: “Non so che dirvi di lui, c’è così tanto da dire…”
Ed ecco le opinioni:
“Charles Foster Kane ha dato inizio alla guerra, ma se non fosse stato per lui, gli USA avrebbero il Canale di Panama?”
“ E’ un comunista!”
“ Governatore? Quando gli elettori e sua moglie sapranno cos’ho scoperto su di lui e una certa biondina, non lo eleggeranno neanche spazzino!”
“ Lo sposerò la settimana prossima. Alla Casa Bianca.”
“ Certo che lo amavo. Gli ho dato 60 milioni di dollari!”
“ Per forza lo amo. E’ l’uomo più ricco d’America.”
“ E’ un pazzo.”
“ E’ meraviglioso.”
Conclude Welles, sempre fuori campo: “Signore e signori, non so cosa penserete del sig. Kane. Non ne ho idea: io ho solo recitato il suo ruolo. Beh, Kane è un eroe. E una canaglia. Una nullità e un uomo d’oro, un formidabile amatore, un grande americano e un gran bastardo. Dipende da chi ve ne parla. Qual è la verità su Charles Foster Kane? Venite al cinema e lo scoprirete da soli.”
Da notare.
1. I pareri espressi su Kane, violentemente contrapposti, sono tutti decisi. Nessuno esprime dubbi o valutazioni ambigue. Il dubbio deve restare tutto del pubblico. L’autore non sta semplicemente usando una tecnica pubblicitaria, né sta soltanto distribuendo i ruoli tra i personaggi del film, tutti definiti a seconda dell’opinione espressa su Kane, ma sta anche affidando un ruolo al pubblico: quello di formarsi un suo proprio giudizio.
2. Le opinioni su Kane vengono espresse in forme sintetiche, colorite ed efficaci (non lo eleggeranno neanche spazzino, gli ho dato 60 milioni di dollari). I personaggi secondari, ciascuno con la propria personalità e il suo linguaggio, parlando di Kane presentano anche se stessi e incuriosiscono a loro volta.
3. Pur nei contrastanti pareri, vengono date alcune informazioni certe: Kane si muove su uno scenario politico (vengono nominate la guerra, il comunismo, gli elettori, la Casa Bianca), la sua vita privata è sfoggiata in pubblico (amori, scandali, ricchezza) ma nasconde dei misteri (come si comporta sotto sotto con sua moglie e le altre donne? Quali sono le sue arti seduttive? Come ha fatto i soldi? ).
4. La storia, nel suo sviluppo, si regge sul mistero della personalità di Kane. E’ questo il suo vero motore narrativo.
Rispetto a quanto detto in precedenza e a quanto insegnato dai manuali di sceneggiatura, qui si usa come punto di forza espressivo non quanto conosciamo del personaggio, ma proprio tutto quello che non conosciamo affatto. La tecnica capovolge la regola. Il compito dell’autore in apparenza era quello di spiegare il protagonista, ma è stato svolto molto meglio e più coerentemente alla storia, non spiegandolo affatto, anzi affidando al giudizio del pubblico la valutazione finale. ( Del resto,
quando la comunicazione non si preoccupa di stimolare il nostro spirito critico e il nostro libero giudizio, ci declassa a popolo bue).
Commento. Il film Citizen Kane ( 1940) è stato tradotto in italiano con il titolo Quarto Potere. Infatti il film parla del potere della stampa. Ma di questo tema, nel trailer, non c’è traccia. Non si fa parola del tema centrale del film! Questo potrebbe indurre molti a pensare che il trailer è sbagliato. Non sarebbe stato più corretto informare il pubblico che il misterioso Kane è un magnate della Stampa? Come mai tra le informazioni contenute nel trailer proprio questa, così decisiva, non c’è? Anzitutto, di film sul potere della stampa ce ne erano già stati parecchi e scegliendo di centrare il trailer su questo aspetto, Citizen Kane non sarebbe apparso come un film originale, ma come un altro film sulla stampa. In secondo luogo, “la stampa” non è una persona. E’ un tema. Centrare il trailer su un tema avrebbe voluto dire offrire al pubblico una percezione astratta, ideologica, del film. Con la sua scelta, Welles esprime con grande efficacia che il centro di una rappresentazione non può essere un Tema, ma deve essere un Uomo. Il che illustra perfettamente quando dicevo al principio: una storia senza personaggi, una storia puramente “tematica”, non ha forza. D’altra parte Welles è assolutamente onesto e veritiero nel sottolineare che si tratta della storia di un personaggio. Il film inizia con Kane bambino. E’ una biografia, che molti interrogativi rendono inquietante. E infine (ma qui si esce dal campo delle “regole e delle tecniche di composizione” e si entra nel campo della genialità pura) scegliendo di tacere al pubblico un’informazione essenziale, Welles si comporta esattamente come la Stampa, che proprio mentre asserisce di informare sui fatti essenziali, e al contempo “democraticamente” propone al pubblico opinioni contrastanti in proposito, occulta contenuti fondamentali, cioè cose che per opportunità o convenienza “è meglio non si sappiano”. La comunicazione mediatica è esattamente questo. Il trailer di Welles, tacendo il contenuto fondamentale del film (il Potere della Stampa e della Comunicazione) lo rivela nondimeno sotto metafora, e ne usa spudoratamente i meccanismi, con corrosiva ironia.
Sviluppo del modello. Ho scelto di illustrare questo modello come primo tra i tanti, perché si tratta del modello più antico. Dicendo che è di origine teatrale ho implicitamente chiarito che lo si ritrova già nella tragedia classica ( questa è la funzione del “coro”: introdurre e commentare il carattere del protagonista e le vicende in cui è implicato), in Shakespeare, insomma in secoli di teatro fino a giorni nostri. Va precisato che un inizio affidato al “coro” non è una semplice introduzione, ma è già di per sé narrazione: infatti ci presenta a confronto, da subito, il personaggio e il proprio ambiente, il singolo e la collettività che ne valuta il carattere e le azioni. Se la nostra narrazione non considera centrale il rapporto individuo-gruppo, questo tipo di inizio non è il più adatto. Tuttavia questo modello ha dato vita nel corso del tempo a molte varianti. Il fatto che si tratti di un modello antico non significa affatto che sia un modello sorpassato. L’esempio fornito dal trailer di Welles, ci mostra in modo molto preciso che dall’iniziale contesto teatrale già il modello si sposta verso un modello di comunicazione che ha a che vedere con l’inchiesta giornalistica. In molti film successivi questo legame è stato esplicitato al punto che il modello non è stato usato soltanto come inizio utile alla presentazione del protagonista e alla sua entrata in scena, ma come struttura dell’intero racconto. Nei film Zelig, Lenny, Harry ti presento Sally, Man on the Moon, il modello, sotto forma di interviste “giornalistiche”, scandisce tutti i passaggi della narrazione, dal principio alla fine. Le regole base di questo modello si ritrovano anche in film che non contengono riferimenti esplicitamente teatrali, né giornalistici. Prendiamo ad esempio il recente La maledizione della Prima Luna di Gore Verbinski. Il titolo originale del film è Pirates of the Caribbean (Pirati dei Caraibi) e gli sceneggiatori Ted Elliot e Terry Rossio si preoccupano subito di destare la curiosità del pubblico su questo protagonista collettivo: i pirati. Nella scena d’apertura, vediamo un grande vascello che fende la nebbia. A prua, una bambina scruta il mare. Il film, prodotto dalla Disney, si rivolge anche a un pubblico infantile e in questa bimba che cerca di orientarsi nella nebbia, curiosa di veder apparire qualcosa , gli spettatori più giovani possono immediatamente identificarsi. A bordo, il “coro” ( il capitano del vascello, il nostromo, il padre della bambina) discute di pirati: c’è chi li vorrebbe impiccare, c’è chi li teme per le loro gesta feroci, c’è chi cerca di smussare i toni (il padre della bimba) per non impressionare troppo la piccola. Lei, candidamente, esprime un’opinione contrastante: vorrebbe incontrarli, questi famosi pirati che hanno acceso la sua immaginazione. Ora la corrente trascina un ombrellino bianco, simbolo di candore, e poi dalla nebbia appare un giovane naufrago, anche lui un ragazzino, esanime sul rottame di una nave. Quando la nebbia si apre, ci appare un altro vascello in fiamme e la superficie del mare disseminata di rottami. Non si tratta più di semplici discorsi sui pirati, ma della dimostrazione visiva, concreta, di quello che i pirati, ancora invisibili, possono fare. Anche qui c’è chi cerca di smussare: potrebbe essersi trattato di un semplice incidente, ma è ormai chiaro che questa spiegazione è solo un patetico tentativo di tranquillizzare. Il naufrago viene portato a bordo e affidato alla vigilanza della bambina, che ha all’incirca la stessa età. La bimba scopre al collo del ragazzo un medaglione con effigiato il teschio simbolo della pirateria. Dunque quel ragazzo non è una vittima, ma un pirata! Sarebbero quelli i terribili corridori del mare? Dei ragazzini? La bimba decide di proteggerlo e nasconde il medaglione.
Insomma: vediamo qui in azione il nostro modello di riferimento, in tutti i dettagli: 1. Si esprimono opinioni contrastanti sui pirati, 2. Le opinioni sono espresse in un linguaggio vivace e inequivocabile e ci permettono di capire il diverso atteggiamento e le diverse caratteristiche dei singoli personaggi del coro; 3. Ne ricaviamo alcune informazioni certe: il mare è battuto dai pirati, c’è una grave emergenza in corso, l’atmosfera è gravida di attesa e pericolo, ma tutto è immerso nel mistero, inclusa l’identità del giovanissimo naufrago che potrebbe essere vittima o aggressore; 4. Il motore della storia è il mistero circa l’identità dei pirati: sono creature demoniache, affascinanti avventurieri o cos’altro? E cosa rappresenta davvero il misterioso medaglione, al contempo raffinato esteticamente e intimidatorio con quel teschio che vi campeggia al centro?
In conclusione: un modello antico non è necessariamente un modello superato. Diffidate di chi sostiene che le forme di rappresentazione ereditate dal passato sono “vecchie” e come tali da abbandonare. Si tratta invece di archetipi, di fondamenti della rappresentazione, di cui uno sceneggiatore deve avere consapevolezza, imparando a svilupparli e ad adattarli di volta in volta alle proprie esigenze di racconto.
Esercizio. Cercate altri esempi cinematografici di questa tecnica di presentazione del personaggio ed esploratene le varianti. Provate poi su queste basi a scrivere un inizio di storia, sempre con presentazione del protagonista da parte degli altri personaggi e ingresso ritardato del protagonista stesso, ma in diverse versioni, indicando tra le possibili varianti quale risulti per voi la più efficace. Considerate anche casi in cui il modello è applicato male ed evidenziatene gli errori. Nella ricerca dei materiali, non è infatti indispensabile fare riferimento a dei capolavori o a dei film ben realizzati. Jerry Lewis nella sua scuola di cinema, usa di preferenza film decisamente brutti. Per imparare a individuare gli errori è molto utile guardare dei film mal riusciti. Gli errori degli altri ci abituano a riconoscere più facilmente i nostri. Cercate però di non citare film troppo sconosciuti o introvabili per non mettere in difficoltà chi leggerà i vostri esempi.
Lezione 1 di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
IL FANTASY
Molti ritengono che il Fantasy sia una Fiaba per adulti, si tratta invece di una versione moderna del genere Epico/Mitologico. I due filoni principali del Fantasy sono l’Heroic Fantasy e la Quest. Nel primo caso, il protagonista è un eroe assoluto. Che si tratti di Maciste (figura inventata, ma che rielabora la mitologia classica) o di Conan (il cui autore Robert Ervin Howard inventa ex novo una propria mitologia), non ha importanza. Il celebre critico e scrittore americano Lyon Sprague de Camp dà questa definizione dell’ Heroic Fantasy: “Con questo termine si indica quel genere di storie ambientate non nel mondo come è, era o sarà, ma come dovrebbe essere per ambientarvi un buon racconto. Le storie che si riuniscono sotto questo nome comune sono fantasie avventurose che si svolgono in mondi immaginari preistorici o medievali (…). In mondi del genere, città scintillanti alzavano le loro torri ingioiellate verso le stelle, stregoni mormoravano sinistri malefici in spelonche sotterranee, spiritelli dispettosi saltellavano tra rovine dimenticate, mostri primordiali si aprivano sentieri attraverso giungle inesplorate e il destino dei reami era in bilico sulle lame rosse di sangue delle spade impugnate da eroi dalla forza e dal coraggio soprannaturali.”
Si potrebbe dunque pensare, stando a questa definizione, che non si possa definire Heroic Fantasy il racconto mitologico classico (quello delle fatiche di Ercole, per intenderci) e neppure quello cavalleresco (come il ciclo di Re Artù), dato che essi prendono spunto da un mondo che è realmente esistito. Però a ben vedere, soprattutto se si considera la storia del cinema, sia i film sull’antichità classica degli eroi semidei, che quelli sull’Europa cavalleresca rappresentano in larga parte mondi re-inventati, in direzione dell’avventura fantastica. (Per inciso va osservato che il personaggio di Conan appare subito dopo la morte del grande scrittore fantastico e avventuroso sir Arthur Conan Doyle). Era realistico il mondo pagano di Cabiria di d’Annunzio e Pastrone? Erano realistici gli antichi regni di D.W. Griffith e Cecil B. De Mille? No, erano totali reinvenzioni, anche sotto il profilo scenografico, dove la precisione storica veniva sacrificata a vantaggio di un accumulo di elementi figurativi provenienti da tradizioni diverse e liberamente mescolati e ricreati. La vera differenza tra l’Heroic Fantasy e il Genere Epico classico o cavalleresco, è dunque un’altra. L’Heroic Fantasy è rigidamente manicheo: da un lato i buoni, condotti al riscatto da un Eroe semi-dio, dall’altro i cattivi, terribili tiranni che fondano il loro potere sul connubio con le Forze del Male e con Divinità oscure e feroci. L’epica classica invece (pensate all’Iliade di Omero) non distingue affatto tra buoni e cattivi, non rappresenta gli Achei come incarnazioni del Bene e i Troiani del Male, considera luci ed ombre di entrambi e anzi casomai propende per i vinti (i Troiani). Anche il racconto cavalleresco ci mostra spesso Eroi smarriti, che perdono il senno e si consegnano all’arbitrio, e Nemici capaci di gesta generose, ben forniti di senso dell’onore. Del resto il genere “cavalleresco” si fonda per definizione sul rispetto dell’avversario. Nel ciclo di Re Artù, Maghe, stregoni e falsi profeti, sono distribuiti equamente in entrambi i campi. (Avrete forse seguito recentemente sui giornali una piccola polemica a proposito del film 300, tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller. Roberto Saviane, che pure è un autore colto e intelligente, ha sostenuto contro chi accusava quel film di “fascismo”, che si trattava invece di racconto epico e che il racconto epico è di per sé manicheo. Sbagliato. Non è l’epica, ma l’Heroic Fantasy, ad essere manicheo. 300 è decisamente un film di Heroic Fantasy, anche se prende spunto dall’evento storico delle Termopili. D’altro canto, la celebrazione del Buono che combatte soltanto Guerre Giuste contro Cattivi rivoltanti e depravati, non è certo scaricabile tutta sul fascismo, come attesta la storia stessa del cinema mitologico, egualmente diffuso in Europa e in America fin dai tempi del cinema muto, poi per tutta la guerra fredda e persino ben addentro i “progressivi” anni 60).
In cosa la Quest si differenzia dall’Heroic Fantasy? Si intende per Quest, la ricerca di un oggetto sacro, miracoloso, magico (il Santo Graal, l’Anello dei Nibelunghi, il Vello d’Oro). Il lungo cammino, disseminato da ostacoli, alla ricerca di questo oggetto, è anche un percorso spirituale, nel corso del quale il cercatore non si limita a sfruttare le sue abilità, ma le affina, non è virtuoso fin dal principio, ma migliora, diventando così degno, a poco a poco, e non senza contraddizioni, cadute e sconfitte temporanee, del proprio scopo. L’oggetto simbolico, di per sé, ha valore solo in quanto la Quest stessa acquista valore. Nella Quest, l’Eroe non è necessariamente un semi-dio, anzi più spesso è un individuo comune. Nel corso del suo cammino incontra altri volenterosi come lui e la sua ricerca viene condivisa, diventa collettiva. Se il Male è sempre rappresentato (come nell’Heroic Fantasy) come Forza Oscura e Tirannica, a fargli da contrasto non è un Eroe Giusto e Buono per natura e dotato di grandi poteri, ma una comunità di esseri diversi, in genere piuttosto egualitaria: la Comunità degli Ultimi e degli Esclusi. Nella Quest spira un’aria decisamente più popolaresca e “democratica” che nell’Heroic Fantasy.
Veniamo ora all’aspetto comune di questi due tipi di Fantasy che risiede, come ha ben definito De Camp, nell’invenzione di un mondo. Per lo sceneggiatore si tratta di cambiare totalmente l’approccio narrativo. Il contesto non è dato, va inventato (di sana pianta, o recuperato da epoche e mitologie rielaborate). Avrete notato che nella maggior parte dei romanzi Fantasy, alla stessa apertura del libro, la prima cosa che si vede è una mappa che indica i luoghi in cui si svolgerà la vicenda. E’ dall’invenzione del mondo che si parte, non dall’invenzione della storia e dei personaggi. Questo mondo fantastico deve essere tale da poter offrire tutte le possibili occasioni all’avventura e dunque è costruito su una geografia impossibile che accumula ogni genere di paesaggi dentro uno spazio limitato: foreste, paludi, deserti assolati, ghiacciai, lande nebbiose e cunicoli sotterranei. La geografia umana è altrettanto ricca: nani e giganti, razze di tutti i generi, donne mostruose e bellissime, pirati e cavalieri, selvaggi e sapienti, e chi più ne ha, più ne metta. Megalopoli labirintiche si alternano a villaggi di capanne, città portuali a rocche fortificate. La cosa più difficile è, partendo da questa assoluta improbabilità e incongruenza di base, mantenerla plausibile, e ciò si può fare se alla grande varietà “spaziale” e ambientale si fa corrispondere un tracciato temporale ben definito. In altre parole, l’epoca, per quanto non “storica” dev’essere comunque chiara. Facciamo un esempio: la scelta delle armi. In Guerre Stellari abbiamo un esempio prezioso di Fantasy Fantascientifico. Che si tratti di Futuro è reso evidente dalle astronavi, che questo Futuro sia un aggregato di lontane e mitiche Epoche Passate, è reso manifesto dalle armature, dai mantelli, dalle spade. Ma c’è un equilibrio: le spade dei cavalieri Jedi sono spade-laser, cioè l’estetica richiama l’Antico, ma l’uso esprime il Futuro. Se i cavalieri Jedi usassero delle spade normali, lo troveremmo ingiustificabile e ridicolo per dei personaggi abituati a muoversi su astronavi avveniristiche fornite di armi ad altissima tecnologia.
In Conan la scelta è quella di una non meglio precisata età barbarica. La scelta delle armi, degli elmi, dei costumi, va di conseguenza. Possono esserci elementi più antichi (fionde, mazze di pietra, bastoni) ma infilarne di più moderni sarebbe insensato quanto fare irrompere un veicolo a motore in mezzo ad un’umanità che si muove a piedi o a cavallo. Se uno stregone guarda in uno specchio magico, le immagini che vede non devono sembrare dei cinegiornali ( lo dico perché in molti casi questo è avvenuto) altrimenti ne ricaveremmo un effetto parodistico. In un film di Shrek possiamo persino divertirci a far trasmettere uno spot pubblicitario dallo specchio magico, ma in un Fantasy Avventuroso il nostro specchio magico dobbiamo inventarlo in modo che non ci faccia assolutamente venire in mente un televisore.
Ho ritenuto opportuno evidenziare questo aspetto perché in diversi soggetti fantasy che mi avete inviato, non è tenuto nella dovuta considerazione. Più il nostro mondo è di fantasia, più dobbiamo cercare di costruirlo con delle caratteristiche rigorose. E in questa scelta l’elemento decisivo su cui potete orientarvi è il tempo, la scelta dell’epoca.
Dal punto di vista della costruzione della storia invece, il tracciato è tradizionale, quasi obbligato.
Di solito l’ Heroic Fantasy presenta al principio della storia una strage imputabile ai Cattivi. L’Eroe ( Maciste o Conan) spesso viene colpito personalmente: è il suo villaggio, la sua gente che sono stati uccisi. Lui è tornato a casa troppo tardi per poterli salvare. Ciò che lo spinge a muoversi è non solo il senso della Giustizia in generale, ma la giustizia intesa come Vendetta . La violenza dell’Eroe è giustificata da quella che ha dovuto subire. In altre parole: l’azione del Cattivo, deve precedere quella del Buono.
Nella Quest la storia si apre in genere con un prologo nel quale si rappresenta la lotta in atto nel nostro mondo fantastico e si precisa quale ne è il palio: l’oggetto magico che in mano ai buoni può rappresentare l’occasione di riscatto e in mano ai cattivi la definitiva fine di ogni speranza. Da ciò, per stacco, si stringe su una situazione apparentemente del tutto marginale rispetto a questo scenario apocalittico. Un personaggio o dei personaggi che in teoria non dovrebbero essere affatto decisivi ai fini della Guerra, proprio perché giudicati da tutti insignificanti, cresciuti come sono in disparte, scoprono e spesso malvolentieri di avere una missione: sono proprio loro gli insospettabili eletti che potranno salvare il mondo. Dopodiché il racconto si snoda attraverso una serie di episodi che ci consentono di incontrare personaggi e situazioni diverse, di aggregare il gruppo attraverso reclutamenti che paiono casuali, ma che si rivelano sempre oculati perché le doti e i limiti di ciascun essere che si aggiunge alla comitiva è complementare a quelli degli altri. I singoli sono imperfetti, solo l’insieme è completo, e questo insieme si crea un pò per volta lungo il viaggio.
Si può qui rintracciare, nel confronto tra Heroic Fantasy e Quest, una differenza di cui abbiamo già parlato. Abbiamo detto che l’Epica è frutto di una contaminazione tra gli opposti generi della Tragedia e della Commedia. L’Heroic Fantasy (con i suoi protagonisti semi-dei, le loro grandi azioni, una certa enfasi nella rappresentazione e nel linguaggio, e un senso dominante del Destino, per cui la natura stessa dei personaggi dipende dagli eventi che abbiamo stabilito di raccontare)
ha un’indubbia origine nella Tragedia. La Quest invece (con una notevole prevalenza di personaggi comuni e persino buffi, tali da destare più simpatia che estatica ammirazione, sempre attivi e reattivi al punto che le circostanze che si trovano ad affrontare paiono – e sono- predisposte proprio per mostrare la loro capacità di sopravvivere, fino alla vittoria collettiva finale) affonda le sue radici nella Commedia.
Riguardo infine all’invenzione del mondo, tenete sempre presente che non state scrivendo un Romanzo: in cinema (e in fumetto) avete a che fare con un racconto per immagini. In questo genere di film (e di fumetti), l’invenzione degli ambienti, degli scenari, dei costumi, dei personaggi e delle creature, in genere precede, e comunque deve accompagnare sempre, la scrittura della sceneggiatura vera e propria. Lo sceneggiatore non è chiamato semplicemente a vedere il personaggio nella propria immaginazione, deve poterlo vedere disegnato, progettato nei dettagli. Solo così può “metterlo in scena”.
Dunque anche se parecchi di voi sognano di poter scrivere un film Fantasy, impresa già di per sé proibitiva in Italia, rendetevi conto che non si può scrivere una buona sceneggiatura di questo genere, se non all’interno di un progetto molto concreto, di cui la scrittura è solo un elemento.
Come dovrete disegnare la Mappa del vostro mondo fantastico, così dovrete anche partecipare alla visualizzazione degli ambienti, dei costumi, dei personaggi e persino degli oggetti di scena. In un Fantasy questi non sono elementi decorativi, ma direttamente narrativi.
Come esercizio finale vi consiglio di studiare da questo punto di vista uno dei film della saga de Il Signore degli Anelli: distaccatevi dalla trama in modo da considerare meglio come tutto l’apparato visuale del film sia, al di là del plot, il vero e sostanziale centro motore del racconto.
24° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com - I Generi moderni (VI)
L’ADATTAMENTO (II)
b) Il postino suona sempre due volte
Il romanzo di James Cain esce negli USA nel 1934 e ha un primo adattamento cinematografico in Francia nel 1939 (Le dernier tournant, di Pierre Chenal) . Viene successivamente riadattato nel 1942 in Italia (Ossessione di Luchino Visconti) con un film oggi considerato come il primo manifesto del neorealismo. In America viene portato sullo schermo solo nel 1946 (The postman always rings twice, di Tay Garnett ) e infine ripresentato a colori e in una nuova e differente versione nel 1981 (di Bob Rafelson, con sceneggiatura di David Mamet).
(NOTA- Non deve stupire che un classico della letteratura americana come il Postino di Cain sia stato adattato allo schermo per la prima volta in Francia. I francesi, oltre ad aver definito e codificato il genere noir di cui Cain è un Maestro riconosciuto, vantavano una robusta tradizione di storie di coppie criminali. In questo caso si può citare sicuramente Thérèse Raquin (1867) di Emile Zola, dal quale il romanzo di Cain prende chiara ispirazione. Si è anche scritto che a sua volta, quasi a chiudere il cerchio, al romanzo di Cain si sia ispirato Albert Camus per il suo L’etranger (1942). Questo secondo richiamo mi pare tuttavia piuttosto flebile in quanto, sul piano della vicenda, l’unico collegamento tra il romanzo di Camus e quello di Cain sta nel fatto che essi sono scritti in prima persona da un condannato a morte. E’ comunque interessante notare come nel romanzo criminale, e in particolare nel Noir, le singole e ben distinte opere di autori, anche di notevole rilievo e di grande personalità, tendano ad iscriversi, nella percezione dei lettori, in una sorta di comune flusso narrativo. Questo conferma quanto sia importante l’indagine delle caratteristiche dominanti dei generi che, come ho cercato di mostrare, non si poggiano soltanto su delle strutture di racconto, ma esprimono delle filosofie correnti, dei punti di vista ben riconoscibili da cui si guarda alla vita, cioè delle interpretazioni del mondo condivise, che in quanto tali, travalicano i singoli autori e le singole opere. Le persone avverse a un certo genere, che si tratti dell’Horror piuttosto che della Love Story, del Noir o del Porno, lo sono perché non ne condividono la filosofia, non per una valutazione di tipo estetico. La valutazioni estetiche riguardano infatti le singole opere e i singoli autori, non possono riguardare un Genere nel suo complesso).
Qui confronteremo tra loro due adattamenti del romanzo di Cain: Ossessione di Visconti (film interpretato da Massimo Girotti e Clara Calamai) e l’edizione del 1981 di Rafelson (interpretata da Jack Nicholson e Jessica Lange). Entrambi i film sono facilmente reperibili in DVD e ve ne raccomando la visione e lo studio, in modo da approfondire meglio e più direttamente ciò che qui, per esigenza di sintesi, mi limiterò ad accennare.
1. Il plot
Questa è la scaletta del romanzo, capitolo per capitolo. Vi sarà utile anzitutto come modello di riassunto “per tappe” di un romanzo ( cosa che dovrete sempre fare per preparare un adattamento) e poi come riferimento per confrontarlo ai due film sopraccitati.
Califonia, tra il confine con il Messico e Los Angeles. Frank Chambers, un vagabondo di 24 anni, si ferma a un distributore di benzina con autorimessa dotato anche di una bettola, proprietà e abitazione di Nick Papadakis, un grassone di mezza età, di origine greca. Questi, che ha bisogno di un garzone, offre subito a Frank di restare lì. Frank esita, finché adocchia, in cucina, Cora, la giovane moglie di Frank, una bruna formosa, non particolarmente bella, ma sfrontata e aggressiva, quanto basta per fargli subito bollire il sangue. Frank decide di restare.( Capitolo 1).
Frank aggiusta l’insegna luminosa del locale e conquista subito la fiducia di Nick. Con Cora le cose vanno molto rapidamente: sotto il reciproco atteggiamento di sfida c’è una chiara tensione sessuale che viene sfogata subito. Al primo bacio lei gli ribatte “Mordimi!” e lui le fa zampillare il sangue dalle labbra. Poi se ne vanno di sopra.( Capitolo 2).
Frank approfondisce la conoscenza di Cora e apprende che viene dallo Iowa dove, eletta Reginetta di Bellezza, aveva vinto una trasferta a Hollywood. Qui però non era riuscita a superare i provini, a causa del suo accento rustico. Per un po’ si era prostituita, ma quel lavoro la disgustava, e dunque alla prima proposta di matrimonio, aveva accettato. Adesso però, è stanca di quel grassone del greco. Frank le propone di andarsene via insieme, ma Cora non vuole fare la vita della vagabonda. Invita piuttosto chiaramente Frank a far fuori suo marito. Frank non se la sente, anche perché lo trova un brav’uomo. D’altro canto, ormai non può più rinunciare a Cora. L’intesa non è più soltanto sessuale, con lei gli pare di stare in un’altra dimensione, come sospeso tra inferno e paradiso.
(Capitolo 3 ).
Frank ha ideato l’omicidio, in modo da farlo passare per un incidente (una caduta in bagno), ma è Cora ad eseguire il piano. In quel preciso momento però un agente di polizia si ferma al distributore, Frank lo intrattiene, mentre un guasto manda in tilt l’impianto elettrico e la casa resta al buio. Cora non è riuscita a completare l’omicidio. Il greco è esanime e probabilmente non s’è neppure reso conto di quanto è accaduto. Non si può far altro che chiamare un’ambulanza, ad evitare che il poliziotto possa nutrire sospetti. Al risveglio in ospedale, il greco non ricorda quanto è accaduto. Il poliziotto intanto ha trovato un gatto morto fulminato vicino alla cassetta delle valvole. Ogni possibile sospetto si è dissolto. Frank e Cora per il momento, l’hanno fatta franca.( Capitolo 4).
Frank e Cora, mentre il greco è ricoverato, passano una settimana felice. La tensione per quanto è accaduto sconsiglia loro di riprovarci in futuro. Decidono di partire, ma lei si ferma subito e scoppia in lacrime. Proprio non ce la fa a lasciare quel poco di sicurezza che si è guadagnata. Si commuove anche Frank. Si lasciano piangendo. (Capitolo 5).
Frank va a San Bernardino, per quindici giorni gioca a biliardo e spenna due tipi . Con duecentocinquanta dollari in tasca, se ne va a Glendale dove spera di incontrare di nuovo Cora e il greco che frequentano spesso il mercato locale. Gioca ancora a biliardo però stavolta viene spennato lui e si ritrova di nuovo senza un soldo. Al mercato incontra Nick, che è uscito dall’ospedale e sente la sua mancanza: i due garzoni che aveva assunto in sostituzione di Frank, erano un buono a nulla e un ladro. Frank torna con il greco. Con Cora tiene le distanze. Una notte la sente urlare in camera. Cora chiede a suo marito di allontanare Frank, sostiene che non lo sopporta. Frank intuisce che in realtà Cora voleva che lui ascoltasse la litigata, anche se non ne comprende i motivi. Più tardi, Cora gli rivela che il greco vuole un figlio da lei. Questo, Cora lo considera intollerabile. E’ in previsione una gita a Santa Barbara per una festa. Il greco si aspetta che in quell’occasione Cora dia il suo consenso. Cora implora Frank di accompagnarli e di approfittare del viaggio per ammazzare Nick. Altrimenti per lei non resterà altra strada che il suicidio. Non vuole un bambino dal greco, lo vuole da Frank. Si dichiarano il loro amore. (Capitolo 6).
Alla festa, il greco si ubriaca. Frank regge il gioco e simula ubriachezza. Nel viaggio di ritorno, è Cora a mettersi alla guida. Durate una sosta per un apparente disturbo al motore, Frank colpisce greco con una chiave inglese. I due amanti spingono l’auto in una scarpata e si fingono a loro volta vittime di un incidente, percuotendosi l’un l’altra. La violenza e la tensione sono tali che finiscono per possedersi sul posto. (Capitoli 7 e 8).
Poi Frank e Cora si ripassano la versione da fornire alla polizia. Una caduta casuale, mentre Frank sta risalendo la china, lo spedisce nel mondo dei sogni. Intanto Cora ha fermato un’auto di passaggio ed è stata chiamata un’ambulanza. Ci sarà un’inchiesta,però. La polizia infatti non è affatto convinta della dinamica dell’incidente e Frank si trova ad affrontare un processo. C’è di mezzo un fatto di cui Frank non sospettava: Nick aveva stipulato un’assicurazione sulla vita. La polizia, su input degli agenti assicurativi che non vogliono pagare il premio, sospetta che Frank lo abbia ucciso con la complicità di Cora per tenersi la proprietà e incassare i soldi. Frank professa la sua innocenza, ma è sotto farmaci e approfittando della sua labilità mentale, la polizia gli fa firmare una dichiarazione nella quale accusa Cora ( Capitolo 9).
Frank si procura un avvocato piuttosto astuto. Cora, incattivita, vuole confessare tutto. Rinchiusa in carcere, detta la sua confessione a un dattilografo, convinta che il tipo le sia stato mandato dalla polizia, mentre in realtà è un emissario dell’avvocato di Frank che ha pensato bene di farla sfogare, per guadagnare il tempo necessario a sistemare le cose. L’avvocato tratta con l’assicurazione e con raffinati espedienti, ottiene che la denuncia contro Frank e Cora venga ritirata. I due amanti vengono liberati. (Capitolo 10 e 11).
Dopo il funerale del greco, Cora e Frank trovano modo di spiegarsi tra loro. Di nuovo, dalle parole passano ai fatti e si prendono con brutalità ( Capitolo 12).
Il rapporto tra Cora e Frank si trascina tra litigi e sbornie. Frank ha un’avventura fugace con un’artista di un circo. Lei si trova bene e con lui e gli propone di aggregarsi alla carovana. Ma Frank sente che ormai non può più fare a meno di Cora e torna da lei ( Capitolo 13).
Cora nel frattempo è stata in Iowa per il funerale di sua madre. Il rapporto tra lei e Frank pare rasserenarsi. Ma rispunta fuori il dattilografo dell’avvocato che dopo essere stato licenziato ha bisogno di soldi e vuole ricattare Cora, avendo conservato la sua confessione. Frank lo pesta a sangue, si impossessa della confessione e la distrugge. Cora lo deride: per lei la cosa era irrilevante, una volta assolta non poteva più essere processata per quel reato. Il rischio avrebbe riguardato solo Frank. E’ irritata con lui perché ha scoperto la sua avventura con la donna del circo, e ha una crisi isterica. Durante la notte, si calmano e si spiegano. Decidono di sposarsi. Lei rivela a Frank di aspettare un bambino da lui. Dopo il matrimonio vanno a fare un bagno in spiaggia. Mentre tornano a casa, hanno un vero incidente di macchina e Cora resta uccisa ( Capitoli 14 e 15).
Frank viene accusato d’aver provocato a bella posta la morte di Cora e stavolta l’avvocato non riesce a fare nulla per lui. Disilluso di tutto, sperando ormai solo di poter riunirsi a Cora nell’aldilà, Frank scrive la sua storia nel braccio della morte, dopodiché attende solo che lo vengano a prelevare (Capitolo 16).
I primi capitoli del romanzo sono brevi e rapidissimi. I fatti si susseguono a un ritmo bruciante. Il capitolo 9 è molto più lungo. La vicenda rallenta dando spazio all’inchiesta ,alle strategie processuali, insomma al lato più propriamente “giallo” della storia. Ma il rallentamento corrisponde anche al venir meno della furente tensione erotica tra i due personaggi, che seppure con alti e bassi, scarti e ritorni indietro, si trasforma in una storia d’amore segnata tanto dalla colpa quanto dal sogno di trovare stabilità: una casa, un reddito sicuro, un bambino, un futuro più sereno. Il finale è improvviso e tronca la storia con freddezza, proprio come se le forbici del destino ne spezzassero il filo di netto. Questa alternanza di ritmo, molto ben giustificata nel romanzo, presenta un problema dal punto di vista della trasposizione cinematografica. I ritmi in un film si possono certo alternare, ma bisogna sempre stare attenti che le diverse parti (grosso modo i Tre Atti) non abbiano tempi troppo diversi tra loro perché l’opera complessiva non risulti squilibrata. Nel caso, il Primo Atto potrebbe apparire troppo sbrigativo, il Secondo eccessivamente lungo e il Terzo Atto nient’altro che un brusco finale. Come è stato risolto il problema nei film di Visconti e di Rafelson?
In Ossessione, Visconti parte in quarta, con lo stesso ritmo incalzante e provocatorio del romanzo. Poi elimina dei passaggi. Cancella del tutto il primo tentativo di omicidio, passando subito all’omicidio riuscito. Nella parte centrale del racconto, evita le alternanze e gli andirivieni tra l’ambiente reclusorio e statico della trattoria e le escursioni en plein air alle città vicine. Lascia la trattoria e si affida alla dinamica del viaggio, degli ambienti sociali e degli spazi aperti, potenziando la dinamica degli eventi, ravvicinandoli temporalmente, in modo che pur aprendo lo spazio del racconto, il ritmo non rallenti troppo. In questa sezione, Visconti inserisce un personaggio di sua invenzione: il protagonista incontra infatti un suo simile, un ex vagabondo che fa l’imbonitore da fiera, che lo aiuta, gli procura un lavoro, per quanto poco gratificante, e da amico ne ascolta lo sfogo e gli consiglia, senza successo, di tenersi ben lontano dalla donna che gli ha fatto perdere la testa. E’ un inserimento brillante. Il romanzo infatti è narrato in prima persona e il protagonista può dunque raccontare i suoi dubbi direttamente al lettore, ma in un film deve esteriorizzarli a un interlocutore, qui genialmente rappresentato nella figura di un alter-ego. Inoltre in questo modo, si mostra che il protagonista ha avuto a disposizione un’alternativa, una scelta diversa, e questo rende drammaturgicamente più efficace il fatto che la rifiuti, a dispetto di ogni evidenza. Tutta la lunga fase processuale viene eliminata. La polizia agisce sul campo, segue e insegue i sospetti, che fuggono e si sfuggono, si tradiscono, cedono ai nervi, si ritrovano, vivono permanentemente braccati dagli altri e da se stessi, finché l’incidente fatale durante l’ultima e apparentemente liberatoria fuga, diventa la fine inevitabile della corsa. Lui è ancora chino sul cadavere di lei, quando la polizia lo raggiunge. Tutto si conclude lì. Ma non è un finale brusco. E’ una finale predestinato. Non c’è più nulla da spiegare, perché la vicenda si è spiegata da sola, nel suo svolgersi.
Nel Postino suona sempre due volte di Rafelson, la prima parte viene invece rallentata, l’incontro sessuale tra i due protagonisti è frutto di un corteggiamento più cauto che esplode con furia proprio perché rimandato. In uno sforzo di maggiore rispetto del romanzo, nessun passaggio narrativo viene trascurato o eliminato, anzi se ne aggiungono altri. Ad esempio nel romanzo la festa del greco uscito dal ricovero in ospedale non viene affatto raccontata, mentre nel film è rappresentata in una scena di parecchi minuti nella quale il greco ha un rilievo, come personaggio, del tutto assente nel romanzo. Le partite a biliardo (eliminate da Visconti) diventano un gioco d’azzardo stradale e vengono così sbrigate più velocemente, ma restano comunque un passaggio poco incisivo. La parte processuale è così ampia da diventare un film nel film e il personaggio assolutamente minore dell’avvocato assume un ruolo ingiustificato da co-protagonista. L’unico taglio, tra tante aggiunte, è nel finale, dove Frank resta prostrato e sconfitto di fronte al cadavere di Cora, senza che ne segua l’arresto e la sedia elettrica, che a quel punto sarebbero un’appendice drammaturgicamente forzata e inutilmente punitiva. La critica cinematografica, che in genere tende a premiare lo sforzo di maggiore fedeltà a un’opera narrativa, in questo caso è stata compatta: il film è insopportabilmente lento.
2. I protagonisti
Ho già sottolineato nelle prime lezioni, quanto sia fondamentale in un film presentare con efficacia i personaggi, in modo da esprimerne subito, visivamente, non solo il carattere, ma il momento emotivo in cui si trovano. La presentazione che Visconti fa della coppia protagonista è esemplare. Lui, scoperto addormentato sul retro di un carro, viene svegliato e si avvia alla trattoria, entra e si avvicina al banco, senza che il pubblico possa mai vederlo in volto. Sente una donna cantare dalla cucina. Si avvia da quella parte, sempre di spalle, e si ferma sulla soglia. Davanti a lui ora c’è l’altra protagonista, ma nemmeno lei vediamo: lui la impalla lasciandocene scorgere soltanto le gambe nude e dondolanti. Stacco su di lei che si sta limando le unghie seduta su un tavolo e solleva lo sguardo, smettendo di cantare, con espressione più sfrontata che sorpresa. Solo a quel punto vediamo il volto di lui, che si incanta e si accende. Ricordo che il film è del 42. Il protagonista presentato di spalle anticipa di molti anni lo stile di presentazione dei personaggi di Brando e di James Dean. La protagonista, preceduta dal suo canto, e rappresentata come una sensuale apparizione, vi ricorda nulla? E’ la sequenza di presentazione di Gilda, di cui abbiamo già parlato. Solo che Gilda è un film di quattro anni dopo! L’intensità di questo primo incontro tra i personaggi, che è anche il nostro primo incontro con loro (si scoprono con uno sguardo, nell’istante stesso in cui noi li scopriamo), esprime già il loro distinto carattere e insieme il rispecchiamento dell’uno nell’altra, la reciproca intesa.
Nel film di Refelson l’incontro è invece rimandato. Tutta la rappresentazione è più debole. Prima entra in scena Jack Nicholson e ci viene mostrato immediatamente, affidandosi semplicemente a lui. Non è il personaggio che entra in scena: è Jack Nicholson. Jessica Lange la vediamo dal suo punto di vista: una presenza femminile che traffica in cucina e gli dedica solo uno sguardo distratto. Inoltre la precisione drammaturgica e l’esibita fedeltà al romanzo vanno entrambe a farsi benedire a priori e indipendentemente dalla volontà dello sceneggiatore, in virtù della stessa scelta degli attori che non corrispondono per nulla ai personaggi del romanzo: Jack Nicholson non è un ragazzo di ventiquattro anni apparentemente innocuo, è un uomo adulto e con la faccia da gangster. Non c’è alcun motivo logico per cui il greco possa fidarsi di lui e offrirgli un lavoro da garzone, né si capisce perché Cora dovrebbe sentirsene attratta e insieme giudicarlo abbastanza ingenuo da poter essere manovrato. Jessica Lange inoltre non è certo il tipo della ragazzotta rustica ex-miss scolastica di uno sperduto borgo dello Iowa e infatti, forse proprio per evitare l’implausibilità, nel film non ci rivelerà nulla del suo passato. (Se infine si considera che originariamente il ruolo di Cora era stato offerto addirittura a Maryl Streep , appare evidente quanto il film fosse fuori strada prima ancora di venire realizzato). Forse si confidava che la scelta di attori di grande richiamo avrebbe reso più esplosive le scene calde (quasi hardcore, non solo per la furia, ma per l’insistenza su certi dettagli, come la mano e la faccia di Nicholson tra le cosce di Lange). Anche queste scene paiono forzate, troppo volute, ed esse stesse deboli (non ci sono i morsi e il sangue del romanzo). Era del resto piuttosto ingenuo pensare che potessero ancora apparire forti nel 1981, cioè ben otto anni dopo Ultimo Tango a Parigi. Non c’è dunque da stupirsi troppo se, completamente fuori ruolo, sia Nicholson che Lange hanno offerto una delle interpretazioni peggiori della loro brillante carriera.
3. L’ambiente
Gli anni 30 e il desolante sud California di Cain immergevano la vicenda criminale nella giusta cornice della Depressione, nella quale le illusioni e le speranze dei due giovani protagonisti non potevano che richiedere il prezzo del delitto e andare drammaticamente deluse. Le trasposizioni europee, sia quella francese che quella italiana, trovarono sicuramente un punto di grande forza espressiva nel dipingere un quadro di campagna degradata a puro territorio di attraversamento, luogo di marginalità assoluta rispetto alle grandi città. Visconti sceglie un’ambientazione molto insolita, nel cinema italiano di tutte le epoche, e cioè le Marche, che sono per tradizione una sorta di territorio “a parte”, sufficientemente neutro da non richiedere caratterizzazioni troppo pronunciate in termine di usi locali e di dialetto, come sarebbe stato invece scegliendo il Veneto o la Campania. Questa felice scelta impedisce al contesto di inghiottire la vicenda. La vicenda, tanto accuratamente ambientata, quanto spaesata, mantiene così una sua esemplarità al di là dell’ambiente, come è caratteristica di un vero dramma, che in quanto dramma umano, deve riguardare tutti, e non apparire mai come pretesto per raccontare una realtà sociale specifica. Tanto per chiarire: L’Oro di Napoli non può ovviamente venire ambientato altrove, le sue storie si inscrivono in un ritratto della città, di quella città e della sua cultura. Le dinamiche di un noir invece debbono serbare una loro astrattezza. Il luogo non è certo indifferente, né il momento, ma non deve mai prevalere sul destino dei protagonisti che anzi ci vengono narrati come “estranei”, irriducibili alla realtà che li circonda, in disperato conflitto con essa, in cerca di riscatto e di fuga, nomadi perpetui e predestinati, trascinati come rifiuti dal fiume della vita. L’ambiente giusto è dunque quello che meglio consente di rappresentare questa loro condizione vissuta di estraneità.
Nel film di Rafelson invece il contesto, spostato in una terra di nessuno del centro america, incrocio di tutte le direzioni possibili, e negli anni 40, è una cornice d’epoca di mero contorno, resa meno miserabile e più patinata da una fotografia flou chiaramente orientata ad alleggerire, quasi si pensasse che il film fosse già di per sé sufficientemente crudo da non dover venire aggravato da immagini di degrado. Pesava sicuramente il confronto con la precedente edizione americana, la quale trasferiva la storia in un bianco e nero, gioco perpetuo di luci ed ombre, che la rendeva assolutamente astratta e la impreziosiva con il caratteristico glamour del film noir: Frank, un duro attraente, Cora una bionda platinata. Rispetto a questa attrattezza totale, probabilmente Rafelson intendeva dare maggior peso al realismo d’ambiente, pur serbando uno stile elegante che preservasse il film dal rischio opposto, quello di precipitare nel trucido. Si resta così a metà strada, in una caratterizzazione che non caratterizza a sufficienza, né in direzione dell’astratto, né in quella del concreto. Lo stesso per le scelte di dialogo, che nel romanzo è costituito da una lingua frammentaria e incerta, a volte esibizionisticamente sferzante, altre volte ingenuamente sentimentale e ridondante di luoghi comuni. Cioè la lingua di due ragazzi immaturi. Il linguaggio usato da Nicholson e Lange è scarno e funzionale, nemmeno questo ci aiuta a capire chi sono. Il risultato è che tutto appare ancor più finto e nulla ci aiuta a capire perché i protagonisti ragionino e agiscano in quel modo.
( NOTA- Come si vede, non sempre la quantità di mezzi a disposizione, l’eccellenza del cast, la forza d’impatto della promozione, riescono a salvare un film dal flop e, ciò che più conta, da un modesto risultato espressivo. Ho già accennato a come Jerry Lewis nella sua scuola di cinema facesse studiare i film brutti in modo da far capire bene agli allievi i possibili errori. Ma film brutti non significa necessariamente film realizzati dilettantisticamente, anzi i film non riusciti che allo studio ci rivelano gli errori più sorprendenti, sono proprio quelli realizzati con i migliori professionisti. Il professionismo di per sé non preserva dagli errori. Non si sbaglia soltanto quando si è alle prime armi, si può sbagliare sempre, anche ai massimi livelli. Studiare gli errori è fondamentale per evitarli. Ma non commettere mai più errori è praticamente impossibile, soprattutto in un lavoro complesso e collettivo come quello del cinema. Se restate frustrati di fronte a un vostro errore, tanto da sentirvi spinti a rinunciare, non siete fatti per questo lavoro. L’errore è oltre che difficilmente evitabile, fondamentale, se si impara a riconoscerlo, per crescere ed affinare la propria espressività. Il vero problema casomai è che oggi l’industria cinematografica non consente più come un tempo la possibilità di sbagliare ai registi, agli attori e, in misura certo minore, anche agli sceneggiatori. O si ottengono risultati immediati o continuare diventa difficile. Questo però non è colpa di chi lavora come regista, come attore o come sceneggiatore. E’ un errore dell’industria, che riconosciuto o meno, crea danni strutturali e di lunga durata.)
In conclusione: molti sono gli elementi da soppesare in una trasposizione da romanzo a film.
Il primo è la scelta di cosa mantenere e di cosa eliminare. Un film non si appoggia soltanto sul linguaggio verbale: ci mostra le cose, ci fa ascoltare suoni, rumori, musiche o silenzi, e da questo punto di vista è una narrazione globale, più ampia di quella della letteratura. Ma un film ci racconta tutto questo in un tempo dato, che è tempo narrativo (format e scansione ritmica del racconto, che in un romanzo non corrispondono a regole predeterminate) e tempo di ricezione (uguale per tutti gli spettatori, mentre il tempo di lettura di un romanzo è differente per ogni singolo lettore). Sotto questo profilo, la narrazione di un film è molto più breve e sintetica. Mostrando di più, può però raccontare meno, se vuole raccontare bene. Una digressione in un film pesa molto di più che in un romanzo e tra l’altro in un romanzo possiamo anche prenderci il lusso di saltarla e passare oltre, mentre in un film no (in genere ci ritroviamo dormienti prima che sia finita). Le scelte che eliminano sono dunque in un adattamento cinematografico più opportune e premianti di quelle che aggiungono. In particolare gli snodi della vicenda vanno semplificati. Le aggiunte si rivelano necessarie non solo e non tanto per potenziare l’aspetto spettacolare (esempio: l’aggiunta dell’animata scena di ballo e di festa in onore del greco), ma per poter esprimere in linguaggio cinematografico, cioè mostrando in azione, ciò che in un romanzo viene semplicemente narrato a parole e in una dimensione psicologica distinta dagli eventi (esempio: i tormenti interiori di Frank, da lui confessati in Ossessione a un altro personaggio).
Il secondo elemento fondamentale è la rappresentazione dei personaggi, rispetto alla quale il cinema è certo più erede delle tecniche di scrittura teatrale che di quelle romanzesche. In un film il personaggio fin dal suo primo apparire deve trasparire, cioè comunicare la sua fisicità, il suo ruolo, la sua essenza e il suo stato d’animo. Una presentazione casuale o sbagliata finisce per pesare negativamente sul personaggio, sulla sua identità e sul suo sviluppo drammaturgico.
Il terzo elemento è la scelta dell’ambientazione. Bisogna valutare molto bene se in un romanzo i personaggi e la storia sono inseparabili dal loro ambiente (abbiamo ad esempio visto come si sia in prevalenza scelto di non separare Jekyll dalla Londra vittoriana, e del resto sarebbe ben più arrischiato separare Sandokan dalla Malesia ), o hanno invece sufficiente autonomia da poter essere trasportati in altro contesto e in altra epoca (ad esempio Emma Bovary in quanto personaggio-simbolo di un certo tentativo di evasione/riscatto femminile è stata spesso dislocata senza soffrirne troppo). Tuttavia bisogna anche valutare attentamente come e quanto il mutato ambiente si presti a mettere in luce (meglio se in nuova luce) quel personaggio e quella storia, a meno che non si voglia farne un adattamento così libero da rendere pretestuosa l’origine letteraria.
23° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com
Prima di affrontare l’esame di altri generi cinematografici, è bene considerare un aspetto che li percorre trasversalmente. Avrete già notato che abbiamo spesso parlato di film, di generi diversi, ma egualmente ricavati (più o meno liberamente) da romanzi. Per lo sceneggiatore non si tratta in questi casi di scrivere una storia originale, pensata fin dal principio per il cinema, ma di trasporre cinematograficamente un’opera narrativa preesistente e che il più delle volte non prevedeva neppure una versione cinematografica. Sembrerebbe un compito particolarmente difficile per uno sceneggiatore, ma è tuttavia un’esperienza fondamentale, anche a puro titolo di esercizio, e offre notevoli vantaggi. Anzitutto siete liberati dall’esigenza di dover inventare una storia e creare dei personaggi, perché la storia e i personaggi esistono già. In secondo luogo, imparando a sceneggiare una storia scritta da altri, potrete familiarizzarvi con una situazione assolutamente abituale nel cinema. E’ infatti ancora oggi piuttosto raro che un film nasca dall’idea narrativa di uno sceneggiatore. Nella stragrande maggioranza dei casi, sarete chiamati a sceneggiare un’idea di altri, nata cioè da uno stimolo produttivo, dall’ispirazione di un regista o dalle aspirazioni di un attore di cartello. E spesso queste idee nascono da narrazioni pre-esistenti. Proprio per questi motivi uno dei test di ammissione più frequenti alle Scuole di Cinema è l’adattamento. Il fondamentale requisito di uno sceneggiatore non sta nel fatto di essere autore originale di una storia, ma di essere in grado di “mettere in scena” una storia, non necessariamente creata da lui stesso.
Ecco i requisiti preliminari per realizzare un adattamento:
1. Leggere il testo originale. Questo può sembrare ovvio, ma non lo è. Di certi romanzi classici, già oggetto di numerose trasposizioni, si può pensare di conoscere già la storia, quanto meno nei lineamenti essenziali, e che dunque basti rinfrescarsela con una rapida lettura. Niente di più sbagliato. I testi letterari che hanno avuto molte trasposizioni, si prestano alle più diverse interpretazioni: le varie versioni (teatrali, radiofoniche o cinematografiche) non sono meri remake, anzi ciascuna di esse si giustifica per la sua particolarità. Questo avviene perché ogni lettura di un romanzo interviene nel romanzo stesso. Il romanzo è fin dalle origini molto più interattivo di quanto si pensi, sicuramente molto più interattivo del cinema. Il lettore è infatti costretto ad immaginarsi i personaggi, gli ambienti e le situazioni, e ciascuno se li figura secondo la propria e autonoma sensibilità. Inoltre certi passaggi narrativi che risultano fondamentali per alcuni lettori, per altri non lo sono altrettanto e possono persino passare inosservati. Infine tempi, modi e capacità di lettura sono diversi da lettore a lettore. Dunque leggete e lasciate anzitutto che il romanzo solleciti la vostra immaginazione.
2. Scalettate gli eventi del romanzo, i passaggi fondamentali che scandiscono la storia dal principio alla fine. Passando alla sceneggiatura non dovrete necessariamente rispettare la struttura originale, ma dovrete comunque tenerla ben presente, per poter valutare ogni singolo scostamento. In un romanzo c’è sempre qualcosa da togliere, nel passaggio al film, e non lo si può togliere a caso, altrimenti si perde l’equilibrio dell’insieme. A volte c’è anche qualcosa da aggiungere, per esprimere meglio una situazione. Saltare o aggiungere un passaggio, alterare l’ordine degli eventi, riassumere un momento per sottolinearne invece un altro, sono tutte scelte che devono corrispondere all’efficacia cinematografica, ma anche a una coerenza generale del racconto.
3. Guardate, se ci sono, le precedenti trasposizioni cinematografiche. Molti non lo fanno per il timore di restarne condizionati. Timore ingiustificato. Che dalla stessa storia si possano trarre versioni tanto diverse, non potrà che stimolare il vostro particolare punto di vista. Sicuramente leggendo il romanzo avete avuto altre suggestioni e vi capiterà come al pubblico di restare se non delusi, perplessi di fronte a certi film tratti dal romanzo, perché avete visto trascurati momenti che alla vostra lettura sembravano invece tanto essenziali, quanto espressivi. Potrete di fronte alla pluralità e varietà delle versioni, sentirvi più liberi di esplorare fino in fondo la vostra.
4. Cercate di individuare il centro, il focus del racconto. Concentratevi su quei momenti del romanzo che per voi ne hanno espresso il senso più profondo. Qualcuno di voi potrà trovare la storia inscindibile dal suo contesto storico e geografico perché è proprio questo contesto che vi ha affascinato. Qualcun altro potrà invece essere più attratto da aspetti del tutto attuali, da una dinamica psicologica o di eventi che può essere raccontata e reinterpretata anche al di fuori di quel contesto. Qualcuno potrà trovare il focus nella filosofia espressa dal romanzo, nel suo rivelare una certa “verità” ,un prezioso punto di vista sul mondo e sull’esistenza umana. Qualcun altro potrà essere conquistato da un personaggio, non necessariamente il protagonista , e prendere quello a paradigma, narrandone la storia nella storia, il romanzo nel romanzo. Cercate di non divagare da un elemento all’altro. Il racconto cinematografico comporta scelte nette e decise.
5. Evitate di considerare il romanzo originale come pure pretesto per raccontare dell’altro. Il romanzo è un pre-testo, solo nel senso che precede la vostra trasposizione, ma è un testo e fa testo, che voi lo vogliate o no. Gli scacchi e la dama si giocano con la stessa scacchiera, ma sarebbe insensato giocare a dama con le pedine degli scacchi. Il romanzo definisce il gioco, a voi le mosse, ma dentro quel sistema di gioco. Altrimenti non si capisce (non lo capisce il pubblico) perché abbiate scelto quel romanzo, quando potevate farne benissimo a meno e raccontare invece una storia vostra. Il rispetto dell’originale sta tutto qui: non sta nel seguirne pedissequamente i passaggi in un improbabile sforzo di fedeltà, sta nel rispetto della vostra stessa scelta di partenza. Motivatela, ma non traditela. Spesso la scelta non sarà stata vostra. Qualcuno vi avrà affidato il compito di sceneggiare il romanzo, dandovi indicazioni generiche oppure estremamente precise. Ma dal momento in cui accettate il lavoro, quelle indicazioni dovranno diventare vostre e la scelta altrui dovrà essere da voi condivisa. Altrimenti è più onesto che diciate: no, grazie, quel romanzo (o la versione che me ne proponete) non mi convince.
Vediamo ora un paio di esempi celebri di trascrizioni cinematografiche (il primo subito, il secondo nella prossima lezione) che ci saranno utili a chiarire e approfondire in concreto le indicazioni di cui sopra.
a) Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde
Il romanzo breve di Robert Louis Stevenson esce nel 1886 e viene adattato per il teatro già nell’anno successivo da Thomas Russell Sullivan, che inserisce nel plot una storia d’amore del tutto assente nel romanzo. Questo primo adattamento fornirà poi la base per le più note versioni cinematografiche del romanzo (in totale se ne contano più di 120 e l’elenco continua ad allungarsi). Vediamo alcune delle variazioni più cospicue apportate all’originale.
1. La struttura narrativa
Il romanzo di Stevenson , come risulta evidente fin dal titolo, è un mistery. Inizia con un
 atto di violenza su una bambina perpetrato da uno sconosciuto. Si scopre poi che questo sconosciuto (Hyde) è stranamente protetto da un medico e ricercatore illustre (il dottor Jekyll). Finché si verifica un vero e proprio delitto, compiuto da Hyde, per inspiegabili motivi, ai danni di un anziano deputato. Hyde viene braccato. L’ambiguità del suo rapporto con Jekyll suscita angosce nella cerchia degli amici del dottore. Dello stesso Jekyll , sotto finale, si perdono le tracce o quantomeno il suo domestico si convince che l’uomo chiuso a chiave nel suo studio non sia Jekyll, ma Hyde. Nei rari momenti in cui riesce a vederlo, Hyde ha il volto coperto da una maschera, ma la sua bassa statura e la sua magrezza lo rivelano comunque tutt’altra persona dal dottore che è alto e rotondo. Irrompendo nello studio, dopo una notte molto agitata, un avvocato amico di Jekyll e il domestico trovano a terra il cadavere di Hyde. Una testimonianza autografa di Jekyll svela il mistero: Jekyll e Hyde erano la stessa persona, trasmutata grazie agli effetti di una pozione.
atto di violenza su una bambina perpetrato da uno sconosciuto. Si scopre poi che questo sconosciuto (Hyde) è stranamente protetto da un medico e ricercatore illustre (il dottor Jekyll). Finché si verifica un vero e proprio delitto, compiuto da Hyde, per inspiegabili motivi, ai danni di un anziano deputato. Hyde viene braccato. L’ambiguità del suo rapporto con Jekyll suscita angosce nella cerchia degli amici del dottore. Dello stesso Jekyll , sotto finale, si perdono le tracce o quantomeno il suo domestico si convince che l’uomo chiuso a chiave nel suo studio non sia Jekyll, ma Hyde. Nei rari momenti in cui riesce a vederlo, Hyde ha il volto coperto da una maschera, ma la sua bassa statura e la sua magrezza lo rivelano comunque tutt’altra persona dal dottore che è alto e rotondo. Irrompendo nello studio, dopo una notte molto agitata, un avvocato amico di Jekyll e il domestico trovano a terra il cadavere di Hyde. Una testimonianza autografa di Jekyll svela il mistero: Jekyll e Hyde erano la stessa persona, trasmutata grazie agli effetti di una pozione.In tutto il romanzo, i veri protagonisti restano sempre sullo sfondo e nell’ombra. I personaggi guida sono altri: gli amici, i conoscenti e i domestici di Jekyll. La tecnica, per tutto il romanzo, è quella del “parlano di lui”, anzi “di loro”: Hyde e Jekyll. In alcuni incontri fugaci, Hyde intrattiene diverse conversazioni, piuttosto ambigue. Jekyll è anche più riservato e sfuggente. Solo alla fine il dottore si racconta in prima persona e svela il mistero con una confessione postuma.
Gli adattatori si ritrovarono subito di fronte a un problema. Mentre in un romanzo i fatti possono essere narrati da testimoni, in teatro e in cinema il vero testimone dei fatti è lo spettatore. Ciò che in un romanzo viene riferito, in teatro e più ancora in cinema deve venire mostrato.
Questo coinvolge anche le scelte di tecnica narrativa. In un romanzo il “parlano di lui” può essere usato per l’intero sviluppo della storia . In Dracula di Bram Stoker, scritto in forma di romanzo epistolare, tutti parlano di Dracula, mentre lui non si esprime mai, è solo oggetto delle narrazioni altrui. In cinema, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, il “parlano di lui” può venire usato come prologo introduttivo alla comparsa del protagonista, come intermezzo di scansione, o come voce fuori campo di un narratore non-protagonista, ma in ogni caso i protagonisti devono agire ed esprimersi direttamente.
A questo primo problema di trascrizione, se ne aggiungeva un altro: il romanzo era divenuto subito talmente popolare che tutti conoscevano già il finale. Non si poteva dunque trasporre il romanzo rispettandone la struttura e la tecnica narrativa, ma nemmeno le caratteristiche di mistery perché il mistero non c’era più, e il finale non sarebbe stato per il pubblico un colpo di scena inatteso.
Bisognava dunque individuare altrove il focus narrativo e per il teatro ottocentesco (dove erano popolarissime le figure degli attori trasformisti) non c’era nulla di più stimolante che rappresentare dal vivo e in scena la trasformazione di Jekyll in Hyde. Il tema centrale del romanzo, al di là della struttura, era quello dello sdoppiamento di personalità, presentato in modo radicale, non come un comportamento doppio da parte di un singolo individuo, ma proprio come lo sdoppiamento di un individuo in due persone diverse. Era questo che il pubblico si aspettava di vedere. Dall’indeterminazione del mistery, dove i fatti salienti avvengono dietro le quinte, sono inafferrabili e vengono svelati solo alla fine, bisognava dunque passare alla concretezza emotiva dell’horror.
Ma la scelta di rappresentare la trasformazione, rispetto al romanzo, metteva gli adattatori di fronte a un altro problema e cioè…
2. I personaggi di Jekyll e Hyde
Nel romanzo, la descrizione di Jekyll è chiarissima. E’ un uomo di cinquant’anni, alto e rubicondo. Da giovane è stato un po’ scavezzacollo, ma ormai è uno studioso serissimo e per quanto sia impegnato in esperimenti segreti , nessuno dubita della sua limpidezza morale.
La descrizione di Hyde è invece volutamente vaga e imprecisa. Di sicuro sappiamo che è “un giovanotto” , di piccola statura, poco più di un nano, che ha un modo molto caratteristico di muoversi, rapido, leggero e a tratti scimmiesco. Una lieve peluria gli ricopre il dorso delle mani.
Ma quanto al volto, mistero assoluto. Nessuno riesce pienamente a descriverlo.
“ Che aspetto ha?” chiede l’avvocato Utterson a suo cugino Enfield (il quale, testimone di un’aggressione di Hyde a una bambina, lo ha fermato e poi trattenuto presso di sé per un’intera notte, costringendolo a rifondere i danni alla famiglia dell’aggredita). E questa è la risposta: “Non è facile a descriversi. C’è in lui qualcosa di strano, di ripugnante, di detestabile. Non ho mai visto un uomo così antipatico, eppure non saprei dire il perché. Colpisce sgradevolmente, sembra che vi sia in lui qualcosa di deforme , ma non saprei specificare cosa. Ha un aspetto anormale e tuttavia non potrei indicare esattamente in lui nulla fuori dell’ordinario. No, caro, non riesco a capirlo. Non riesco a descriverlo.” Altre volte nel romanzo si rimarca questa indefinibilità di Hyde, in nessun punto si dice che è un mostro. Un vetturino che lo incontra lo trova persino comico (perché Hyde indossa i vestiti di Jekyll, troppo grandi per lui), e soltanto di fronte alla sua reazione infastidita, ne intuisce la pericolosità.
Come mai Stevenson insiste tanto su questa indescrivibilità di Hyde? Da un lato, sottolinea che la ripugnanza destata da Hyde è di tipo istintivo… come quando ci troviamo di fronte a una persona che emana energie negative, che trasmette una deformità di tipo morale più che di tipo fisico. D’altro canto, da grande scrittore, Stevenson suscita l’inquietudine dei lettori mettendoli nella disagevole condizione di non potersi figurare Hyde. Il verbo to hide, significa nascondere. Mister Hyde è l’Uomo Nascosto (e Stevenson lo rimarca esplicitamente, perché la scelta del nome non sembri casuale). Il suo volto ci resta nascosto per tutto il romanzo. E questo ci inquieta molto di più che se Stevenson ci avesse descritto un mostro.
In teatro e più ancora in cinema è proibitivo rappresentare il non rappresentabile. Il pubblico è lì per vedere. Un personaggio di cattivo può essere mantenuto a lungo nell’ombra per renderlo più indecifrabile e minaccioso, ma a un certo punto deve essere mostrato. Nella foto allegata potete vedere il primo creatore dell’immagine di Hyde e cioè l’attore Richard Mansfield, primo interprete teatrale del doppio personaggio Jekyll/Hyde. Potete intuire, anche se la foto non è chiarissima, che raccorcia, accucciandosi, la sua statura e assume una postura scimmiesca. Gli spunta una barba, eppure non c’è ancora in lui l’aspetto mostruoso che ne ha fatto la fortuna cinematografica. In cinema è difficile rappresentare la deformità morale quando essa è unita alla trasformazione fisica. Una metamorfosi malvagia deve apparire anche fisicamente malvagia. Se dunque un uomo si trasforma in mostro, che mostro sia fino in fondo: più mostruoso apparirà, più lascerà il pubblico senza fiato.
Sono pochi gli esempi cinematografici di un Hyde più fedele a quello “indescrivibile” del romanzo. Nel film Il testamento del Mostro (1959), Jean Renoir grazie alla performance prodigiosa dell’attore mimo Jean-Louis Barrault, ci presenta un Hyde meno sfigurato del solito nel volto, ma tanto più inquietante nel movimento, nella camminata agile e nervosa, quasi comica a tratti, un Hyde che compie i suoi pestaggi con leggerezza fanciullesca, quasi danzando (e anticipando i picchiatori-clown di Arancia Meccanica ).
Terence Fisher nel suo The Two faces of dr.Jekyll (1960) ci presenta addirittura un Hyde bello e aitante. E una scelta simile compie Alistair Reid in un interessante film tv del 1981 con David Hemmings. L’intento è quello di discostarsi da un modello cinematografico ormai sedimentato e dunque troppo prevedibile. Vi siete abituati a vedere un Jekyll distinto e un Hyde mostruoso? Beh, io vi sorprendo presentandovi un Jekyll bolso e un Hyde seducente.
Questo capovolgimento totale, soprattutto nella versione di Reid, ha il merito di recuperare un tema ben presente nel romanzo e in genere trascurato: Jekyll è un cinquantenne alle soglie della vecchiaia e Hyde è giovane. Cioè quello che spinge Jekyll verso Hyde è il desiderio di ritrovare l’energia vitale che sta perdendo, di rivivere le potenti emozioni e le passioni travolgenti della gioventù e persino dell’infanzia, liberandosi dal ruolo sociale “per bene” tipico della maturità avanzata e anticamera del pensionamento. Cancellando questa motivazione, non ci capisce perché Jekyll si trasformi in Hyde. Resta solo il suo assunto morale (ben poco persuasivo in un ricercatore scientifico e in effetti per renderlo plausibile Stevenson fa di Jekyll un seguace della “medicina trascendentale”): Jekyll tenta di isolare il male per espellerlo. E’ vero che nel romanzo Jekyll sostiene proprio questo, che cioè lo scopo iniziale della sua ricerca era di perfezionare l’essere umano, separando il bene (prevalente) dal male (la parte meno sviluppata di noi, ecco perché Hyde è quasi nano), ma la narrazione ci mostra la verità al di là delle intenzioni “ideologiche” di Jekyll e cioè che Jekyll cerca di ritrovare attraverso Hyde la giovinezza e l’allegra dissolutezza che ha ormai perduto.
3. La pozione
Anche la vita di Hyde , oltre al suo aspetto, nel romanzo ci resta occulta. Sappiamo che è impegnato a dare sfogo alle libidini più perverse, ma non viene svelato quali siano. Di certo, Hyde è in preda a una costante e incontrollabile eccitazione. La “pozione” che dà vita ad Hyde, non è un filtro magico, è qualificata né più né meno che come una droga. Così si lamenta il domestico di Jekyll: “Ogni giorno, anche due o tre volte al giorno, sono dovuto correre da tutti i farmacisti della città. Ogni volta che tornavo a casa con la roba, mi diceva di riportarla indietro perché non era pura e mi dava un altro ordine per un’altra farmacia. Questa droga veniva chiesta disperatamente, chi sa per quale scopo.” Il dottor Lanyon, collega di Jekyll, descrive così la sostanza: “una specie di sale cristallino di color bianco.” Il famoso e misterioso filtro nel quale la polvere va versata è soltanto una soluzione adatta a sciogliere quel “sale”. Il filtro diventerà inefficace, sia a compiere la trasformazione che ad invertirla, senza la polvere giusta. Finché ce l’ha, Jekyll deve aumentarne la dose di volta in volta. Ad un certo punto non ne ha più e nemmeno può procurarsela perché scopre amaramente che quella originale, quella che funzionava, era stata casualmente adulterata. Dunque Jekyll non dipende dal filtro, ma da una droga che non ha fabbricato lui e che non riesce a ricreare. Per di più gli effetti hanno ricadute a lunga scadenza… la trasformazione in Hyde tende alla permanenza, mentre quella di rientro si fa sempre più fugace. Ormai il dottore non può più tornare indietro. E ad ogni nuova trasformazione, Hyde è sempre più esaltato e incapace di governare i suoi impulsi, che lo spingono non solo alla furia, ma anche a mille astuzie per procurarsi denaro, ad umiliarsi per sfuggire ai guai che combina, e infine addirittura al pianto dirotto e disperato di chi si sente minacciato dal mondo, dal suo creatore e persino da se stesso. Il suo percorso è suicida, perché in Hyde la via della distruzione non può che condurre all’autodistruzione. Per Stevenson, Hyde non diventa (fisicamente) un mostro, lo diventa (moralmente) sotto l’influsso della droga. Quando Lanyon gli porta l’ennesima polverina, Hyde gli grida: “L’avete qui? L’avete qui?” e gli afferra un braccio, scuotendolo, “in preda a una fosca eccitazione.” A Stevenson non interessa la corruzione dei costumi di Hyde, non gli importa nulla di raccontarci le sue imprese lussuriose, ci sta parlando del dramma della dipendenza, con una forza espressiva e una precisione che nessuno scrittore prima di lui aveva osato esibire. Ma questo aspetto del romanzo dovette apparire così perturbante che persino a distanza di decenni il cinema ha evitato di sottolinearlo. Nei film, è Jekyll che si suicida, per eliminare Hyde. Nel romanzo le cose non stanno affatto così. Nella sua lettera d’addio, Jekyll scrive: “In qual modo non posso prevedere, ma il mio istinto e tutte le circostanze della mia indefinibile situazione, mi dicono che la fine è sicura e dev’essere vicina.” Cioè la fine è inevitabile. Jekyll non la ricerca, ci si abbandona. Sa che diventerà Hyde e che Hyde sarà sempre più debole e non potrà reggere all’astinenza. Quando Hyde muore, Jekyll è già scomparso da tempo.
Il film tv di Reid, in uno sforzo di maggiore adesione al romanzo di Stevenson, ci mostra , alla fine, il cadavere di Jekyll che si trasforma in Hyde. Questa è un’eccezione assoluta tra i film tratti dal romanzo, nei quali è sempre Hyde alla fine a trasformarsi in Jekyll, con il trasparente intento di tranquillizzare il pubblico mostrando la redenzione di Jekyll che, nella morte, è riuscito a tornare se stesso.
4. La Londra Vittoriana
Il romanzo può anche essere legittimamente interpretato come un apologo morale che denuncia l’ipocrisia della società Vittoriana. Spesso la figura di Hyde è stata associata a quella di Jack lo Squartatore che insanguinava i vicoli di Londra in quegli anni, era probabilmente un membro illustre dell’aristocrazia e dimostrava una notevole perizia medico-chirurgica. Di questo riferimento Stevenson non può essere considerato responsabile, se non come anticipatore e profeta, in quanto il suo romanzo uscì nel 1886 mentre i delitti di Jack si verificarono due anni dopo. Per di più alcuni critici hanno rilevato che la Londra descritta da Stevenson somiglia più a Edimburgo che a Londra stessa e che il romanzo non inizia nelle nebbie, ma in una placida domenica assolata, nella quale l’aggressione di Hyde alla bambina risulta ancor più scioccante. Resta comunque indubbio che la cornice storico geografica e la quasi contemporaneità con i delitti di Jack The Ripper si imprimono indelebilmente nell’immaginario collettivo. La storia diventa un tutt’uno con la sua cornice e questo spiega perché la stragrande maggioranza dei film tratti dal romanzo ne ha rispettato appieno l’ambientazione (con aggiunta di molte nebbie).
5. Infedeltà o tradimento?
Riassumendo: nella maggior parte dei film tratti dal capolavoro di Stevenson, non solo la struttura narrativa viene cambiata, non solo Hyde, contro le indicazioni dell’autore, è raffigurato come un mostro, non solo la sua tossicodipendenza e la sua gioventù vengono trascurate, ma anche il finale risulta stravolto. Non si può però con questo dire che il cinema abbia (in generale) tradito il romanzo. Ne ha colto il seme (lo sdoppiamento) e l’ha piantato e fatto crescere in un altro terreno. Ha tolto al romanzo molte delle sue caratteristiche e ha aggiunto cose e personaggi che non c’erano: quadri di vita sociale di Jekyll, squarci di vita dissoluta di Hyde, personaggi femminili (una promessa sposa di Jekyll e una prostituta schiavizzata da Hyde, vedi il film di Victor Fleming del 1942). Chi adattava di volta in volta non ha semplicemente portato il romanzo sullo schermo: ha condotto, a partire dal romanzo, un’operazione di riscrittura che teneva conto delle esigenze proprie della narrazione cinematografica in generale e anche del particolare momento di mercato che suggeriva adeguamenti (più o meno opportuni) al gusto del pubblico. Ha considerato anche le versioni cinematografiche precedenti, diventate la “vulgata” del testo, per aggiornarle o distaccarsene.
Tra i tanti film prodotti ne voglio ricordare uno in particolare, una classica versione “infedele”, e tuttavia pregevolissima: quella di Robert Mamoulian (del 1931). Qui la scelta di adattamento è resa trasparente fin dalla prima meravigliosa sequenza. Il film inizia in soggettiva di Jekyll. Noi siamo Jekyll, vediamo quello che lui vede. Usciamo di casa con lui, prendiamo una carrozza, andiamo in Università a tenere una lezione, e ad ogni passaggio veniamo omaggiati da servitori e persone che incontriamo, finché ci ritroviamo soli di fronte a uno specchio, in cui Jekyll vede il suo volto fino a quel momento occulto. Jekyll incontra Hyde già quando è di fronte allo specchio, di fronte a un se stesso che è altro da sé. In altri termini, anche senza droga, il germe della schizofrenia e dello sdoppiamento è in tutti noi.
Questo è sicuramente il messaggio più potente trasmesso dall’opera di Stevenson. Jekyll ci coinvolge perché tutti noi possiamo essere lui. In ciascuno di noi c’è una parte nascosta (Hyde) che chiede di uscire e una parte manifesta (Jekyll) che già all’origine è ambigua, tanto che persino il nome di Jekyll allude seppure in modo più mascherato (Je-kill: Io Uccido) alla potenzialità omicida di ogni essere umano. Attraverso uno scostamento narrativo dal romanzo, Mamoulian è riuscito ad esprimerne il significato centrale, separandolo ed isolandolo da quelli accessori, e rendendolo visibile.
Il compito di un romanziere è suggerire ai lettori una pluralità di interpretazioni in modo che ciascuno di loro, secondo la propria sensibilità, possa relazionarsi al racconto, facendolo proprio.
Il lavoro del cineasta consiste invece nello scegliere un’interpretazione tra le tante possibili ed esprimerla con radicalità, in modo che colpisca lo spettatore, molto più passivo di fronte allo schermo di quanto non sia un lettore di fronte a una pagina scritta.
Il cinema è una potente macchina di semplificazione che a volte può apparire devastante rispetto ai modelli letterari di riferimento, ma se di questa semplificazione facciamo lo strumento per cogliere l’essenza di un’opera, esprimendola non in un concetto, ma nella sintesi di un’immagine o di una sequenza, allora possiamo sperare di rendere omaggio all’originale creando al contempo cinema nella necessaria, indispensabile autonomia e secondo le modalità espressive specifiche del mezzo.
Nella prossima lezione esamineremo un’altra celebre trascrizione: Il postino suona sempre due volte.
NOTA
Da questo mese inauguro una nuova sezione (Contributi) con un interessante intervento/lezione di Davide Aicardi sulla Sketch Comedy. Davide fa parte della redazione di autori del programma TV Camera Café e sa bene di cosa parla. Tra le persone che seguono questo corso ce ne sono parecchie che frequentano corsi e scuole di cinematografia (anche internazionali) o che hanno già avuto delle esperienze professionali sul set o nella creazione di corti o di documentari. Sarebbe molto utile se raccontassero anche agli altri, che invece sono alle prime armi, le loro esperienze e le loro riflessioni. La sezione Contributi è aperta e spero di poter pubblicare presto altri utili interventi.
22° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com