Incontri ed Interviste
 Profondo rosso 40 anni dopo. Il capolavoro di Dario Argento uscì nelle sale il 7 marzo 1975 e il thriller italiano non fu più lo stesso. L’immaginario e le coordinate di quel racconto di suspense e paura girato in pochi mesi (settembre-dicembre 1974) fanno ancora oggi scuola per chi anche solo lontanamente si avvicina al genere. Profondo rosso spaventa sempre lo spettatore, da qualsiasi latitudine esso provenga. È un dato di fatto. Nel novembre scorso al festival di Torino per la proiezione speciale del film nessun gridolino davanti alla sequenza di David Hammings nel corridoio degli specchi, nessuna risata di fronte ai più macabri e sanguinolenti omicidi di molti protagonisti del film, ma solo mani davanti agli occhi e salti sulla poltroncina. Probabile che nel #ProfondoRossoDay che si svolgerà a Torino per l’intera giornata di sabato 7 marzo 2015 le reazioni saranno le stesse. La copia del film restaurata digitalmente verrà proiettata alle 20 e alle 22 al cinema Massimo sala tre, mentre durante il giorno all’interno dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, dove a sede il Museo del Cinema, potranno essere visionati materiali di scena originali, locandine, fotobuste, libri e riproduzioni di oggetti scenici di Profondo Rosso. Tra i cimeli da non perdere la mannaia dell’assassina Clara Calamai e il tavolo dove trova la morte Glauco Mauri, entrambi realizzati da Germano Natali.
Profondo rosso 40 anni dopo. Il capolavoro di Dario Argento uscì nelle sale il 7 marzo 1975 e il thriller italiano non fu più lo stesso. L’immaginario e le coordinate di quel racconto di suspense e paura girato in pochi mesi (settembre-dicembre 1974) fanno ancora oggi scuola per chi anche solo lontanamente si avvicina al genere. Profondo rosso spaventa sempre lo spettatore, da qualsiasi latitudine esso provenga. È un dato di fatto. Nel novembre scorso al festival di Torino per la proiezione speciale del film nessun gridolino davanti alla sequenza di David Hammings nel corridoio degli specchi, nessuna risata di fronte ai più macabri e sanguinolenti omicidi di molti protagonisti del film, ma solo mani davanti agli occhi e salti sulla poltroncina. Probabile che nel #ProfondoRossoDay che si svolgerà a Torino per l’intera giornata di sabato 7 marzo 2015 le reazioni saranno le stesse. La copia del film restaurata digitalmente verrà proiettata alle 20 e alle 22 al cinema Massimo sala tre, mentre durante il giorno all’interno dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, dove a sede il Museo del Cinema, potranno essere visionati materiali di scena originali, locandine, fotobuste, libri e riproduzioni di oggetti scenici di Profondo Rosso. Tra i cimeli da non perdere la mannaia dell’assassina Clara Calamai e il tavolo dove trova la morte Glauco Mauri, entrambi realizzati da Germano Natali.
 “Mentre giravo quel film sapevo esattamente ciò che volevo”, spiega Dario Argento al fattoquotidiano.it. “Ero molto rilassato, non sentivo lo stress. E poi la storia è bellissima. L’ho scritta in pochi giorni tutta d’un fiato. Fu miracoloso. Basta guardare un film per capire come sta il regista nel momento in cui l’ha girato”. Sua la sceneggiatura di Profondo Rosso, sua la regia, sua la scelta dei Goblin e della filastrocca nenia di Giorgio Gaslini come leitmotiv terrificante della presenza dell’assassino, sue le mani che stringono colli, accoltellano, spingono teste contro gli spigoli dei caminetti per spappolare dentature e crani: “Ho seguito il mio istinto – continua Argento – anche per il titolo che, per molto tempo, prima delle riprese e a sceneggiatura già finita con attori pronti a girare, non c’era. Prima ho sviato la stampa dicendo che si sarebbe dovuto intitolare La tigre con i denti a sciabola, poi mentre ero in macchina mi è venuto in mente Profondo Rosso. Ai produttori della CineRiz non piacque, dissero che era sbagliato, suggerivano al massimo Rosso Profondo. Per fortuna che m’impuntai”.
“Mentre giravo quel film sapevo esattamente ciò che volevo”, spiega Dario Argento al fattoquotidiano.it. “Ero molto rilassato, non sentivo lo stress. E poi la storia è bellissima. L’ho scritta in pochi giorni tutta d’un fiato. Fu miracoloso. Basta guardare un film per capire come sta il regista nel momento in cui l’ha girato”. Sua la sceneggiatura di Profondo Rosso, sua la regia, sua la scelta dei Goblin e della filastrocca nenia di Giorgio Gaslini come leitmotiv terrificante della presenza dell’assassino, sue le mani che stringono colli, accoltellano, spingono teste contro gli spigoli dei caminetti per spappolare dentature e crani: “Ho seguito il mio istinto – continua Argento – anche per il titolo che, per molto tempo, prima delle riprese e a sceneggiatura già finita con attori pronti a girare, non c’era. Prima ho sviato la stampa dicendo che si sarebbe dovuto intitolare La tigre con i denti a sciabola, poi mentre ero in macchina mi è venuto in mente Profondo Rosso. Ai produttori della CineRiz non piacque, dissero che era sbagliato, suggerivano al massimo Rosso Profondo. Per fortuna che m’impuntai”.
Sul set del film, girato in alcuni studi di posa ed esterni a Roma, ma soprattutto in memorabili esterni notte a Torino – si veda la sequenza del primo omicidio in piazza C.L.N. con tanto di baretto alla Hopper ricostruito in un angolo -, Argento conobbe l’attrice Daria Nicolodi e se ne innamorò: “È il film più bello di Dario”, racconta al fattoquotidiano.it Gabriele Lavia, nel film è Carlo l’amico del protagonista Marc/David Hemmings. “Nella regia si avverte qualcosa in più, una strana cosa che credo sia l’amore, quello di Dario per  Daria”. L’attore di origine siciliana che proprio in quegli anni interpretò parecchi titoli thriller e horror (Zeder di Avati e ancora Inferno di Argento) ricorda con affetto il set di Profondo Rosso: “Mi alzavo alle 6 del mattino a Milano per girare lo sceneggiato tv Marco Visconti e alle 17 arrivava una Lancia della produzione di Dario per portarmi a Torino sul set del film. Giravamo sempre di notte e per almeno una settimana credo di non aver mai dormito – continua Lavia -. La scena in piazza CLN fu molto complessa e spettacolare. Venne usato un innovativo dolly Chapman lasciato in Italia da una produzione americana. Comunque Profondo Rosso è davvero bello, e lo posso dire da poco tempo perché il film non l’ho mai voluto vedere se non pochi anni fa assieme a mia figlia”.
Daria”. L’attore di origine siciliana che proprio in quegli anni interpretò parecchi titoli thriller e horror (Zeder di Avati e ancora Inferno di Argento) ricorda con affetto il set di Profondo Rosso: “Mi alzavo alle 6 del mattino a Milano per girare lo sceneggiato tv Marco Visconti e alle 17 arrivava una Lancia della produzione di Dario per portarmi a Torino sul set del film. Giravamo sempre di notte e per almeno una settimana credo di non aver mai dormito – continua Lavia -. La scena in piazza CLN fu molto complessa e spettacolare. Venne usato un innovativo dolly Chapman lasciato in Italia da una produzione americana. Comunque Profondo Rosso è davvero bello, e lo posso dire da poco tempo perché il film non l’ho mai voluto vedere se non pochi anni fa assieme a mia figlia”.
Numerosi gli aneddoti di scena del film che ultimamente si possono ritrovare anche nel libro autobiografico di Dario Argento, Paura, edito da Einaudi. Tra i tanti, come l’uso di cocaina sul set o la microcamera snodabile Snorkel per carrellate ravvicinate sugli oggetti, ne va ricordato uno davvero singolare: dopo aver tolto l’intervallo durante Quattro mosche di velluto grigio, Argento non volle che si entrasse in sala a Profondo Rosso iniziato. La paura è un sentimento che va servito per bene, senza troppe distrazioni, perché come l’oramai 75enne regista romano ha sempre raccontato: “Finché là fuori c’è una persona da spaventare potrò dirmi una persona felice”.
di Davide Turrini per ilfattoquotidiano.it
 Ermanno Olmi ha voluto vere facce da freddo per 'Torneranno i prati', film sulla guerra del '15-'18 che ha appena finito di girare. E così, invece di utilizzare uno studio, si è esposto a quasi 83 anni al gelo della neve dell'Altopiano dei Sette Comuni (Asiago, Vicenza) per girare una sola notte di trincea. Ma oggi sul set del film il regista vola su tutti i temi: onestà, coraggio, disubbidienza e aggiunge: "Vorrei che questo film fosse più che bello, soprattutto utile contro la guerra".
Ermanno Olmi ha voluto vere facce da freddo per 'Torneranno i prati', film sulla guerra del '15-'18 che ha appena finito di girare. E così, invece di utilizzare uno studio, si è esposto a quasi 83 anni al gelo della neve dell'Altopiano dei Sette Comuni (Asiago, Vicenza) per girare una sola notte di trincea. Ma oggi sul set del film il regista vola su tutti i temi: onestà, coraggio, disubbidienza e aggiunge: "Vorrei che questo film fosse più che bello, soprattutto utile contro la guerra".
Tutto si svolge su l'altopiano innevato dei Sette Comuni dove sono state ricostruite due trincee, una a circa 1.100 metri d'altezza e una ancora più in alto, a 1.800 metri in località Dosso di Sopra, Val Formica. Creato e scritto dallo stesso Olmi, interpretato da Claudio Santamaria, Jacopo Crovella, Andrea Di Maria, Francesco Formichetti, Camillo Grassi e Niccolò Senni, racconta una storia realmente accaduta. Riconosciuto di Interesse Culturale con il sostegno del Ministero per i Beni Culturali e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato realizzato nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
In 'Torneranno i prati', prodotto da Cinema Undici e Ipotesi Cinema con Rai Cinema, tutto parte dai ricordi di un vecchio pastore, chiamato 'Toni matto' che visse da giovane soldato i combattimenti della prima guerra mondiale. Combattimenti avvenuti là dove da anziano fa pascolare i suoi animali e da bambino aveva giocato e vissuto. "Vorrei che più che un bel film sia un film utile. Un film che ci faccia chiedere - dice Ermanno Olmi - perchè questa guerra mondiale è accaduta. Le versioni ufficiali su queste cose non sono mai davvero credibili. Così, a 100 anni di distanza, il miglior modo di festeggiarlo è capire quello che è successo come capire perché oggi si parli ancora di conflitti". Per il regista de 'Il mestiere delle armi' ci sono ancora "nubi burrascose.
Nubi che preludono a un conflitto mondiale, ma ce la faremo". E aggiunge: "Ognuno di noi può fare qualcosa per evitare la guerra. L'onestà dovrebbe essere un dovere e tutti dovrebbero praticarla perchè le cose vadano avanti meglio. Chi non sopporto proprio sono quelli che non vanno a votare, perchè non capiscono quanto è stato doloroso per molti conquistare questo diritto". La storia, quella vera, aggiunge Olmi, "è quella raccontata da anonimi. Da persone che sono soli dati anagrafici. Non quella raccontata dagli scrittori famosi".
Del film, costato 3,5 milioni di euro per 7 settimane di riprese e girato in condizioni ambientali spesso avverse, Olmi tiene riservata la trama. Solo alla fine rivela che in 'Torneranno i prati' che si svolge nell'autunno del 1917 poco prima di Caporetto (24 ottobre), ci sarà un atto di disobbedienza: "Quello di un alto ufficiale e quello di un soldato semplice. La disubbidienza è giusta - dice il regista -.
Questi due personaggi, infatti, fanno valere la propria coscienza sulle esigenze militari. La disubbidienza in questo caso è un atto morale che diventa eroicità quando si porta avanti fino alla morte".
E, sempre riguardo alla guerra, Olmi aggiunge citando Einstein: "Non possiamo pensare che lo cose cambino se noi tutti continuiamo a fare le stesse cose". Mentre per quanto riguarda il suo ritorno dietro la macchina da presa, dopo che aveva annunciato nel 2007 il suo ritiro, dice: "a questo impegno non potevo sottrarmi. Raccontare la prima guerra mondiale in cui anche mio padre aveva partecipato come bersagliere e mi faceva capire, in memoria della guerra, come fosse importante anche un boccone avanzato".
La guerra comunque, aggiunge: "non è un'epidemia ma a volte è una cosa che nasce da piccole difficoltà, bisogna dunque cominciare a lavorare su sè stessi per evitare che ce ne siano ancora. 'Torneranno i prati', ormai in postproduzione (sarà pronto solo in autunno), potrebbe a tutto diritto partecipare al prossimo Festival di Venezia mentre per quello di Cannes i tempi sarebbero davvero ristretti.
 Quattro “giovani adulti” dei nostri tempi, alle prese col Problema dei nostri tempi: la crisi. Il regista quasi loro coetaneo Ciro De Caro racconta con originalità e spirito scanzonato una storia in cui i trentenni d’oggi possano riconoscersi, con un sorriso amaro che sfocia spesso in risata. E si avvale coerentemente di attori poco conosciuti e di un budget pressoché simbolico. Valerio è un attore ventinovenne, che non riesce a trovare ruoli all’altezza del suo idealismo e delle sue aspirazioni e quindi accetta frustranti impieghi part-time. Il suo amico Scheggia vive ancora con la nonna, e cerca di nobilitare la sua attività di pusher con un pragmatismo simpatico che annacqua l’amoralità delle sue scelte. Serena persegue un dottorato e tenta invano di sondare se anche il suo compagno Valerio voglia mettere su famiglia. Giovanna, la sorella di Valerio, continua a prestargli soldi rimproverandolo per la sua inconcretezza, e fra una stancante seduta e l’altra di massoterapia coltiva il sogno di diventare chef di cucina cinese.
Quattro “giovani adulti” dei nostri tempi, alle prese col Problema dei nostri tempi: la crisi. Il regista quasi loro coetaneo Ciro De Caro racconta con originalità e spirito scanzonato una storia in cui i trentenni d’oggi possano riconoscersi, con un sorriso amaro che sfocia spesso in risata. E si avvale coerentemente di attori poco conosciuti e di un budget pressoché simbolico. Valerio è un attore ventinovenne, che non riesce a trovare ruoli all’altezza del suo idealismo e delle sue aspirazioni e quindi accetta frustranti impieghi part-time. Il suo amico Scheggia vive ancora con la nonna, e cerca di nobilitare la sua attività di pusher con un pragmatismo simpatico che annacqua l’amoralità delle sue scelte. Serena persegue un dottorato e tenta invano di sondare se anche il suo compagno Valerio voglia mettere su famiglia. Giovanna, la sorella di Valerio, continua a prestargli soldi rimproverandolo per la sua inconcretezza, e fra una stancante seduta e l’altra di massoterapia coltiva il sogno di diventare chef di cucina cinese.
Quattro “giovani adulti” dei nostri tempi, alle prese col Problema dei nostri tempi: la crisi. Il regista quasi loro coetaneo Ciro De Caro racconta con originalità e spirito scanzonato una storia in cui i trentenni d’oggi possano riconoscersi, con un sorriso amaro che sfocia spesso in risata.
E si avvale coerentemente di attori poco conosciuti e di un budget pressoché simbolico, dimostrando che un film per vedere la luce necessita solamente dell’urgenza di essere realizzato. I continui jump-cut sembrano sottolineare stilisticamente le aspettative puntualmente abortite dei quattro personaggi, che nell’arco della storia compiranno, insieme e individualmente, un’evoluzione e, forse, avranno più chiara la direzione da prendere. Perché quando un quinto personaggio più sfortunato di loro, una prostituta cinese, incrocerà le loro vite, ognuno capirà se temporeggiare ancora o autoresponsabilizzarsi.
Nella solida sceneggiatura si alternano siparietti gustosi con coppie di personaggi antitetici: Valerio e Scheggia in primis. L’uno ingenuo, l’altro spensieratamente cinico, formano un duo collaudato, con tempi comici perfetti e dialoghi esilaranti quanto veritieri. La scena in cui Scheggia accompagna Valerio a un provino, per esempio, riesce a divertire ritraendo realisticamente la situazione lavorativa attuale: per fare carriera, più della professionalità e della competenza, pagano la disinvoltura e la sfacciataggine. Così, quando Valerio snocciola le sue esperienze teatrali con registi dal nome pretenzioso a un regista che ostenta la propria noia, non possiamo fare a meno di ridere e arrabbiarci.
Allora perdoniamo anche il finale vagamente buonista, che allevia la frustrazione di immedesimarci con tanta facilità in personaggi perennemente in bilico. (da sentieriselvaggi.it)
Di seguito l'articolo di Francesco Persili per Dagospia
Solo posti in piedi. Ma fuori c'è ancora gente, che si fa? Aggiungi un posto in sala. Uno, due, tre. Alla fine, si aggiungerà un'intera fila di sedie color nostalgia. Come fossimo in qualche nuovo cinema Paradiso o in una arena estiva. E, invece, siamo al cinema Aquila di Roma, in mezzo alla bohème del Pigneto, in fuga da tombolate e calcio inglese ché è pur sempre il 26 dicembre, ad aspettare l'inizio di ‘Spaghetti Story', il film indipendente sui trentenni di oggi che qui ha battuto anche il cinepanettone dei record.
Come sia possibile che una commedia generazionale ‘costata come un'utilitaria' diventi un piccolo caso cinematografico è qualcosa da cercare in quella formula magica chiamata passaparola. Sold out all'Aquila e al Tiziano (l'altro cinema di Roma in cui il film viene proiettato), il numero degli spettacoli quotidiani raddoppiati fino al 2 gennaio, applausi in sala che nemmeno alla prima di Ritorno al Futuro, un blabla che non è più circoscritto alla scena off. Una sorpresa anche per il regista, Ciro De Caro, quello di ‘Salame milanese', che nel 2011 ha passato 6 mesi a scrivere il suo primo lungo e poi ha impiegato 11 giorni per girarlo.
Dopo averlo portato in giro per il mondo (Mosca, Rekyavik), adesso officia con il resto del cast tutti gli spettacoli. E coglie ogni occasione per ribadire che il film è ‘no budget' e di come ‘la mancanza di mezzi può diventare un'opportunità' prima di cercare la didascalia giusta per una commedia che è stata celebrata perfino in Russia dall'Izvestia come ‘una boccata d'aria fresca'. Una storia contemporanea - spiega De Caro - che racconta un modo tutto italiano di fare le cose: semplice ma non privo di creatività, appassionato e popolare. Alla portata di tutti, come un piatto di spaghetti, appunto. Spaghetti way of life.
Una pellicola che si tiene lontano dagli orizzonti di boria e dalle velleità pseudo-intellò dei noiosissimi circuiti alternativi: il sospetto di un crepuscolarismo due camere e cucina viene tenuto a bada da una comicità perfido- romanesca che attenua il drammone esistenziale di questi 4 trentenni in cerca d'autore: il pusher post-pasoliniano ‘Scheggia' imbottito di Tavor e realismo (Cristian Di Sante), l'aspirante attore senza arte, né parte (Valerio Di Benedetto) con annessa fidanzatina che sogna un bambino e la famiglia (Sara Tosti), la massoterapista chef (Rossella D'Andrea).
‘Giovani, carini e disoccupati in salsa capitolina', ma nemmeno troppo. Neorealismo sfig e vena ‘malincomica', autoironia e difetti speciali, lagne e magagne di una combriccola di giovani adulti. Non senza forzature: così dopo il Coso di Argentero (vedi ‘Un Boss in salotto') anche qui c'è un altro trentenne irrisolto che fugge le responsabilità e si ritrova a giocare la sera col trenino: psyco-commedia all'italiana.
Dopo la proiezione, segue ancora dibattito. Non sono solo demi-monde cinematografaro e artistoidi in ordine sparso, tra gli spettatori molte persone comuni che incalzano i protagonisti. "Ma sei un attore vero? E se non sei attore, che fai?", chiedono a ‘Scheggia'. "Non faccio il pusher, tranquillo", replica lui, con ironia. "E' un film anche per i bambini?". "Sì, nel gatto della fortuna non c'è la droga ma il Nesquik"...
Battute, dialogo senza rete, risate. Poi c'è ancora tempo per qualche rivelazione del regista sulla selezione degli attori, a partire dalla strepitosa ‘nonna' incontrata a Trastevere e convinta con un cesto di frutta', e sul montaggio, ‘volutamente imperfetto'.
Mentre sulla scelta di ridurre la profondità di campo, arriva impietoso il contrappunto popolare: ‘Ahò, io faccio er tassinaro, mi diverto a riconoscere i posti in cui viene girato un film ma stavolta non c'ho capito ‘na mazza'...
Regia: Ciro De Caro
Interpreti: Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti, Rossella D’Andrea, Deng Xueying, Tsang Wei Min
Origine: Italia, 2013
Distribuzione: Distribuzione Indipendente
Durata: 82’
 Quindici cortometraggi per la tivù. Da girare a colori tra Roma e dintorni, benché la Rai di allora trasmettesse ancora rigorosamente in bianco e nero. Gli spunti li forniva la cronaca nera ma ancor più il costume dell’epoca, con temi che ormai avevano fatto irruzione nell’Italia post-boom di fine Anni Sessanta: la moda, la grande distribuzione commerciale, gli sport d’élite, il turismo, la stessa televisione. Per quanto possa sembrar strano Giorgio Scerbanenco, il padre del noir italiano, autore strettamente legato all’immagine della mala milanese e agli orizzonti polizieschi della costiera adriatica veneto-romagnola, stava per dare una svolta romana alla sua carriera di scrittore. E soprattutto, dopo aver avuto rapporti controversi con il cinema, aveva deciso di puntare tutto sulla televisione, di cui aveva intravisto le grandi potenzialità narrative.
Quindici cortometraggi per la tivù. Da girare a colori tra Roma e dintorni, benché la Rai di allora trasmettesse ancora rigorosamente in bianco e nero. Gli spunti li forniva la cronaca nera ma ancor più il costume dell’epoca, con temi che ormai avevano fatto irruzione nell’Italia post-boom di fine Anni Sessanta: la moda, la grande distribuzione commerciale, gli sport d’élite, il turismo, la stessa televisione. Per quanto possa sembrar strano Giorgio Scerbanenco, il padre del noir italiano, autore strettamente legato all’immagine della mala milanese e agli orizzonti polizieschi della costiera adriatica veneto-romagnola, stava per dare una svolta romana alla sua carriera di scrittore. E soprattutto, dopo aver avuto rapporti controversi con il cinema, aveva deciso di puntare tutto sulla televisione, di cui aveva intravisto le grandi potenzialità narrative.
Lo conferma la figlia dello scrittore, Cecilia, che in occasione del festival letterario Grado Giallo, parlerà proprio del rapporto fra il padre e il piccolo schermo. Un rapporto appena abbozzato, che si interruppe il 27 ottobre del 1969 a causa della prematura morte dell’autore di origine ucraina. «Papà credeva molto nel mezzo televisivo – sottolinea Cecilia Scerbanenco, che sta curando una monumentale biografia sul padre – Dopo tanti anni trascorsi nel mondo della carta stampata, fra giornalismo ed editoria, forse aveva voglia di cambiare. Anzi, stava pensando di lasciare Milano e trasferirsi a Roma proprio per seguire meglio questo progetto televisivo e altre iniziative legate al cinema».
Difficile per i fan immaginare uno Scerbanenco che abbandona i navigli e la nebbia delle periferie milanesi per far muovere i suoi cupi personaggi in riva al Tevere. Eppure, per lui, sarebbe stato un ritorno a casa, nella città dove visse fino all’età di quindici anni dopo una travagliata e traumatica infanzia russa (il padre fu ucciso nel corso della rivoluzione sovietica).
Benché a Roma avesse trascorso gli anni dell’adolescenza, Scerbanenco non vi ambientò mai nessuno dei suoi numerosissimi romanzi a sfondo noir. «La Capitale compare solo in due titoli degli Anni Quaranta - conferma la figlia - Opere di genere “rosa”, non certo poliziesco: Si vive bene in due e Quando ameremo un angelo».
Nel 1969 l’incontro con il produttore cinematografico Gigi Martello convinse Scerbanenco a rimodulare la sua produzione letteraria. E soprattutto a dare una svolta televisiva alla sua carriera di scrittore. Il progetto «Televisione a colori» era già definito e le quindici sceneggiature pronte per essere girate. I soggetti originali si trovano ora nell’archivio della biblioteca civica di Lignano Sabbiadoro, la cittadina friulana che l’aveva «adottato» e dove vive la figlia.
Fitte pagine di appunti scritti a mano, forse al Bar Gabbiano, di fronte al mare, dove Scerbanenco trascorreva le sue mattinate. E poi ricopiati dall’autore con la macchina per scrivere.
Quindici sceneggiature con titoli che portano l’inconfondibile marchio del maestro del noir: A Fregene col cadavere, Come uccidere una giornalista, Supermorte al supermercato, All’Olgiata si muore meglio, Requiem per un cavallo, La clinica che uccide, Allah a Fiumicino, I milioni delle Mantellate.
La narrazione è volutamente scarna, sincopata, sommariamente descrittiva come si conviene a una sceneggiatura. Ma i lettori di Scerbanenco vi riconosceranno senza difficoltà lo stile dell’autore di Venere privata e I milanesi ammazzano il sabato. Ecco un breve estratto dalla sceneggiatura di A Fregene col cadavere:
«Antonio e Cristina sulla Mercedes, che vagano per Fregene. La povera Maria Giovanna è sempre nel baule. Sole, sole e frenesia di corpi e di nudo anche per la strada. Antonio: Ti ho detto che adesso vado dai carabinieri e gli consegno la ragazza. Io sono solo un ladro, non voglio aver niente a che fare con gli assassini. Cristina: ma ti mettono in galera per trent’anni. Antonio: Spero di no. Tu scendi e torna al tuo ente provinciale del turismo, scemetta – le fa una carezza, mentre lei ha una smorfia di pianto, e quasi la butta fuori dalla macchina. Poi Antonio riparte subito, MdP (macchina da presa, ndr) inquadra Cristina dall’alto, Cristina diviene sempre più piccola».
«Il muso della Mercedes adesso corre in un vialetto secondario, sullo sfondo si vede una targa: Carabinieri. Antonio guida deciso verso la caserma dei carabinieri, deciso a confessare tutto pur sapendo che saranno mesi e mesi di galera, se va bene, se no forse anni. Un uomo all’improvviso gli sbarra la strada. È Michelone che girella per Fregene alla ricerca della “sua” Mercedes, e ora l’ha vista. Antonio è costretto a fermarsi, Michelone sale, impugna la rivoltella, la punta contro Antonio – Vai senza storie. Dove hai trovato questa Mercedes? Sulla strada da Macconese (sic, probabilmente si tratta di Maccarese, ndr) a qui, a Fregene? Hai per caso guardato nel baule? Sì – Antonio sussulta per la rivoltella che Michelone gli affonda nel fianco. E cosa hai trovato? Una ragazza morta. È Maria Giovanna, ne parlano tutti i giornali... Bravo, sei informato. Adesso mi aiuterai a sistemare la ragazza...».
di Giorgio Ballario per lastampa.it
Sabato, 26 novembre, all’apertura di Verso Sud, il festival di cinema italiano di Francoforte, la proiezione serale era dedicata all’ospite d’onore di quest’anno. Ogni edizione il festival decide di approfondire l’opera di un grande autore o autrice del nostro paese.
Questa volta si tratta di Cristina Comencini, regista tra le più apprezzate anche all’estero come testimonia la candidatura all’Oscar nel 2006 con il film la Bestia nel cuore e i cui film purtroppo in Germania sebbene sia conosciuta e riconosciuta, non sempre hanno trovato un distributore per le sale.
Abbiamo avuto il piacere di incontrarla poco prima della proiezione del suo film Latin Lover, uscito nel 2015.
Ai tavolini del Filmmuseum iniziamo un’intervista che si trasforma in una breve e rilassata conversazione. Le domande di rito sulla sua impressione riguardo a Francoforte e alla Germania sono una pratica sbrigata in fretta. Ci dice che a Francoforte è la prima volta ma è appena arrivata: “ho visto solo una grande e bella città, tutta natalizia”. In Germania invece non è la prima volta, è stata a Berlino che, si capisce, le piace molto: “Sono stata a Berlino per La bestia nel cuore, che ha anche vinto un premio, quindi diciamo che ho un buon rapporto col pubblico tedesco. Vorrei conoscerla di più, mi piace molto”.
La presenza nel cuore della Germania è occasione per discutere, se non della città, almeno della sua impressione sulle differenze “cinematografiche” con l’Italia. Ci dice che “il festival di Berlino è un festival molto impegnato. C’è una differenza forse a livello popolare. Ho la sensazione che ci sia una grande organizzazione molto buona per il cinema d’essay e per i festival, ma poi a livello popolare invece vada più il cinema americano. Noi invece abbiamo un cinema popolare, il nostro cinema è stato storicamente un cinema popolare anche se ha avuto un calo”. Ci fa notare così che questa è un’arte che ha bisogno di rinnovarsi continuamente, così se vogliamo trovare una ragione alla diminuzione degli spettatori di film italiani avanza l’ipotesi che poi ribadirà anche alla fine della proiezione, quando risponde alle domande del pubblico “io ho l’impressione che in Italia abbiamo fatto troppe commedie, le produzioni hanno visto che funzionavano e ne abbiamo fatte tantissime” e poi di nuovo sollecitata ammette il dubbio che “se in Germania il cinema francese riesce a venire distribuito e quello italiano no, non è perchè manca l’interesse ma forse perchè qualcuno sbaglia a promuovere i nostri film all’estero“.
Ci chiediamo se non sia anche un problema di regolamentazione. Altri, sempre nel contesto del festival del cinema italiano ci hanno esposto lamentele, non particolarmente originali, sull’inefficienza del sostegno delle istituzioni all’arte cinematografica e soprattutto alla sua diffusione. “Io sono contro le lamentele” taglia corto, “hanno appena passato una legge, da poco, che dovrebbe riordinare un po’ le cose, ora stiamo a vedere. Io sono contro il lamento, la mia filosofia è quella di capire cosa anche in noi cineasti non funziona”.
Poi il discorso verte abbastanza velocemente sul tema delle relazioni tra donne e uomini nella nostra società. “Al cinema le donne si sono avvicinate molto tardi, perché è un lavoro di comando, è sempre stato un lavoro maschile”.
Traccia poi un parallelo con la letteratura, l’altra sua grande passione. Cristina Comencini infatti è anche scrittrice, l’ultimo suo libro è Essere vivi e poi è anche autrice di teatro alcune di esse da lei stessa trasposte sul grande schermo. “In letteratura le donne hanno iniziato ad essere presenti già nell’Ottocento. Nel cinema dobbiamo ancora fare questo lavoro. D’altronde la storia delle donne è una storia millenaria. È una trasformazione epocale, è la prima volta nella storia.”
Il tema è affrontato nell’opera di Cristina Comencini, anche nel film proiettato quella sera stessa. La questione di genere però non è un semplice oggetto da spulciare, ma parlando con l’autrice, emerge in maniera chiara che si tratti di qualcosa di più. Come una cornice generale che permette e pervade il suo lavoro, non come semplice scelta: “Il cinema rispecchia la società e quando nella società le donne riprendono la scena, aumentano anche i film girati da donne. Ma non è che le donne debbano affrontare solo questioni ‘da donne’. Io penso che lo sguardo femminile sia su tutto”.
Ne ha anche per gli uomini, soggetti evaporati – come si sente dire a volte – un po’ come il Latin Lover del film, morto e idealizzato che da “fantasma” continua a condizionare le vite dei suoi amori e delle figlie tramite un’immagine di cui egli stesso è in parte imprigionato. Un film la cui lettura più volte, anche dopo la proiezione, la regista identifica e rimanda alla rappresentazione e all’omaggio al grande cinema italiano del passato, ma che si presta facilmente per essere letto come uno smascheramento della figura classica del latin lover.
“Io credo che siamo arrivati ad un punto in cui le donne non possono più andare avanti da sole. Siamo ad un punto in cui non c’è avanzamento se non con gli uomini. Gli uomini devono fare un lavoro su di sé che ancora non è cominciato. Gli uomini dicono che son solidali con le donne ma è come se non volessero vedersi”. L’idea è che le donne che sempre di più acquisiscono sicurezza e potere non solo impauriscono l’uomo ma ne scatenano la reazione.
Ma le cose stanno cambiando: “Avanza lentamente una cosa gigantesca e ci vuole del tempo. E non si torna indietro mai” ci dice. Riporta un ricordo di uno dei fratelli Taviani, “Una volta durante un dibattito uno dei fratelli Taviani mi disse: “Cristina la verità è che un po’ di sangue deve scorrere” cioè le cose cambiano ma non possono farlo morbidamente”. Ci vorrà del tempo.
Alessandro Grassi
Uno scrittore è un po’ come l’E.T. del film di Steven Spielberg. Quando deve costruire una ricetrasmittente improvvisata per ricollegarsi con i confratelli va in un ripostiglio e assembla creativamente quel che trova: un ombrello, una lampada a piede, dei piatti, un giradischi. Un romanzo si può costruire in un modo analogo, con uno stock di buon ciarpame. La qualità degli ingredienti non è molto importante, quel che conta è avere accumulato un gruzzolo di dettagli concreti e peculiari, quelli che attirano la nostra attenzione, tanto meglio se inspiegabili. Occorre collezionare questi frammenti, metterci un’etichetta e chiuderli in un’apposita cassettiera mentale, da dove la memoria si incarica di ricuperarli e utilizzarli al momento giusto. Ad animarli penserà la magia, quella non può mancare. “Si possono utilizzare rozzi materiali d’uso quotidiano, semplici parole disadorne, ma se c’è la magia, riusciamo a creare un apparecchio sorprendentemente raffinato”, o almeno efficace.
Così parlò Murakami Haruki, il più occidentale e il più tradotto dei narratori giapponesi, l’autore di Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia e 1Q84, best-seller mondiale e oggetto di culto (molti suoi adepti dichiarano di adorarlo anche se non sanno spiegare perché, ma a lui va benissimo così, tenendo in sovrano disdegno la critica togata, che talvolta è arrivata a dargli del venditore di fumo). La notizia è che uno scrittore ombroso e riservato, che non ama la socialità e fa di tutto per non apparire, che rifiuta festival e sedute di firma-copie, vive autorecluso e si rallegra quando al ristorante non solo non lo riconoscono ma gli danno anche il tavolo peggiore, si sia deciso a parlare di sé, con abbondanza di dettagli autobiografici, e addirittura del Mestiere di scrittore, come suona il titolo del volume ora tradotto in italiano da Antonietta Pastore per Einaudi (pp.190, euro 18,00). Dove più che di letteratura e di tecniche narrative si finisce per parlare di precetti per vivere in sano equilibrio tra corpo e mente. Perché l’E.T. nipponico è un maratoneta convinto e praticante (ne ha corse a decine), un cultore di triathlon, uno che tutti i giorni corre o nuota per almeno un’ora. Scrivere, dice, è un pratica lenta e faticosa, che richiede pazienza, determinazione, energia, come qualsiasi altro lavoro usurante. La buona condizione fisica è indispensabile alla forza morale e spirituale, quella che ti fa superare i dubbi, le critiche feroci, gli insuccessi, gli amici che ti voltano le spalle. Kafka, anche se morto a quarant’anni di tisi, era vegetariano, nuotava ogni giorno nella Moldava per un miglio e faceva lunghe sedute di ginnastica. (Ma come faceva il povero Proust, tormentato dall’asma?).
Le scuole di scrittura si moltiplicano (numerosi i giovani scrittori che, arrivati al secondo libro, si sentono autorizzati all’insegnamento), continuano a uscire volumi che dispensano buoni consigli sul “come si fa”. Ancora recentemente sono state edite, con tanto di annesso cd audio, le classiche, insuperabili lezioni di Peppo Pontiggia, in cui il gran lombardo dispensa amabilmente il suo sapere (Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere, Belleville editore, pp. 320, euro 21,00). Guido Conti è ricorso al magistero dei classici. In Imparare a scrivere con i grandi antologizza i big per dimostrare come si affrontano i problemi legati agli incipit, alla trama, a stile e forma, montaggio e ritmo, colpi di scena e generi, da Puskin e Cechov a Jack London e a Carver (Bur, pp. 550, euro 15,00).
Murakami batte tutt’altre strade. Stile, forma, scrittura non gli interessano più che tanto. Sembra accentrare la sua attenzione su tutto quello che precede l’atto dello scrivere, sulle condizioni esistenziali che fanno scattare la scintilla. Per lui scrivere romanzi non richiede un’intelligenza superiore, solo un livello minimo di talento, istruzione, e conoscenze. E la pazienza che ci vuole per costruire navi in bottiglia. Un lavoro non poi molto dissimile da altri che si compiono ripetitivamente nel chiuso di una stanza, giorno dopo giorno. Tutto il contrario dell’immagine romantica dell’artista maledetto, bohémien, incline alle droghe, gran bevitore e donnaiolo, che finisce per autodistruggersi. Il suo ideale è il metodico Anthony Trollope, lo scrittore inglese dell’Ottocento che lavorava alle Poste e continuò a farlo anche dopo il successo, inventando la famosa cassetta rossa per imbucare la corrispondenza. Ma anche Kafka, scrupoloso impiegato delle Assicurazioni Generali, ramo infortuni sul lavoro, apprezzato dai colleghi per il suo puntiglio. Lo diceva già Flaubert: “Siate borghesi nella vita per essere rivoluzionari nell’arte”.
Al romanzo Murakami arriva sui trent’anni. Prima si è sposato, e a prezzo di pesanti sacrifici ha aperto un locale a Tokyo dove faceva ascoltare musica jazz e serviva caffè e alcolici. Un giorno porta da casa un vecchio piano verticale che suonava da ragazzo e nei weekend fa un po’ di musica live. Sin da piccolo adorava la lettura, dai classici russi agli hard boiled americani. Poi nel 1978 durante una partita di baseball una sorta di folgorazione. Una voce interiore gli annuncia di avere accumulato le energie interne necessarie per cominciare a scrivere. In un’altra occasione, ha anche detto di essere stato ispirato dalla pallina di un flipper, dai suoi scatti imprevedibili, emblema delle traiettorie capricciose che incrociano i destini degli uomini. Palla da baseball o flipper che sia, si attacca a una vecchia Olivetti e comincia a darci dentro. Portare a termine il primo romanzo breve, Ascolta la canzone del vento, è stata una fatica improba, confessa. Nessuna idea di come scriverlo, nessun indirizzo programmatico. Semplicemente un procedere per tentativi, un “raccontare le cose come le sentivo, come le avevo nella testa, liberamente, come più mi piaceva”
Incomincia a scrivere in inglese, che non padroneggia nemmeno tanto bene, perché vuole esprimersi in un linguaggio essenziale, togliendo tutto il grasso superfluo. Capisce la cosa fondamentale: bisogna trovare il ritmo giusto, congeniale, quello che definisce uno stile personale: “una narrazione che vada dritta al punto senza divagazioni, con descrizioni precise ma non contemplative”.
Scrivere rientra allora qualcosa di assai vicino al fare musica: “Mantenere il ritmo, trovare begli accordi, credere nella forza dell’improvvisazione” . Trovare l’originalità che si impone, quella stessa che aveva colpito lui ragazzo ascoltando per la prima volta Please please me dei Beatles o Surfin’ USA dei Beach Boys, e sapendo che si può non essere accettati subito, basti pensare allo sconcerto che nel 1913 accolse La sagra della primavera di Stravinskij o alle stroncature della musica di Mahler, definita “triste, brutta, incompleta e circonvoluta”.
Come arrivare all’originalità? Bisogna soddisfare alcuni criteri di base. Prima cosa, distinguersi dagli altri ed elaborare uno stile unico e immediatamente riconoscibile. Secondo punto, migliorare quello stile, farlo evolvere, non accontentarsi dei risultati raggiunti. Terzo, con il passare del tempo diventare fonte d’ispirazione per le generazioni che seguono. Come diceva il poeta polacco Zbigniew Herbert, “per arrivare alla sorgente bisogna nuotare risalendo la corrente. A scendere galleggiando sull’acqua è solo la spazzatura”. Conseguentemente, Murakami rigetta le tradizionali categorie di avanguardia o retroguardia, destra o sinistra, letteratura pura o di intrattenimento. Uscito dalla generazione delle rivolte studentesche fine anni 60 ha sviluppato una forte avversione al sistema, da cui si è sempre chiamato fuori.
Come diceva Thelonius Monk, non potendo piacere a tutti, meglio piacere a se stessi, almeno uno si diverte. Più che sul divertimento, Murakami sembra però insistere sulla fatica operaia che la scrittura comporta. Per arrivare a configurare uno stile riconoscibile occorre procedere per sottrazione, fare piazza pulita dei troppi carichi, perché la sovrabbondanza di contenuti finisce per provocare ingorghi. Capire cosa è necessario e cosa non lo è, per lui è facile: bisogna provare piacere, una sorta di allegria naturale e spontanea, l’impulso a trasmettere a un gran numero di persone un sentimento di libertà, una gioia che non conosce restrizioni. Se questa eccitazione virtuosa non si produce, meglio tornare al punto di partenza e ripensare tutto. La domanda da farsi non è “Che cosa sto cercando?”, quanto piuttosto: “Prima di cercare qualcosa, come sono fatto io?”. La scrittura può e deve diventare autoanalisi per essere in grado di trasmettere al lettore l’emozione primigenia, lo stupore e la grata meraviglia con la quale accogliamo le opere che cambiano la nostra percezione del mondo.
Torna l’idea pirandelliana dei personaggi che, una volta creati, se ne vanno poi per conto loro e fanno quello che vogliono. Torna l’idea dello scrittore sciamano, che si lascia attraversare da flussi di sensazioni e di immagini che sgorgano dalle profondità dell’inconscio e riproducono il flusso ingovernabile dell’esistenza. La porta tra mondo reale e mondo fantastico è sempre aperta, e Murakami la attraversa quando vuole, in sovrana libertà. L’onirico e il surreale dei mondi alternativi si nutrono di dettagli realistici anche minimi, creando quei cortocircuiti mentali che sconcertano e affascinano i suoi lettori: si sentono sempre sul punto di risolvere il mistero, e ne rimangono ogni volta esclusi. Ma l’avrà contata giusta, il maratoneta maniaco-depressivo (parole sue) giustamente restio a parlare di sé, perché sono sempre le opere che devono dire quel che c’è da dire? Non è che questi precetti a metà tra il fitness e le illuminazioni iniziatiche sono un modo, molto gentile e molto giapponese, per depistarci e difendere ancor meglio il proprio diritto alla privacy? Diavolo d’un uomo ordinato, controllato e metodico, non lo sapremo mai.
Articolo di Ernesto Ferrero per “Sette/Corriere della sera”, 24 febbraio 2017
Haruki Murakami è stato tradotto in circa cinquanta lingue e i suoi best seller hanno venduto milioni di copie. Le sue opere di narrativa si sono guadagnate il consenso della critica e numerosi premi, sia in Giappone che a livello internazionale, come il premio World Fantasy (2006), il Frank O'Connor International Short Story Award (2006), il Premio Franz Kafka (2006) e il Jerusalem Prize (2009). Fra i suoi titoli più celebri si ricordano Nel segno della pecora (1982), Norwegian Wood (1987), L'uccello che girava le viti del mondo (1994-1995), Kafka sulla spiaggia (2002) e 1Q84 (2009–2010). da wikipedia.org
MATILDE
Matilde è una bimba non udente, vispa ed intelligente, ma a scuola sembra che qualcosa la turbi. Lei però non si perde d’animo e con le forbici della mamma e delle palline da tennis, trova una soluzione geniale per i suoi problemi…
Con la delicatezza e la dolcezza che gli sono congeniali, Vito Palmieri indaga ancora una volta le dinamiche infantili entrando nel mondo di Matilde, una bimba sorda dalle mille risorse. Grazie ad un uso magistrale di fotografia, montaggio e musiche (cui d’altronde il regista ci ha abituati già nei lavori precedenti), si resta affascinati dalla storia e dai modi di fare della piccola protagonista, straordinariamente interpretata dalla giovanissima Matilde De Silva.
LE DOMANDE AL REGISTA
Ciao Vito, bentornato su cinemio. Iniziamo dal tema del corto di cui sei autore del soggetto e della sceneggiatura. Come sei arrivato a questa idea?
E’ stata l’Agfa/Fiadda a chiedermi di realizzarlo. Volevano un corto per i non udenti interpretato da persone sorde. Nei miei lavori ho spesso raccontato storie di bambini. Rappresentare il quotidiano di una bambina sorda, però, è stata un’esperienza nuova. Inizialmente avevo qualche perplessità. Non sapevo se avrei trovato il linguaggio appropriato per raccontare questa vicenda legata alla sordità. Poi ho trovato la chiave giusta dalle storie dei membri dell’Agfa. In primis dal padre di Matilde che mi ha raccontato un episodio sulle palline da tennis che mi ha colpito e che ho voluto inserito nel corto.
Un altro ragazzo sordo mi ha raccontato che da bambino aveva chiesto al maestro di tagliarsi i baffi perché non riusciva a capire ciò che diceva. Nei giorni in cui abbiamo sviluppato l’idea del corto ho anche frequentato il Senza nome, un bar di Bologna aperto da poco, gestito e frequentato da sordi. Lì ho avuto modo di conoscere molti ragazzi che mi hanno raccontato le loro esperienze sin dai banchi di scuola e a cui mi sono ispirato per altri dettagli del film.
Alla fine del corto tieni a precisare che tutti gli attori protagonisti e non che hanno recitato sono sordi. Immagino sia stata una novità per te. Com’è andata?
Sotto consiglio dell’Agfa, ho scelto di lavorare esclusivamente con attori sordi per testimoniare che anche loro possono interpretare un film. L’Agfa mi ha anche chiesto che il film venisse sempre distribuito con i sottotitoli in italiano o nella lingua del paese in cui verrà proiettato. “Matilde” è un film fatto per i non udenti. Ho voluto inserire una scena in cui anche gli spettatori udenti sono obbligati a leggere il labiale perché non sentono le battute dei personaggi, in quanto la scena si svolge in un interno mentre la macchina da presa è posizionata al di là di un vetro e dunque in esterno.
La piccola Matilde de silva, protagonista del corto, è veramente molto brava. Come l’hai scelta?
Riguardo la scelta della protagonista, non ho dovuto fare dei casting. Quando mi hanno suggerito di scegliere Matilde, che è il vero nome della bambina che recita, sono andato nella sua classe. Tra tutti i ragazzi spiccava il suo sguardo acuto e il taglio degli occhi. Non avevo dubbi riguardo alla scelta. Matilde era perfetta.
Nella tua filmografia i bambini ed i ragazzi la fanno da padrone. Come mai questa voglia di raccontare il loro mondo?
Tutto è nato grazie a Tana libera tutti dove ho raccontato il mondo dell’infanzia, poi ho insegnato nelle scuole medie e molti soggetti li ho scritti con i miei stessi alunni. Poi ho capito che il percorso che stavo seguendo era quello giusto, anche perché in qualche modo mi è stato confermato dalle selezione al festival di Berlino proprio nella sezione Generation, dove selezionano film rivolti o interpretati da bambini.
Non ho potuto non notare la collaborazione, alla sceneggiatura e alla regia, di Francesco Niccolai, regista che è stato anche ospite di questa rubrica. Vuoi parlarci del tuo rapporto con lui e di com’è andata la collaborazione durante la preparazione del corto?
Francesco Niccolai l’ho conosciuto a Bologna, la nostra collaborazione è iniziata nel 2009, dove mi ha aiutato per la realizzazione del mio documentario Il valzer dello zecchino, poi abbiamo scritto insieme un corto tributo a Lucio Dalla Anna bello sguardo e subito dopo abbiamo scritto Matilde. Sul corto Matilde è stato anche assistente alla regia, quindi ha seguito molto anche il lavoro della piccola prtagonista sul set.
Il tuo corto ha partecipato e continua a farlo, a numerosi festival nazionali ed internazionali ed ha già vinto al Riff ed al festival del cinema europeo. Qual è la tua impressione a riguardo? c’è un complimento che più di altri ti è rimasto nel cuore?
C’è da dire che è stato tutto inaspettato. Il corto è nato come un progetto molto semplice e non pensavo avesse questo tipo di distribuzione e attenzione in vari Festival stranieri e Italiani. Spero continui così. Ogni motivazione di una giuria mi conferma che siamo riusciti a fare un buon lavoro e di conseguenza li considero dei bei complimenti.
Ed ora uno sguardo al futuro. Mentre Matilde prosegue il suo percorso vittorioso tra festival stai già pensando ad un nuovo progetto? magari un lungometraggio che vede protagonisti i ragazzi…
Ho scritto un soggetto per un film e spero di avere la possibilità di realizzarlo, soprattutto dopo questa partecipazione al Festival di Berlino e i vari premi che sta ricevendo il mio corto. Posso solo dire che segue il mio percorso registico e avrà come protagonisti i bambini.
Ringrazio Vito Palmieri per la disponibilità e lo saluto in attesa di conoscere novità riguardo questo suo nuovo interessante progetto.
Come raggiungere la perfezione cinematografica? Ce lo svela Wim Wenders, protagonista del nuovo spot pubblicitario di Stella Artois, celebre marca di birre dalla provenienza belga. Il cineasta, autore di pellicole rinomate come Il cielo sopra Berlino (1987), Paris, Texas (1984) e Lampi sull'acqua – Nick's movie (1980) spiega agli spettatori ed aspiranti registi come riuscire a fare un film impeccabile. Ecco i punti salienti del suo discorso:
 - Come prima cosa, dovete trovare un bel titolo.
- Come prima cosa, dovete trovare un bel titolo.
- Secondo, ricordatevi che la continuity è sopravvalutata. D'altronde, basti vedere proprio Il cielo sopra Berlino e il suo evadere le convenzioni narrative più tradizionali.
- Rispettate gli attori: il loro lavoro è 10 volte più pericoloso del vostro.
- Non innamoratevi dell'attrice protagonista.
- Evitate di lavorare con degli animali. Non fanno mai ciò che volete facciano.
- Non quotate altri film. Non raccontate storie che altri potrebbero raccontare meglio. Non girate un Western se non vi piacciono i cavalli.
- Tenete in mente che anche le altre persone potrebbero avere buone idee. Forse.
- Aspettate sempre altri 5 secondi prima di dare lo stop. Non si sa mai.
- Infine, la regola più importante di tutte: non esistono regole.
Ovviamente, trattandosi di uno spot pubblicitario per una birra, l'atmosfera è quella rilassata e ludica dell'ironia. Wenders, come un sofisticato lord, si trova in una sala cinematografica vuota, tra momenti di giocosità e divertimento. È comunque bello vedere un autore così rinomato e rispettato partecipare alla pubblicità di un prodotto mainstream come la Stella Artois.
Attualmente, il cineasta è impegnato nella post-produzione della sua ultima pellicola, Every Thing Will Be Fine, che racconterà le vicende di un uomo che investe accidentalmente un povero bambino. Nel cast, nomi celebri come James Franco, Rachel McAdams e Charlotte Gainsbourg. Era invece a Cannes The Salt of The Earth, documentario biografico che l'autore ha dedicato al fotografo errante Sebastião Salgado, che negli ultimi decenni ha viaggiato per i continenti catturando alcuni eventi storici come guerre e conflitti internazionali. Inoltre, ha immortalato con la sua macchina fotografica alcuni dei paesaggi più belli e nascosti del mondo, inoltrandosi nella fauna più selvaggia.
Articolo da farefilm.it
«Sono felicissimo di essere ad Assisi i primi di dicembre, di rivedere i miei film con il pubblico, con gli studiosi di cinema». Così, in un video messaggio diffuso in queste ore sui social network, Giuseppe Tornatore ha annunciato la sua partecipazione alla XXXIII edizione di Primo Piano sull’Autore, la rassegna del Cinema Italiano che si terrà ad Assisi dal 1 al 6 dicembre e che quest’anno, con il titolo Giuseppe Tornatore. Cinema, passione, sogno, è dedicata alla carriera del vincitore del premio Oscar con Nuovo cinema Paradiso.
Ogni anno la Rassegna (diretta da Franco Mariotti e promossa dall’associazione culturale Amarcord in collaborazione con il Comune di Assisi e il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema ) è dedicata alla rilettura dell'opera di un protagonista che ha segnato la cultura italiana ed internazionale. In questi anni ad Assisi si sono avvicendati Carlo Lizzani, Ermanno Olmi, Dino Risi, Alberto Lattuada, Pietro Germi, Michelangelo Antonioni, Lina Wertmuller, Luigi Comencini, Gillo Pontecorvo, Damiano Damiani, Mauro Bolognini, Carlo Di Carlo, Mario Monicelli, Alberto Sordi, Bernardo Bertolucci, Luigi Magni, Giuliano Montaldo, Franco Zeffirelli, Carlo Verdone, Michele Placido, le famiglie Vanzina e Gassman, Giancarlo Giannini, Aurelio De Laurentiis, Bud Spencer & Terence Hill, Francesco Rosi, Pupi Avati, Enrico Lucherini, Lino Banfi, Gina Lollobrigida e Neri Parenti.
«Ricevere tale riguardo - ha aggiunto Tornatore - tale onorificenza mi dà un senso di grande ansia, di grande responsabilità perché, innanzitutto, mi dà la sensazione che il tempo voli via troppo rapidamente, ma nello stesso tempo mi dà un senso di grande responsabilità. Mi chiedo se dopo nomi di cineasti così importanti come quelli che già sono stati oggetto di studio nelle edizioni precedenti di Primo Piano sull'Autore ad Assisi, sia all'altezza del compito e se quello che ho fatto è meritevole di tale attenzione».
Nato a Bagheria il 27 maggio 1956, Tornatore debutta alla regista nel 1986 con Il camorrista (Nastro d’argento per il miglior esordio). Dopo Nuovo cinema Paradiso, nel 1990 gira Stanno tutti bene, con Marcello Mastroianni. Del 1994 è Una pura formalità. Nel 1995 firma L'uomo delle stelle, che vince il David di Donatello, il Nastro d'Argento e il Gran Premio della Giuria a Venezia. Nel 1999, con La leggenda del pianista sull’oceano, vince David, Efebo d'oro, Ciak d'Oro e 2 Nastri d'Argento. Dopo Malèna (2000), torna sul grande schermo nel 2006 con La sconosciuta, che vince 3 David di Donatello e viene scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar. Nel 2009 firma Baarìa. Il suo ultimo film è La migliore offerta (2013).
Il programma di Primo Piano sull’Autore prevede la proiezione, al cinema Metastasio di Assisi, di tutti i film di Tornatore e una tre giorni di studi con il regista, che incontrerà gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia (4 dicembre) e quelli delle scuole superiori del comprensorio di Assisi (5 dicembre). Il 5 dicembre, Tornatore incontrerà il pubblico al cinema Zenit di Perugia, dopo la proiezione di un suo film. Lo stesso regista sarà il protagonista del convegno del 6 dicembre ad Assisi con storici e critici del cinema e con attori, attrici, produttori e sceneggiatori che hanno collaborato con lui.
Anche quest’anno Primo Piano sull’Autore ospiterà la sezione collaterale Dove va il cinema italiano? Oltre la commedia, le nuove proposte, che analizza i nuovi generi del nostro cinema, con proiezioni di film di recente produzione, in contemporanea con l’uscita in sala ma anche vere anteprime sul territorio assisano.
La Rassegna si chiuderà la sera del 6 dicembre con la consegna della Targa onorifica di Assisi a Tornatore e con l’assegnazione dei premi della XXIII edizione del Domenico Meccoli - ScriverediCinema, dedicati a quanti si sono distinti, nel 2014, nella scrittura e nella promozione del cinema attraverso i media.
La musica nel film. Parallela all'immagine che racconta, una linea musicale che scorre, a sottolineare e a commentare. Naturalmente non ci si fa caso, non si entra in un cinema per ascoltare la colonna sonora del film. In un certo senso la si subisce, quasi a nostra insaputa.
COLONNA SONORA Viaggio attraverso la musica del cinema italiano
Un programma di Glauco Pellegrini - presentato da Giulietta Masina - consulenza musicale: Guido M. Gatti - r., s., sc.: Glauco Pellegrini - f.: Sandro Messina - coll. al mo.: Jolanda Benvenuti - organizzatore. Luigi Alessandrini - assistente alla r.: Laura Rossi Guerra - p.: RAI-Radiotelevisione italiana. (Sei trasmissioni di un'ora e dieci minuti ciascuna con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI diretta da Armando La Rosa Parodi, dell'Orchestra di musica leggera diretta da Piero Umiliani e dei critici Luigi Chiarini, Filippo Sacchi, Vinicio Marinucci, Mario Verdone, Gino Visentini).
Per gentile concessione della RAI-TV pubblichiamo integralmente i testi del programma televisivo Colonna Sonora, che ha avuto il merito di accostare ad un vasto pubblico, in forma di intelligente divulgazione, i problemi ed i valori della colonna sonora ed in particolare della musica nel film, costituendo un utile esempio di come il mezzo televisivo possa venire impiegato anche a fini di formazione di ampi strati di spettatori nei confronti del cinema.
Prendono parte alla trasmissione:
PRIMA PUNTATA: Luigi Chiarini, Alberto Lattuada, Gian Francesco Malipiero, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Nino Rota.
SECONDA PUNTATA: Mario Camerini, Mario Soldati, Filippo Sacchi, Alberto Lattuada.
TERZA PUNTATA: Renzo Rossellini, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis, Goffredo Petrassi, Vinicio Marinucci, Giovanni Fusco.
QUARTA PUNTATA: Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Alessandro Cicognini, Ugo Tognazzi, Franco Cristaldi, Carlo Rustichelli, Mario Verdone.
QUINTA PUNTATA: Francesco Rosi, Piero Piccioni, Gino Visentini, Roman Vlad, Valerio Zurlini, Mario Nascimbene, Moris Ergas, Carlo Rustichelli.
SESTA PUNTATA: Angelo Francesco Lavagnino, Sandra Milo, Mario Soldati, Federico Fellini, Nino Rota, Luigi Chiarini.
In sintesi, la trasmissione vuole raccontare la storia del cinema italiano attraverso i commenti musicali. Dai tempi del muto, in cui una orchestrina accompagna le immagini in movimento eseguendo brani musicali di vario genere, alle canzoni più famose apparse nei primi film italiani, alla influenza del melodramma ottocentesco, agli esempi di utilizzazione di musica classica, fino ad un ampio discorso sul presente: questo è il tema della prima puntata, dove è illustrato il contributo di tre importanti compositori cinematografici degli anni trenta: Antonio Veretti, Giorgio Federigo Ghedini, Gian Francesco Malipiero.
La puntata successiva esamina i rapporti fra musica e letteratura. E quindi i film italiani tratti da opere di Manzoni, Bacchelli, Fogazzaro, Pugkin, D'Annunzio, Gogol, con musiche di Ildebrando Pizzetti, Enzo Masetti, Vincenzo Tommasini, Giuseppe Rosati, Felice Lattuada.
La terza puntata è dedicata al neorealismo e presenta l'opera di quattro musicisti: Renzo Rossellini, Goffredo Petrassi, Gino Gorini e Giovanni Fusco.
La quarta, sempre nel quadro del neorealismo, si volge alla commedia: con i commenti di Alessandro Cicognini, il jazz di Piero Umiliani, Armando Trovajoli e Teo Usuelli, e le partiture di Mario Zafred e di Carlo Rustichelli, quest'ultimo particolarmente legato ai film di Pietro Germi.
La quinta puntata ha per tema i film sulla violenza: e illustra i contributi di Piero Piccioni, Roman Vlad, Mario Nascimbene, ancora Rustichelli.
La sesta è dedicata al documentario di lungometraggio, con le musiche di Angelo Francesco Lavagnino, e alla collaborazione di Nino Rota con Federico Fellini.
Si riportano, di seguito, i testi dei vari interventi.
PRIMA PUNTATA
GIULIETTA MASINA (presentatrice): La musica nel film. Parallela all'immagine che racconta, una linea musicale che scorre, a sottolineare e a commentare. Naturalmente non ci si fa caso, non si entra in un cinema per ascoltare la colonna sonora del film. In un certo senso la si subisce, quasi a nostra insaputa.
Eppure, anche se non ce ne accorgiamo, è certo che noi restiamo più profondamente suggestionati dalle immagini, proprio per la presenza del commento musicale. Un complemento: capace però di caricare dí espressività la stessa immagine.
Vogliamo provare, una volta, ad ascoltare i film oltre che a vederli? È quanto ci propone Colonna sonora.
Rivedremo insieme sequenze tratte da oltre cinquanta film, sequenze che riesamineremo interessati soprattutto alla loro colonna sonora. Panorama musicale di quarant'anni di cinema italiano. Visione antologica, forse inevitabilmente incompleta: ma che ha il proposito di tracciare una storia, una linea logica dell'evolversi del commento musicale, perché anche la musica ha la sua importante pagine nella storia del cinema. Ricordate High Noon (Mezzogiorno di fuoco), The Third Man (Il terzo uomo), Sous les toits de Paris (Sotto i tetti di Parigi), Lime-light (Luci della ribalta), The Man with the Golden Harm (L'uomo dal braccio d'oro), Exodus: grandi film, ma anche grandi commenti musicali.
LUIGI CHIARINI: Questa Colonna sonora dedicata al cinema italiano comincia con esempi stranieri, e c'è una ragione: perché il problema della musica nel film è problema che ha un più vasto ambito internazionale.
L'esempio che abbiamo visto è tratto dal film Aleksandr Nevskij di Ejzengtein, musicato da Prokoviev. Si tratta della «battaglia sul ghiaccio»; la battaglia sul ghiaccio che segna l'acme del film, ma anche l'acme della colonna sonora, anche l'acme della musica. Ejzengtein e Prokoviev hanno in fondo risolto tutti i problemi che si sono poi posti sotto questo riguardo; e hanno risolto questi problemi perché hanno considerato il film come un'opera unitaria.
Non ci sono stati nella loro collaborazione né un sopraffattore né un sopraffatto; tant'è vero che alcune parti sono state prima composte e poi il montaggio del film, delle immagini, è stato fatto sulla musica già incisa, registrata. In altre parti invece la musica è stata realizzata, scritta da Prokoviev sui pezzi già montati di cinema, di film. Prokoviev era al suo primo film, eppure Ejzengtein diceva che Prokoviev era un musicista cinematografico. Perché un musicista cinematografico? Perché, diceva Ejzengtein, Prokoviev dà l'interiorità delle cose e non l'esteriorità delle cose. Ed è proprio di questa interiorità delle cose che il cinema ha bisogno; e l'immagine realistica cinematografica ha bisogno della musica in modo che si integri in una immagine unica che dà interno ed esterno.
Vedrete, per esempio, nel film Rashomon, il bandito sdraiato che medita l'uccisione del Samurai; e la musica ... la musica dà i suoi pensieri.
Così come nel film Lost Week-end (Giorni perduti), un film sul-l'alcoolismo, la musica dà il disgregamento della personalità dell'alco-lizzato. Le immagini dànno quello che lui vede: i pipistrelli, i topi ecc., ma la musica il suo disfacimento interiore.
Questa collaborazione tra persone di talento è mostrata anche nel film di Pabst e Honnegger Mademoiselle Docteur (Salonicco nido di spie) in cui un grande regista e un grande musicista hanno creato un'opera che ha la sua unità.
Certo, problemi di rapporti tra musicista e regista, tra il realismo di un'immagine cinematografica e l'astrazione di quella musicale, sí sono sempre posti; ma direi che sono i problemi che si pongono i cattivi musicisti e i cattivi registi. D'altra parte è anche vero che solo nel film artistico non si parla più di musica di commento, di musica illustrativa, oppure di musica di «ammobiliamento» come dicono i francesi, cioè quella musica che serve a riempire í vuoti della colonna sonora. Su questo problema della musica da film, secondo me, non ci sono regole; ed è per questo che questa trasmissione dà degli esempi, che sono quelli che contano.
ALBERTO LATTUADA: Il « bajon » del film Anna ha avuto nel film una funzione proprio peculiare: si trattava di descrivere la dissociazione di un carattere. Una ragazza aveva in sé i germi del male e del bene. Era, prima, ragazza che lavorava in un «night-club», poi la vediamo suora.
Il «bajon» è stato inventato non per dare un godimento, per così dire, «ritmico» al pubblico, ma proprio per sottolineare, diciamo, la parte demoniaca, istintiva, violenta di questo carattere, in contrasto con l'altra, che, dopo un certo dramma che la storia raccontava, la votava per sempre al sacrificio e la chiudeva per sempre nella sua funzione di servire l'umanità come suora.
GIAN FRANCESCO MALIPIERO: Il mio amico Cecchi chiamò Pirandello, prima di me, per fare il soggetto di Acciaio, poi Ruttmann per la parte visiva, diremo, e la musica l'affidò a me.
Io non avevo mai fatto film, e sono andato come un condannato a morte: vediamo che cosa succede!
E difatti successe che io scrissi la musica per conto mio, e gli altri fecero il film per conto loro. Non andavamo d'accordo, con vari incidenti che finirono piuttosto male per la musica. A mio parere, fu tutto sbagliato. Bisognava prima fare il film, poi cronometrarlo, e poi fare la musica sopra il testo.
Precisato questo particolare che mi sembra essenziale, io ho fatto questa musica. Chi l'ascolta, la sente e chi non ha avuto la fortuna di ascoltarla, non la sente. Più di questo non saprei dire. Vi furono vari incidenti, durante la realizzazione, che generarono malcontento. È per questo che la musica sta per conto suo, e il film fa altrettanto. Non so che sorte abbia avuto il film. Non lo ricordo, dopo tanti anni, e con la guerra in mezzo: perciò non saprei cosa dire di più. Che il film sia piaciuto come «macchine» sì, come «storia» no. Non era come l'aveva voluto Pirandello, perché Pirandello aveva pensato tutta un'altra cosa. Ruttmann fece in questa produzione il despota: giudicherete voi che risultato ha ottenuto; perché, sì, ... le «macchine» erano belle, ma non trovo che si possa fare tutto con le «macchine». Ci vuole un po' più di umanità.
PIER PAOLO PASOLINI: In Accattone ho voluto rappresentare la degradazione e l'umile condizione umana di un personaggio che vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma. Io sentivo, sapevo, che dentro questa degradazione c'era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in senso vago e generale della parola, e allora questo aggettivo, «sacro», l'ho aggiunto con la musica. Ho detto, cioè, che la degradazione di Accattone è, sì, una degradazione, ma una degradazione in qualche modo sacra, e Bach mi è servito a far capire ai vasti pubblici queste mie intenzioni.
FEDERICO FELLINI-NINO ROTA.
FELLINI: E qui siamo alla solita storia della «marcetta dei gladiatori». La faccenda sta così: che io sono stato molto tentato, francamente, di lasciare questo motivo nel film perché mi sembrava proprio il più immediatamente evocativo; quindi ho girato con questa marcetta di colore, che è la marcetta del circo. Però, nello stesso tempo, non vorrei che questa evocazione fosse così realisticamente evocativa, cioè che richiamasse esattamente il circo. Come, nel fotografico, ho tentato di fare una specie di ricordo del circo, come può immaginarselo un bambino, qui ci vorrebbe, e tu solo, Nino, puoi farlo, una musica che rievocasse l'atmosfera del circo, che rievocasse la « marcetta dei gladiatori», ma fosse completamente diversa: cioè un ricordo della «marcetta dei gladiatori». Mi rendo conto che è un discorso un po' confuso e anche un pochino difficile, però, proprio per seguire questa operazione che credo sia abbastanza riuscita nel figurativo, si potrebbe fare la stessa cosa sulla colonna sonora: cioè dare il profumo della musica del circo a questa parte di Giulietta degli spiriti ...
ROTA: Posso tentare: per esempio, un valzerino ... ma si può vedere se con un altro ritmo viene fuori una cosa più adatta ...
FELLINI: Soprattutto più «fracassona». L'attacco deve essere proprio così, a chic, estremamente violento e «fracassone» come la musica del circo. Un tipo di sonorità estremamente vistosa, ma che nello stesso tempo possa prestarsi poi ad essere attenuata senza perdere di violenza, perché poi, sotto, ci va il dialogo ... Come faresti? come fa il valzerino?
ROTA: Il valzerino fa così ... (eseguisce al piano). L'atmosfera è sempre quella del music-hall. Basta fare ...
FELLINI: Un attacco violento, questo attacco sulla ballerina che va indietro con l'altalena ...
ROTA: Ecco ... te lo posso far sentire al piano ...
da COLONNA SONORA Viaggio attraverso la musica del cinema italiano di Glauco Pellegrini
in BIANCO E NERO Rassegna mensile di studi cinematografici e televisivi
Centro Sperimentale di Cinematografia - Anno XXVIII - Numero 3-4 Marzo-Aprile 1967
 "La macchinetta in cui inserisci la moneta e viene fuori il costume non l'hanno ancora inventata". Con una battuta di spirito Gabriella Pescucci si schermisce, e aggiunge: "Purtroppo stiamo perdendo la mentalità artigianale, non c'è ricambio di generazioni, oggi i giovani preferiscono andare a lavorare in una jeanseria, eppure il lavoro artigianale in una sartoria è estremamente creativo". La costumista "Oscar '94", circondata dai costumi de "L'età dell'innocenza" montati sui manichini nel salottino della gloriosa sartoria di Tirelli, da cui sono usciti anche quelli del Gattopardo e di Ludwig - e in cui la Pescucci ha creato gli abiti di grandi film come Il nome della Rosa, C'era una volta in America, La città delle donne, Il barone di Munchausen, materializzando i sogni di Fellini, Leone, Gillian, Annaud - risponde con gentilezza e amabilità alle nostre domande. Rivela eleganza, discrezione e soprattutto passione per il proprio lavoro, che lei considera di gruppo: "Ci vorrebbe poco per far sì che il mio lavoro si veda molto, invece che una paillette piccola se ne mette una grossa e il gioco è fatto, ma è bello quando il lavoro è d'equipe, amalgamato in modo che nessuno prevarichi, dove tutto è nelle mani del regista che diventa un po' come il direttore d'orchestra". Stupisce la modestia e la grande professionalità di questa costumista il cui lavoro ha determinato il sapore d'epoca suggestivo e preciso di film che rimarranno nella storia del cinema, un lavoro consacrato dall'Oscar per un film, quello di Scorsese, dove il colore, la pittoricità, la ricostruzione maniacalmente esatta dell'immagine della aristocrazia newyorkese fine Ottocento sono elementi fondamentali del fascino visivo. "Avevo molto amato il romanzo della Wharton nella mia giovinezza, per cui mi ci sono buttata con molto calore e anche coraggio, Scorsese aveva fretta di girare e non avevo molto tempo per la preparazione, ma lui è stato magnifico, mi ha lasciato la massima libertà...".
"La macchinetta in cui inserisci la moneta e viene fuori il costume non l'hanno ancora inventata". Con una battuta di spirito Gabriella Pescucci si schermisce, e aggiunge: "Purtroppo stiamo perdendo la mentalità artigianale, non c'è ricambio di generazioni, oggi i giovani preferiscono andare a lavorare in una jeanseria, eppure il lavoro artigianale in una sartoria è estremamente creativo". La costumista "Oscar '94", circondata dai costumi de "L'età dell'innocenza" montati sui manichini nel salottino della gloriosa sartoria di Tirelli, da cui sono usciti anche quelli del Gattopardo e di Ludwig - e in cui la Pescucci ha creato gli abiti di grandi film come Il nome della Rosa, C'era una volta in America, La città delle donne, Il barone di Munchausen, materializzando i sogni di Fellini, Leone, Gillian, Annaud - risponde con gentilezza e amabilità alle nostre domande. Rivela eleganza, discrezione e soprattutto passione per il proprio lavoro, che lei considera di gruppo: "Ci vorrebbe poco per far sì che il mio lavoro si veda molto, invece che una paillette piccola se ne mette una grossa e il gioco è fatto, ma è bello quando il lavoro è d'equipe, amalgamato in modo che nessuno prevarichi, dove tutto è nelle mani del regista che diventa un po' come il direttore d'orchestra". Stupisce la modestia e la grande professionalità di questa costumista il cui lavoro ha determinato il sapore d'epoca suggestivo e preciso di film che rimarranno nella storia del cinema, un lavoro consacrato dall'Oscar per un film, quello di Scorsese, dove il colore, la pittoricità, la ricostruzione maniacalmente esatta dell'immagine della aristocrazia newyorkese fine Ottocento sono elementi fondamentali del fascino visivo. "Avevo molto amato il romanzo della Wharton nella mia giovinezza, per cui mi ci sono buttata con molto calore e anche coraggio, Scorsese aveva fretta di girare e non avevo molto tempo per la preparazione, ma lui è stato magnifico, mi ha lasciato la massima libertà...".
Come è avvenuto lo studio dei personaggi? "Partendo dal libro che è descrittivo al massimo, quasi didascalico, poi decidendo insieme a Scorsese, ad esempio, che Helen doveva essere una donna più "donna", con una femminilità prorompente, con più carattere, rispetto all'altra, Mary, che invece doveva risultare più ragazzina, con un'aria più ingenua. Questa diversità tra le due immagini, sottolineata dai colori e dalla scelta dei dettagli, rendeva più drammatica la situazione del protagonista, diviso tra due sentimenti".
Questo lavoro così minuzioso sui dettagli ha fatto scrivere ad alcuni il nome di Luchino Visconti...
"Ogni volta che si fa un grande film in costume la critica cita Visconti. Visconti è stato un grande maestro, io da ragazzina ho avuto la fortuna di lavorarci, ma non si può citarlo ogni volta. Io trovo che il lavoro di Scorsese è completamente diverso: a Visconti interessava il quadro di una società, di un mondo in disfacimento osservato nella sua crisi, a Scorsese interessa andare "dentro" con la macchina da presa, con cattiveria, curiosità, avidità: un altro modo di raccontare..."
Certo, ma l'amore per la ricostruzione critica di un'epoca li accomuna. "Visconti è stato un caposcuola dell'esattezza di ricostruzione, dell'amore per il passato, questa lezione certamente Scorsese l'ha tenuta presente".
Per lei è fondamentale la documentazione e la ricerca di tipo storico? Oppure lascia spazio alla fantasia... "Fantasia è una parola molto vaga: nessuno inventa niente. Il mio lavoro è una ricerca il più possibile accurata di quello che è stato il modo che devo ricreare, dopo di che posso dire, questo era quel mondo, ora cerco di appropriarmene, magari distorcendolo... ma chi inventa o crede di farlo, lo fa per ignoranza, tutto è stato fatto, non si fa che ricreare, riproporre".
Ma quanto è grande secondo lei il margine tra verità documentata e invenzione? "Si parte sempre dal massimo della conoscenza dell'epoca, o del mondo fantastico che si vuole interpretare. Per Il Barone di Munchausen dissero che avevo "inventato", ma io non inventai nulla, piuttosto partii da una documentazione di varie epoche, distorcendo e pasticciando, mescolando vari stili perché in quel caso l'esigenza della regia me lo permetteva".
E per "The Age of innocence" come ha proceduto? "Sono partita da una documentazione soprattutto pittorica, assimilando il gusto di pittori come Tissot o Sargent, che erano di moda nell'ambiente aristocratico newyorkese del 1880".
E' stata, questa iconografia, una fonte ispirativa o semplicemente un dato di documentazione? "Il mondo pittorico o fotografico d'epoca è sempre per me una fonte di emozione, ogni volta che inizio un film c'è come un innamoramento, per un pittore o per un fotografo, dal quale parto per immergermi in profondità nel clima di un'epoca storica".
Com'è il rapporto di collaborazione con Dante Ferretti, scenografo con cui spesso lavora in coppia? "E' un rapporto unico, ci capiamo al volo, abbiamo cominciato insieme facendo gli assistenti. L'accordo non ha bisogno nemmeno di consultazioni, a volte scopriamo per caso che lui ha messo una certa carta da parati proprio del colore che io ho in mente per gli abiti di quella scena. Ne L'età dell'innocenza per esempio lui aveva fatto l'interno di una stanza tutta con cineserie, e io avevo pensato di far indossare all'attrice proprio una vestaglia cinese!"
Lei ha lavorato anche per il teatro e la lirica, che differenza c'è con il cinema? "Io che vengo dal cinema, quando faccio il teatro (ultimamente La vestale alla Scala), mi viene naturale renderlo più realistico e minuzioso possibile, ma considero la distanza. Il cinema va "dentro", a teatro perché arrivi qualcosa si deve un po' esagerare... ma io amo il cinema sempre di più, amo il lavoro quotidiano e l'incontro con il set..."
Intervista di BRUNO ROBERTI da VIVI IL CINEMA Aprile-maggio 1994
 Trent'anni senza il grande regista, che moriva il 30 aprile 1989, capace di rivoluzionare il modo di usare la cinepresa e di traghettarci nel cinema moderno. Chi lo avrebbe mai detto? Chi avrebbe potuto immaginare che il western, "il cinema americano per eccellenza" (parole di John Ford), sarebbe stato reinventato, ridisegnato, dinamitato addirittura da "un romano de Roma"? Come sostiene Alex de la Iglesia, il western è il più astratto dei generi cinematografici, il più lontano dalla realtà: quello, in un certo senso, che ha "creato" il cinema.
Trent'anni senza il grande regista, che moriva il 30 aprile 1989, capace di rivoluzionare il modo di usare la cinepresa e di traghettarci nel cinema moderno. Chi lo avrebbe mai detto? Chi avrebbe potuto immaginare che il western, "il cinema americano per eccellenza" (parole di John Ford), sarebbe stato reinventato, ridisegnato, dinamitato addirittura da "un romano de Roma"? Come sostiene Alex de la Iglesia, il western è il più astratto dei generi cinematografici, il più lontano dalla realtà: quello, in un certo senso, che ha "creato" il cinema.
E Sergio Leone, allora, cresciuto in pieno clima neorealista italiano e perfino figurante – a meno di vent'anni – in Ladri di biciclette? Certo, Sergio era nato al centro stesso del mondo cinematografico romano: figlio di Roberto Roberti (pseudonimo di Vincenzo Leone, regista di una quarantina di film) e dell’attrice romana Bice Waleran. Ma quello, appunto, era il tempo dei film-opera, dei peplum, delle fantasie salgariane; mentre i western se ne stavano rigorosamente dall’altra parte dell’Oceano. E infatti Leone cominciò come sceneggiatore (Nel segno di Roma), assistente alla regia (Sodoma e Gomorra), o anche direttore della seconda unità (non accreditato) per i blockbuster della Hollywood sul Tevere: Quo vadis?, Elena di Troia, Ben Hur.
........................
 Leone fu, se non il primo, uno dei primi a convertirsi allo spaghetti-western, di cui colse e distillò l’essenza diventando subito il più celebre regista del genere; che, grazie a lui, avrebbe foraggiato l’industria cinematografica italiana per più di un decennio. Sergio, del resto, non poteva sbagliare, unendo l’amore per i classici di Ford, Zinnemann, Aldrich con una inclinazione per la cultura giapponese che ritroveremo sia nei soggetti, sia nelle “maschere” impenetrabili di alcuni cowboy. Nel 1964 il suo primo western, Per un pugno di dollari (che uscì firmato Bob Robertson, in onore allo pseudonimo paterno), stupì e conquistò il pubblico, col suo eroe dalla faccia di pietra (il semisconosciuto Clint Eastwood, dopo che il poco lungimirante Rory Calhoun, già protagonista del Colosso di Rodi, aveva disdegnato il ruolo), con le musiche orecchiabilissime di Ennio Morricone e con una nuova, esibita amoralità, consona ai tempi che si andavano profilando. È noto che il film procurò a Leone parecchie grane: largamente basato sulla Sfida del samurai di Akira Kurosawa, suscitò le ire del maestro giapponese; che intentò una causa al collega italiano, vincendola.
Leone fu, se non il primo, uno dei primi a convertirsi allo spaghetti-western, di cui colse e distillò l’essenza diventando subito il più celebre regista del genere; che, grazie a lui, avrebbe foraggiato l’industria cinematografica italiana per più di un decennio. Sergio, del resto, non poteva sbagliare, unendo l’amore per i classici di Ford, Zinnemann, Aldrich con una inclinazione per la cultura giapponese che ritroveremo sia nei soggetti, sia nelle “maschere” impenetrabili di alcuni cowboy. Nel 1964 il suo primo western, Per un pugno di dollari (che uscì firmato Bob Robertson, in onore allo pseudonimo paterno), stupì e conquistò il pubblico, col suo eroe dalla faccia di pietra (il semisconosciuto Clint Eastwood, dopo che il poco lungimirante Rory Calhoun, già protagonista del Colosso di Rodi, aveva disdegnato il ruolo), con le musiche orecchiabilissime di Ennio Morricone e con una nuova, esibita amoralità, consona ai tempi che si andavano profilando. È noto che il film procurò a Leone parecchie grane: largamente basato sulla Sfida del samurai di Akira Kurosawa, suscitò le ire del maestro giapponese; che intentò una causa al collega italiano, vincendola.
 Tuttavia Per un pugno di dollari non era un colpo di fortuna, o un mero frutto del caso. L’universo che, in un sol colpo, aveva creato, esigeva di essere ripreso e valorizzato. Lo fu doppiamente: con Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo; che, assieme al prototipo, andarono a comporre la famosa "trilogia del dollaro". Poi Leone, circonfuso di fama e riconoscimenti internazionali, volle ampliare ulteriormente le proporzioni delle sue opere e – come dire? – l'angolo visuale del suo acuto occhio registico. Lo fece con un blockbuster come C'era una volta il West, fitto di star che aveva amato da spettatore seduto il platea (Henry Fonda, Charles Bronson); col suo film "rivoluzionario" Giù la testa; con la maxi-saga gangsteristica C'era una volta in America, dalla visione troppo europea per piacere al pubblico americano. E c'è da giurare che l'avrebbe fatto all’ennesima potenza con L'assedio di Leningrado, che si preparava ad andare a girare on location in Russia, pochi giorni prima di morire per un attacco cardiaco a soli sessant'anni.
Tuttavia Per un pugno di dollari non era un colpo di fortuna, o un mero frutto del caso. L’universo che, in un sol colpo, aveva creato, esigeva di essere ripreso e valorizzato. Lo fu doppiamente: con Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo; che, assieme al prototipo, andarono a comporre la famosa "trilogia del dollaro". Poi Leone, circonfuso di fama e riconoscimenti internazionali, volle ampliare ulteriormente le proporzioni delle sue opere e – come dire? – l'angolo visuale del suo acuto occhio registico. Lo fece con un blockbuster come C'era una volta il West, fitto di star che aveva amato da spettatore seduto il platea (Henry Fonda, Charles Bronson); col suo film "rivoluzionario" Giù la testa; con la maxi-saga gangsteristica C'era una volta in America, dalla visione troppo europea per piacere al pubblico americano. E c'è da giurare che l'avrebbe fatto all’ennesima potenza con L'assedio di Leningrado, che si preparava ad andare a girare on location in Russia, pochi giorni prima di morire per un attacco cardiaco a soli sessant'anni.
Che Sergio Leone abbia contribuito in modo decisivo a cambiare il modo di usare la cinepresa, inaugurando un suo (e molto imitato) stile di "cinema moderno", lo hanno detto voci autorevoli del mestiere, da Clint Eastwood a Quentin Tarantino, cui sarebbe troppo facile accodarsi. Piace, invece, ricordare un episodio che dimostra come il regista non fosse narcisisticamente innamorato dei propri film, ma riflessivo e sempre pronto a migliorarsi. Lo ha raccontato così, per i suoi novant’anni, il complice e collaboratore di una vita, Ennio Morricone: "un anno dopo l’uscita Per un pugno di dollari era ancora nelle sale e con Sergio andammo a vederlo al Cinema Quirinale. Uscendo, ci guardammo e, nello stesso istante, esclamammo: che brutto film abbiamo fatto!".
dall'articolo di ROBERTO NEPOTI per Repubblica.it
'C'era una volta Sergio Leone', dopo Parigi la mostra a dicembre a Roma
 Intervista a José Rodriguez, il regista / creatore di "Deadline", un cortometraggio d'azione interamente realizzato in cinematografia digitale. Tanto impegno e passione hanno permesso di creare un cortometraggio con una CG spettacolare. Scopriamo come.
Intervista a José Rodriguez, il regista / creatore di "Deadline", un cortometraggio d'azione interamente realizzato in cinematografia digitale. Tanto impegno e passione hanno permesso di creare un cortometraggio con una CG spettacolare. Scopriamo come.
So che "Deadline" era il progetto finale di un corso. Puoi dire ai nostri lettori qualcosa di più su come è nato?
José Rodriguez: Circa tre anni fa, nel 2009, ho deciso di approfondire la mia passione per il 3D, per gli effetti speciali, e più in generale per il film-making. Per farlo ho consultato una scuola di Barcellona, FX Animation, e partendo dalle premesse di quello che mi interessava realizzare abbiamo stabilito un percorso di studio che comprendeva l'animazione 3D con LightWave 3D e il compositing 2D con Fusion. Ho iniziato così e per completare il corso e considerare superato l'esame, il requisito era quello di consegnare un progetto finale.

Un classico del cinema Hollywoodiano, il grande camion sull'autostrada: a costo zero
Per me, la migliore motivazione in un progetto è: "Fai quello che ti piace guardare al cinema". Così, fin dall'inizio ho deciso che volevo fare un cortometraggio di azione con inseguimenti automobilistici.
Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo?
Dato che il cortometraggio è stato realizzato nel mio tempo libero (in altre parole la sera, dopo il lavoro e dopo aver frequentato le lezioni del corso stesso), mi ci sono voluti circa un anno e mezzo per completare il corto. Devo dire che ci sono state parecchie settimane nelle quali non sono stato assolutamente in grado di lavorarci, quindi questa durata di un anno e mezzo è molto più di quanto in realtà sarebbe servito se mi ci fossi dedicato a tempo pieno.

Rendering spettacolari permettono di produrre a costo zero scene da cinema
Deadline è partito da un'idea o si è evoluto da una classica scena di inseguimento in auto?
La verità è che è iniziato e si è sviluppato in base a quello che richiedeva l'azione, aggiungendo qualcosa di simile a una storia per colmare i "vuoti" e per giustificare, almeno in minima parte, ciò che accade sullo schermo.
Gli obiettivi del progetto erano di dimostrare le capacità del 3D, del compositing e gli effetti speciali. Non ho fatto quasi nulla per preparare uno script: il soggetto della storia è decisamente qualcosa in secondo piano in Deadline.


Simulazione dinamica della collisione e effetti di particelle
Da quanto dura la passione per gli effetti visivi e il film making?
Il mio interesse nella regia e nel 3D risale al 1996. Nel cinema mi è sempre piaciuto in modo particolare tutto ciò che è nello stile classico degli "Hollywood blockbuster". Non appena ho potuto mettere le mani su una videocamera, ho iniziato subito a girare cortometraggi. Ma le mie non sono le storie che si incentrano sui personaggi.
Mi interessa il corto di intrattenimento, l'obiettivo è far saltare in aria le cose e sparare a qualsiasi cosa si muova sullo schermo.
Ovviamente, le prime realizzazioni sono state ben lontane dal somigliare a quello che avevo intenzione di creare quando le ho fatte (ci sono circa un paio di miei cortometraggi, che è davvero vietato guardare :-) ).
Ma la mia speranza è che nel corso del tempo, con l'affinarsi delle conoscenze e delle tecniche, i miei lavori riescano a essere sempre di più vicini all'idea che ho nella mia testa e che cerco di realizzare. Con "Deadline" penso di aver ottenuto più o meno quello che volevo e naturalmente, lavoro dopo lavoro, spero di migliorare in tutto quello che faccio.
Quali sono i registi che più hanno influito sulla tua visione del cinema?
Lo stile visivo di Michael Bay è il riferimento più diretto, cerco sempre di tenere a mente quel modo di mettere in scena l'azione. Non parlo di cose come la qualità della trama dei suoi film, credo che come regista d'azione non abbia rivali. Bay è in grado di mettere lo spettatore all'interno di tutte le sequenze d'azione, ed è quello che, in qualche modo, desidero ottenere anche io.
"Deadline", essendo al 95% creato completamente in CGI, mi ha dato la libertà di pensare a come e dove posizionare le telecamere, quante macchine da presa volevo, quali obiettivi fossero i più appropriati da utilizzare. Ho potuto girare in controluce, e simulare molti shot come li avrebbe fatti Bay (o perlomeno, come penso che li avrebbe fatti).
Insomma, tutto è stato fatto come se stessi lavorando a una ripresa vera e propria. Nel cortometraggio al quale sto lavorando adesso, la percentuale di CGI è scesa al 30% o giù di lì, e questo significa che ho molti più limiti tecnici (e di budget, lol). E quindi non penso di riuscire ad avere un risultato in stile "produzione di Bay".
Ma bisogna sempre tentare!
Il cortometraggio "Deadline", i pochi shot girati dal vero (le persone) sono stati fatti con una miniDV.
Per "Deadline" hai fatto storyboard dell'inseguimento?
Ho fatto una "previz" per l'intera sequenza di introduzione e per tutto l'inseguimento attraverso il tunnel, era un requisito del progetto. Ma il resto del corto l'ho fatto molto più liberamente.
Poiché soltanto io ho lavorato al progetto, era subito molto chiaro come avrei voluto le riprese e non avevo bisogno di realizzare un "premontato" di tutto per spiegare le scene a me stesso. In un certo senso, il fatto che fosse tutto CGI, mi ha dato la possibilità di escludere delle idee e modificarle, prima di passare alla "ripresa" (cioè, al rendering ;) ).

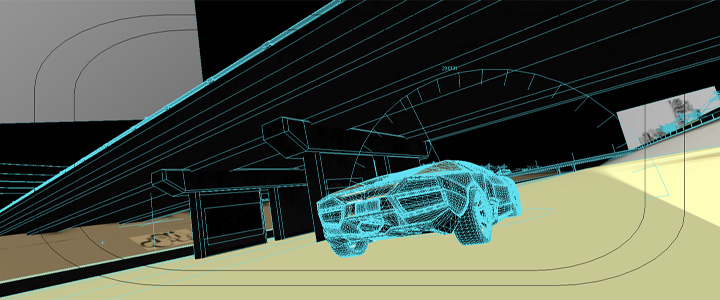
Un altro grande classico: in quanti film abbiamo visto questo canale?
Il montaggio è molto serrato ma anche con un'ottima continuità. È stato scartato molto materiale durante l'editing?
No, in realtà non è stato scartato quasi nulla del rendering durante il montaggio. Poiché ho pianificato le sequenze complete come se fossero una ripresa reale, mettendo le telecamere di Lightwave nelle posizioni alle quali ero interessato, tutto quello che ho fatto è stato di attivare il plugin "CameraSelector" e alternare da una macchina da presa all'altra quando lo volevo.Essendo la stessa sequenza, vista da ciascuna macchina da presa, la continuità era automaticamente esatta. Quindi ho solo dovuto decidere gli intervalli di fotogrammi dei quali avevo bisogno per ogni shot.
Puoi condividere qualche suggerimento sull'animazione? È molto realistica.
La maggior parte dell'animazione è fatta con keyframe manuali, e una parte è stata automatizzata. Ad esempio, ogni macchina aveva un "volante virtuale", che mi ha permesso, quando lo ruotavo, di influenzare la rotazione delle gomme e il rollio della carrozzeria.

Ancora un esempio di ambiente e elementi 3D da Deadline
Un rig permetteva di collegare la rotazione delle ruote alla effettiva velocità e allo spazio percorso. Tutto quello che ha richiesto un' interazione fisica, come l'impatto dell'auto o le travi metalliche che cadono dal camion, è stato calcolato utilizzando simulazioni dinamiche.
Le travi che cadono le ho realizzate con il sistema di fisica nativo di Lightwave (niente Bullet Physics, a quei tempi c'era solo la versione 9.6 di Lightwave), e le collisioni delle auto con una plugin in 3DS Max, che importava una geometria di base per l'automobile, calcolava la simulazione, e quindi esportava l'animazione finale pronta per il rendering in Lightwave.
Qualche consiglio sul rendering? In Deadline è spettacolare. Ed è tutto opera di una sola persona.
La maggior parte è rendering direttamente da Lightwave senza alcuna modifica (insomma, senza passate di rendering, layer di riflessione, colore, ombra, etc.). Fatta eccezione per la necessaria post produzione, come ad esempio la correzione del colore, l'aggiunta di lens flare dell'obiettivo e altri ritocchi classici. Ho fatto il rendering per passate solo per quanto riguarda gli effetti come il fumo. È molto più facile controllare il risultato degli effetti particellari se si fa il rendering come strati separati e poi li si ricompone in 2D.
Tutti i rendering sono stati calcolati con l'illuminazione globale. Uno dei punti di forza del motore di rendering di Lightave è la sua velocità. Il tempo di render medio per ogni fotogramma è stato di circa 6 o 7 minuti. Bisogna tener presente che la risoluzione non era HD, ma DVD PAL. Nonostante questo credo che i tempi di rendering siano stati decisamente buoni.

Wireframe e rendering finale si alternano — si riesce anche a vedere il rig slider di animazione
Da quanto tempo lavoravi con Lightwave quando hai realizzato "Deadline"?
Ho iniziato ad usare Lightwave quando ho fatto il corso di 3D e effetti speciali. In passato ero un utente 3D Studio Max. Il passaggio da 3ds Max a Lightwave, per me, è stato molto produttivo.
Hai fatto riferimento a un nuovo cortometraggio. Di cosa si tratta?
Si tratta di un corto d'azione, che è un video promozionale per una squadra di airsoft nella quale si trovano alcuni dei miei amici. L'idea è di creare qualcosa come un "Call of Duty" ripreso dal vivo, ma resta da vedere se ci riesco oppure no.
Dal punto di vista della storia non c'è molto da dire. Questa è una missione di salvataggio di un ostaggio, effettuata da un gruppo militare. Ma è un tentativo da parte mia di girare scene d' azione riprese dal vero, e certamente è stato un passo importante nel mio percorso di regia. Quando abbiamo girato ho dovuto coordinare un gruppo di circa 20 persone, con tante inquadrature diverse. È stato difficile, ma non credo che sia andato male.

Il girato originale con una DSLR 550D Canon

E i "piccoli" cambiamenti ottenuti con la postproduzione digitale
In questo momento, la post produzione è completa per più del 60%, ma è arrivata alla parte più difficile, le sequenze finali, dove ci sarà per la maggior parte CGI, perché devo creare ovunque degli spari, delle esplosioni e dei veicoli (e le esplosioni dei veicoli! lol).
Questo nuovo corto è girato con una DSLR? Che esperienza hai avuto con il Rolling Shutter?
Sì, per questo progetto, ho usato una EOS 550D per le riprese. Infatti, il Rolling Shutter è uno dei peggiori difetti del sistema DSLR, se non il peggiore. L'effetto "gelatina" può essere più o meno presente, e forse non si nota in alcune riprese, ma quando si tratta di integrare 3D e immagini reali uno shot con il Rolling Shutter è lo scenario peggiore possibile.
È vero che ci sono plugin basate sui sistemi di analisi del movimento e che queste possono correggere in parte il problema. Ma il risultato non è perfetto, lascia degli "artefatti" sulle immagini, e comunque gli oggetti 3D non sono perfettamente integrati con le riprese live action.
Girare con i sistemi DSLR è eccellente. Dalle possibilità di scelta degli obiettivi, al controllo su apertura e filtri. Danno un'ottima flessibilità di ripresa. E soprattutto, danno un tocco cinematografico molto difficile da eguagliare. Ma quando si tratta di scene d'azione , o peggio, scene d'azione con elementi 3D e effetti speciali... non è sicuramente la soluzione migliore.
Cosa pensi di Lightwave?
Per me è la migliore soluzione in termini di software "out of the box". È in grado di dare buoni risultati in poco tempo. Il motore di rendering nativo è eccellente e dà una qualità molto fotorealistica con tempi di rendering decisamente bassi. Ora con la versione 11, hanno ottimizzato molto il sistema di antialiasing, e questo permette di ottenere la stessa qualità delle versioni precedenti, o addirittura una qualità superiore, con tempi di rendering ancora più ristretti.
A mio parere, è meno utilizzato nelle grandi produzioni, dove le società di effetti speciali sono in grado di sviluppare le proprie soluzioni basate di solito su Maya e Houdini. Ma quando si tratta di ottenere risultati con meno risorse e meno tempo, per me, Lightwave è lo strumento da utilizzare.
Ma, come dico sempre lo strumento non è importante. Con qualsiasi software si può ottenere tutto!
Cosa suggeriresti a qualcuno che volesse girare cortometraggi come i tuoi?
Se si tratta di una produzione 3D, per me la cosa più importante ai fini di un risultato realistico è di pensare come se si trattasse di una ripresa reale.
- "Si potrebbe davvero mettere la macchina da presa lì?"
- "Di quale attrezzatura, quali lenti, dolly, gru, o illuminazione, avrei bisogno per fare questo nella realtà?"
- "Se abbasso la macchina da presa in questo modo, potrei farlo anche dal vero?"
Prendendo in considerazione tutto questo, i risultati saranno già un po' più vicini alla realtà. E oltre a questo, è sempre bene di aver visto tanti, tanti film d'azione, e cercare di ricordare quali elementi hanno avuto un impatto più forte e particolare.
José, grazie per l'intervista e per tutti i preziosi consigli. La prima volta che ho visto Deadline su YouTube ho pensato che veramente, finalmente, il mondo della produzione indipendente era cambiato. È impressionante che tu abbia realizzato da solo tutto questo. Non è solo tecnicamente eccezionale, ha il ritmo e il "polso" di una produzione ad alto costo. Insomma, è uno stimolo per tutti a fare sempre di più. Grazie ancora!
Massimiliano Marras
dal sito vfxwizard.com - Corsi Online Effetti Speciali: Corso professionale effetti speciali, compositing e animazione 3D (After Effects, Lightwave, Maya, zBrush, VUE)
Il cortometraggio “L’ultima Zingarata”, remake della celebre scena finale del film “Amici Miei”, presentato alla 67° edizione della Mostra del cinema di Venezia, diventa un film documentario dal titolo “L’Ultima Zingarata. Un funeralone da fargli pigliare un colpo!” che sarà presentato a Firenze, in anteprima nazionale, al cinema Odeon, martedì 15 febbraio.
Ideato e prodotto da Francesco Conforti, con la regia di Federico Micali e Yuri Parrettini, il film documentario ripercorre la straordinaria storia della nascita del cortometraggio. Ne racconta la genesi, offre uno spaccato inedito delle riprese, si avvicina alle mille comparse volontarie, per poi concludersi a Venezia, dove il cortometraggio è stato proiettato nell’ambito delle Giornate degli autori della 67° edizione della Mostra del cinema.
Perla del film è l’intervista inedita a Mario Monicelli e il suo cameo come attore. Il regista della commedia italiana, nella sua ultima partecipazione a un progetto filmico, racconta, tra aneddoti e curiosità sullo sfondo di Amici miei, anche le origini delle cosiddette “zingarate” e delle “supercazzole”.
“Queste zingarate – spiega Monicelli nel documentario – erano vere, tutte cose che si raccontavano a Firenze. Così come la “supercazzola”: un nostro caro amico, tale Raffaello Pacini, in questo era sublime. Fermava la gente per strada, chiunque fosse, la teneva lì per pochi minuti senza dire niente ma prendendoli in giro. Era bravissimo”. Relativamente alla celebre scena degli schiaffi ai viaggiatori alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, racconta che “le comparse sul treno non sapevano che avrebbero preso degli schiaffi dai cinque amici. Fu una sorpresa per tutti e ci fu un’insurrezione delle stesse comparse”.
Il documentario di Federico Micali e Yuri Parrettini - che già avevano indagato il rapporto particolare tra i film e i suoi spettatori con “Cinema Universale d'essai”, distribuito al cinema nel 2009 -, immerge lo spettatore nella Firenze di “Amici Miei”, rievocandone lo spirito goliardico, ironico e a volte amaro anche grazie a rielaborazioni e ricostruzioni grafiche. Il documentario ritrae una generazione d’intramontabile comicità dando voce agli stessi protagonisti del film cult: Gastone Moschin, Milena Vukotic, Maurizio Scattorin (nel film originale figlio del Perozzi) e il fornaio “becco” Tommaso Bianco (tutti saranno presenti all’anteprima all’Odeon). Non manca la testimonianza della moglie del regista, Chiara Rapaccini, anche lei presente all’anteprima.
Il documentario termina con il cortometraggio girato il 6 giugno 2010 in piazza Santo Spirito di Firenze alla presenza di oltre un migliaio di “zingari” vestiti a lutto e accorsi spontaneamente (contattate anche tramite facebook) da tutta Italia. La clip segue le stesse inquadrature iniziali dell'originale (con poche persone), per poi aprirsi a raccontare un funerale surreale e onirico dove tutti sono vestiti eccentricamente a lutto, per spaziare tra corone di fiori e majorettes, tra bande musicali e giocolieri del Circo Nero, fino agli Hare Krishna a chiudere il corteo. Proprio come avrebbe voluto l’architetto Melandri per il suo caro amico Perozzi. Nella parte dell’architetto Melandri c’è nuovamente l’attore Gastone Moschin e nella parte che fu di Adolfo Celi il cameo di Mario Monicelli che, prima della morte, non potendo essere presente alle riprese, lasciò un audio “messaggio di speranza” per Firenze.
“Ragazzi - disse il maestro davanti alle mille comparse - non sono potuto venire a Firenze, non ho l'eta' per fare queste cose. Vi ringrazio di essere tutti presenti in questa Santo Spirito meravigliosa e soprattutto di aver partecipato a questa 'zingarata', forse una delle ultime. Beati voi che siete fiorentini, che siete nati in una citta' dove si fanno le 'zingarate', dove c'e' la liberta' di ridere, di divertirsi e di avere a disposizione tutta questa gente. Come vedete questo spirito a Firenze c'e' ancora e speriamo che non muoia mai. E che si ripeta ancora e ci sia qualcuno che lo faccia vedere al mondo come e' successo per il film 'Amici miei”.
“L’ultima zingarata. Un funeralone da fargli pigliare un colpo!” sarà distribuito insieme a un libro fotografico per Giunti Editori come supplemento al quotidiano La Nazione e venduto in tutte le librerie Giunti al Punto d’Italia. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione Busajo Onlus (www.busajo.org) che sostiene il progetto “Smiling Children Town” contribuendo a reperire i fondi per aiutare i bambini di strada in Etiopia.
Dichiarazioni di Federico Micali e Yuri Parrettini (registi):
Un giorno mi squilla il telefono e sento fare “Si, Micali? Sono Mario Monicelli” e dice “Volete rifare il funerale del Perozzi? E’ un’idea fantastica. Io ci sto”.
L'idea di rifare il funerale del Perozzi ci era sembrata da subito una follia …. e quindi ci sembrava assolutamente pertinente allo spirito dell'Oltrarno, forse l'ultima parte di Firenze che rappresenta ancora l'anima della città, almeno come siamo abituati a conoscerla.
E infatti durante l'organizzione delle riprese del cortometraggio ci siamo resi conto di come alla fine intorno al progetto si stesse muovendo “la pancia” di una città legata a doppio filo con uno dei film che la rappresenta di più. In qualche modo era la stessa Firenze che avevamo incontrato durante le riprese di Cinema Universale d'essai, il nostro precedente lavoro incentrato sulle alterne vicende di una fantastica e anarchica sala cinematografica di San Frediano dove il pubblico in sala interagiva liberamente con lo schermo riscrivendo la trama dei film.
L'incontro con Mario Monicelli- che per l'appunto aveva molto apprezzato proprio Cinema Universale d'essai – è stato il momento in cui abbiamo capito che oltra al cortometraggio dovevamo andare a raccontare tutto quello che si stava muovendo intorno allo stesso. E quindi la fantastica partecipazione di Gastone Moschin, di Milena Vukotic,del figlio del Perzozzi e del fornaio becco, ma anche e sopratutto di quelle centinaia e centinaia di persone che una calda domenica di giusgno si sono presentati vestiti a lutto in Piazza Santo Spirito per amore del cinema.
Monicelli ha subito apprezzato il piglio dell'iniziativa, che gli pareva toccare le corde della sua commedia all'italiana. Ci ha regalato anche un cameo attoriale- insieme all'immenso orgoglio di averlo diretto per qualche minuto- interpretando i panni che furono di Adolfo Celi... quelli del boss.
E non poteva essere altrimenti: il boss geniale, un punto di riferimento assoluto sia autoriale che ideologico che ci mancherà veramente tanto.
Dichiarazioni di Francesco Conforti (ideatore e produttore):
…abbiamo pensato, ma perchè seguendo le parole del Melandri alla fine del film non rifacciamo un Funeralone come avrebbero voluto loro, con bande, bandiere, corone , telegrammi , puttane e militari… tutte cose che in piazza S.Spirito si trovano con una certa facilità!
E’ stato un anno intenso: dal concepimento dell’idea al suo sviluppo e realizzazione, dalla partecipazione a Venezia alle zingarate per l’Italia per raccogliere le tante interviste che fanno da punteggiatura al film. Un anno confortato da tanti amici che ci hanno aiutato, sia economicamente che moralmente, da vecchi Amici con la A maiuscola, grazie ai quali ‘L’Ultima Zingarata’ potrà avere una diffusione ben oltre i nostri confini cittadini e portare una ventata d’Oltrarno per l’Italia, e da tanti nuovi amici come Mario Monicelli che purtroppo nel frattempo ha deciso di andarsene e al quale io, Federico, Clementina e tutta Firenze dedichiamo questo film, certi che questo “Funeralone” sia venuto proprio come lui lo avrebbe voluto!
Grazie “AMICI MIEI” !
Mario Monicelli nel documentario:
“Pietro Germi lo voleva girare a Bologna. Lui era di Genova, e pensava che anche i bolognesi fossero simpatici e cordiali. Poi quando arrivai io, dissi: io sono Toscano, il film si fa a Firenze”.
“Queste ‘zingarate’ erano tutte cose che si raccontavano a Firenze, non è stato inventato…non so se fossero reali ma si raccontavano”
“A Firenze c’erano almeno 15 persone che facevano la supercazzola molto meglio degli attori. Uno era un amico nostro, Raffaello Pacini, la faceva in una maniera sublime. Fermava la gente per strada, chiunque fosse, la teneva lì 6-7 minuti senza dirgli nulla, prendendoli in giro. Erano bravissimi”.
“La verità è che la comparse non lo sapevano che avrebbero preso degli schiaffi. Quando si sposta il treno dissi “fuori fuori” e ci fu una insurrezioni delle comparse”
“'Ragazzi non sono potuto venire a Firenze, non ho l'eta' per fare queste cose. Vi ringrazio di essere tutti presenti in questa Santo Spirito meravigliosa e soprattutto di aver partecipato a questa 'zingarata', forse una delle ultime. Beati voi che siete fiorentini, che siete nati in una citta' dove si fanno le 'zingarate', dove c'e' la liberta' di ridere, di divertirsi e di avere a disposizione tutta questa gente. Come vedete questo spirito a Firenze c'e' ancora e speriamo che non muoia mai. E che si ripeta ancora e ci sia qualcuno che lo faccia vedere al mondo come e' successo per il film 'Amici miei'''. (Messaggio audio trasmesso in piazza Santo Spirito durante le riprese)”.
‘‘Hanno messo insieme un funerale spettacoloso a Santo Spirito a Firenze. E’ un omaggio al mio film e a me’’.
Chiara Rapaccini nel documentario:
‘‘ Durante Amici Miei ho conosciuto Mario...ho lavorato esageratamente come comparsa, mi chiamava sempre...poi anche il mio babbo e la mia mamma furono presi da Monicelli, per l’appunto la mia famiglia venne tutta ingaggiata’’.
‘‘Quando il film è finito e il cinema ha lasciato Firenze è stata una cosa molto malinconica perchè Amici Miei aveva riempito la città di buonumore...sono tornati tutti a Roma ed io, che mi ero innamorata di Mario in modo un pò assurdo (40 anni di differenza) sono andata un pomeriggio da mia madre e le ho detto: ‘vado a Parigi con Monicelli, vado a vivere con lui’ .
Cesare Prandelli nel documentario:
“Dentro di noi c’è sempre un Perozzi. Bisogna tirarlo fuori”
Gastone Moschin nel documentario
‘‘Molti mi chiedevano: ma inventavate lì per lì? Non era scritto niente? E invece era scritto tutto solo che a noi stessi risultava di una tale freschezza, quando si dicevano le battute, da risultare inventate lì per lì. E’ stato il segreto del film, il segreto anche della direzione di Mario Monicelli che più che altro segnava i confini’’.
‘‘Il Melandri vero l’ho conosciuto: era un compagno di corso alla Scuola di Cinema di Germi e gli aveva raccontato queste storie vere che aveva vissuto a Firenze, con i nomi veri dei personaggi, e poi Germi si è ricordato le storie a distanza di tempo e ha pensato di reinventarle, arricchendole’’.
“E so na’ sega. A uno zingaro quando gli gira e gli gira”
Milena Vukoti? nel documentario:
‘’Amici Miei è stata una bellissima avventura, le giornate erano sempre molto cariche, molto intense, perchè sul set c’era sempre una grande vivacità’, non c’erano momenti di stasi’’.
L'ULTIMA ZINGARATA. Un funeralone da fargli pigliare un colpo!
Regia: Federico Micali e Yuri Parrettini
Produzione e ideazione: Francesco Conforti
Assistente alla produzione: Clementina Ricci
Montaggio e Post Produzione Video: Yuri Parrettini
Direttore della fotografia: Sirio Zabberoni
Riprese: Jonathan Chiti, Yuri Parrettini, Gianluca Marzo, Andrea Ponzecchi
Segretaria di Edizione: Martina Bartalini
Assistente di Regia: Giovanni Savi
Colonna sonora: Montefiori Cocktail, la banda musicale La Primula di Fucecchio
Anno di produzione: 2011
Produzione: Geronto Film
Durata: 69’
Distribuzione: dvd per Giunti al Punto
Produzione di Francesco Conforti
e il supporto dei Commerciarti di Piazza Santo Spirito e Savio Firmino, Ristorante Conte Mascetti e gli esercizi commerciali dell'Oltrarno.
Con la collaborazione di
PiazzArt e Toscana Film Commission, Firenze, Busajo Onlus e Controradio
Ideazione: Francesco Conforti
Web Marketing: Linda Bonacchi
Ufficio Stampa: PS Comunicazione di Antonio Pirozzi e Jacopo Storni – www.pscomunicazione.it
Interpreti:
Con la partecipazione straordinaria di
MARIO MONICELLI
GASTONE MOSCHIN
e con
MILENA VUKOTIC
MAURIZIO SCATTORIN
CHIARA RAPACCINI
TOMMASO BIANCO
CESARE PRANDELLI
“IL RIGHI” PAOLINO MONTAGNANI
"IL PEROZZI" ALESSANDRO BORGHI
Gli Amici
ANDREA OVALEO PANDOLFO
FRANCESCO CONFORTI
GIOVAMBATTISTA “GIAMBACCIO” GIANNANGELI
COSIMO SAVIO
FRANCESCO FRILLI
MICHELE GERVASUTI
ALESSANDRO JOMMI
L’Arciprete
Padre GIANMICHELE BARONI
e la partecipazione straordinaria del Circo Nero
Con all’interno il cortometraggio “L’ultima Zingarata” presentato in anteprima alle Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia 2010.
“…Come vorrei che venisse fuori un funeralone da fargli prendere un colpo: e migliaia di persone, tutte a piangere, e corone, telegrammi, bande, bandiere, puttane, militari…”
(Amici miei - 1975)
LUNEDI' 3 OTTOBRE 2011 - ORE 21:00 al Teatro Vascello a Roma
Come raggiungerci: Il Teatro Vascello si trova in Via Giacinto Carini 78 a Monteverde Vecchio a Roma sopra a Trastevere.
Los Angeles o Manhattan? Il premio oscar Giuseppe Tornatorenon sceglie: «A me il cinema americano piace tutto. Loro sono l’industria, ma dall’Italia hanno davvero imparato molto»
Il cinema americano è sempre stato prioritario, decisivo nella storia di quest’arte così straordinaria. E noi ne siamo stati tutti affascinati e condizionati in maniera sostanziale. È tuttora così, anche se spesso siamo portati a pensare che oggi la cinematografia d’oltreoceano non sia più grande com’era una volta. Ma credere che quello che viviamo oggi sia meno importante di quello che abbiamo vissuto ieri, è un vizio comune nel quale inciampiamo spesso e temo che sarà sempre così anche tra cinquant’anni. Personalmente, come spettatore vedo e amo tutto e il contrario di tutto. La prima volta che sono entrato in una sala da solo me la ricordo ancora. Davano Gli argonauti di Don Chaffey (1963), la storia di Giasone alla conquista del vello d’oro: un film tutto effetti speciali, che mi ha letteralmente folgorato. Poi ho adorato John Ford e la grande epopea del western americano, L’uomo che uccise Liberty Valance (1962) è un’opera per me importantissima.
Come i divi, i grandi attori, da Robert Mitchum a Paul Newman, che sono i primi che mi saltano in mente. E Marilyn Monroe, che da ragazzino mi piaceva da pazzi. Però amavo tantissimo anche Bette Davis, straordinaria, grande, grandissima. E quando nel 1972 è venuta in Italia insieme a Joseph Cotten a girare con Luigi Comencini Lo scopone scientifico, a fianco di Alberto Sordi e Silvana Mangano, mi è sembrata una cosa davvero straordinaria. Mi fa sempre questa impressione tutte le volte che dei grandi attori americani arrivano a lavorare qui da noi: trovo sia un modo eccezionale per dimostrare che i legami tra il nostro cinema e quello americano sono molto più forti di quel che pensiamo. Ma arriviamo agli anni ’80, con altri fantastici protagonisti della storia del cinema: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg che hanno segnato una stagione cinematografica fondamentale.
Trovare le ragioni vere della supremazia incontrastata del cinema Usa però non è semplice. Ci hanno provato in tanti, da sempre. Di sicuro è un’industria potente, la seconda più importante del Paese, e questo gli dà più forza, più energia. E ha fatto nascere più scuole. E non si tratta solo di scuola di New York o di Los Angeles, la prima più vicina all’Europa, più “antropomorfica” come direbbe Visconti, la seconda più attenta al consumo e al cinema di “genere”. L’aspetto più importante è che gli americani hanno sempre pensato all’arte del cinema come a una materia da studiare e da insegnare, mentre qui da noi è sempre stata considerata la strada per chi voleva tentare la fortuna. In più in America, a differenza di quel che capita in Europa, non c’è mai stata difficoltà a coniugare contenuti e divertimento. Da noi si è sempre considerato che solleticare il pubblico sia una cosa che non si fa, e così il cinema d’autore ha una casella e quello “di genere” ne ha un’altra. Loro, invece, non hanno mai avuto il complesso di fare film per divertire, sconvolgere, intrattenere gli spettatori. Come non si sono mai preoccupati dei limiti: gli americani fanno i film come si deve e se non hanno i mezzi non li fanno. Noi ci siamo sempre dovuti arrangiare, anche se questo - con tutte le implicazioni positive e negative che ne derivano - ci ha fatto produrre del grandissimo cinema.
Ma c’è un’altra ragione, secondo me, alla base della supremazia del cinema statunitense: è che riesce a ispirarsi e prendere dagli altri senza crearsi problemi. Anzi ammettendolo serenamente. Un esempio: il cinema d’impegno civile degli anni ’70, come Tutti gli uomini del presidente di Alan Pakula (1974) o I tre giorni del condor di Sydney Pollack (1975), ha preso le mosse dal nostro cinema impegnato di quegli anni. In fondo gli americani si sono nutriti di noi più che noi di loro. Sono meno chiusi e settorializzati, più aperti rispetto a noi europei che, condizionati anche dalla storia dei nostri Paesi, siamo sempre costretti a lottare per poter esistere. Sono più aperti in assoluto. Un “vecchio” come Clint Eastwood in Italia farebbe fatica a lavorare. Non gli darebbero una lira per fare un film, come a tutti i nostri grandi vecchi che allo scoccare dei 70 anni hanno cominciato ad avere difficoltà a trovare un produttore.
Sì, certo, c’è l’eccezione di Mario Monicelli, ultranovantenne ancora all’opera: però, quanto ha faticato per fare il suo ultimo film? Fosse stato in America avrebbe lavorato di più e con tempi di attesa molto più brevi. Adesso però anche oltreoceano qualche segno di crisi creativa si intravede. Puntano sui remake (a questo proposito, sta per uscire anche quello del mio Stanno tutti bene, con De Niro al posto di Mastroianni, e io lo aspetto con curiosità e con lo stupore che mi prende tutte le volte in cui un mio film viene amato in Paesi diversi da quello per cui era stato pensato), ripiegano sulla fantascienza e sembra che di quel grande cinema resti poco, che ora ci sia meno grandezza di allora. Stavolta però non è colpa del voler vedere l’ieri meglio dell’oggi, piuttosto dipende forse dall’immane rivoluzione tecnologica che sta trasformando la cinematografia mondiale. E che causa smarrimento.
Giuseppe Tornatore
24 marzo 2009
da: http://www.corriere.it/cinema
"BAARÌA" APRE LA 6ª MOSTRA DI VENEZIA. PARLA IL REGISTA GIUSEPPE TORNATORE
C'ERA UNA VOLTA IN SICILIA
Un secolo di storia nel racconto di una famiglia del paese. Un budget mai visto. «Ma non chiamatelo kolossal».
Tre anni di lavoro, dal giorno in cui riemerse da un cassetto la prima bozza del soggetto. Sei mesi di riprese, intervallati da lunghe pause per problemi meteorologici e organizzativi. Due set principali, uno allestito a Bagheria, presso Palermo, e l’altro a Ben Arous, località a una ventina di chilometri da Tunisi, dov’è stato ricostruito l’antico aspetto del paese siciliano (con il lavoro di 350 carpentieri). Tra professionisti e non, 210 gli attori. Per le scene di massa, 35 mila comparse. E poi 1.500 animali di scena, 2.800 costumi, 1.431 musicisti, 27 temi musicali composti da Ennio Morricone, 300 mila metri di pellicola ridotti a due ore e mezza di film in un anno di lavoro in sala di montaggio. Due edizioni, una in dialetto siculo con sottotitoli e l’altra in italiano.
Bastano i numeri a spiegare lo sforzo produttivo e perciò l’enorme attesa per Baarìa - La porta del vento, pellicola con cui Giuseppe Tornatore è stato chiamato a inaugurare la 66ª Mostra del cinema di Venezia, onore che da vent’anni non toccava a un titolo italiano. Ma c’è di più, molto di più. Perché il regista siciliano che ha vinto l’Oscar nel 1990 col suo secondo film, Nuovo Cinema Paradiso, e ha avuto l’abilità di farsi scoprire da un grande produttore come Franco Cristaldi, è da sempre artista che divide e fa discutere, amato od osteggiato. Uno dei pochi cineasti italiani conosciuti oggi nel mondo i cui film sappiano conquistare pubblico all’estero.
«Siamo in Italia. E a Venezia lo sport più praticato è quello di sparare a zero sui film italiani», dice Tornatore. «Ma io sono in pace con me stesso, so di aver fatto Baarìa con impegno, senza risparmio. È pur vero che mai mi era capitato di mandare a un festival un film appena finito: è come partorire un figlio e mandarlo subito a fare il servizio militare».
- Paura di un salto nel buio?
«Alla Mostra del cinema esistono tre tipologie di spettatori: quelli a cui sto simpatico e vedono ogni mio lavoro con atteggiamento affettuoso; quelli che guardano senza preconcetti e solo dopo giudicano; poi c’è la fazione di coloro i quali, prima ancora di mettere piede in sala, già sanno che odieranno un mio film. Io posso soltanto sperare che i primi due partiti prevalgano sul terzo. Quest’anno, però, è già successo di peggio».
- A che cosa si riferisce?
«Al dilagare di uno strano sport, nato attorno al budget di Baarìa. A me dispiace che gli incidenti capitati durante la lavorazione, i ripetuti problemi meteorologici, le difficoltà impreviste, abbiano fatto lievitare il budget fino a 20 milioni di euro. È stata la mia impresa più complicata, più ancora de La leggenda del pianista sull’oceano. Ma nessun atto di superbia, né voglia di dilapidare denaro. I soldi spesi si vedono tutti. E non è vero che il mio sia il film più costoso della storia del cinema italiano. Basta attualizzare le cifre spese per certi grossi film dell’epoca d’oro. Invece c’è chi, senza cognizione di causa, spara numeri. Tanto per alzare la tensione attorno alla pellicola, esasperando le aspettative. Addirittura, prima del galà a Venezia, ho sentito parlare di 30 milioni di euro! Il costo del film sta lievitando proporzionalmente all’antipatia nei miei confronti. Uno sport che non mi piace. Non penso faccia bene al nostro cinema».
- Ma è vero che lei non avrebbe voluto girare questo film. Almeno non ora?
«La verità è che mi sono sempre portato appresso una montagna di immagini e di personaggi della natìa Sicilia, solo alcuni dei quali finiti in altri miei film. Mi dicevo che sarebbe stato bello farci un’altra pellicola, però solo dopo i 60 anni, con un certo distacco. Invece, ho commesso l’errore di parlarne con i produttori di Medusa. Mi hanno detto: "Facciamolo ora". È stato come cancellare un alibi. Dopo Nuovo Cinema Paradiso, L’uomo delle stelle e Malèna, ho chiuso un’involontaria quadrilogia. Adesso, mi pare di aver distillato tutte quelle cose che sentivo dentro di me e che avevano diritto di essere raccontate».
- Come definirebbe Baarìa?
«La sola etichetta che m’infastidisce è kolossal. C’è chi parla di storia corale, chi di affresco d’epoca o di commedia all’italiana... Io parlerei di una commedia epica. Ci sono l’amore, l’amicizia, il tradimento. Una storia a tratti seria, a tratti divertente. La vena ironica è stata rafforzata dal lavoro degli attori sul set, capaci di far ridere ma anche di far riflettere su certi aspetti della vita nel nostro Paese. Insomma, il tentativo di narrare la storia con la "s" minuscola facendo sentire l’eco di quella con la "S" maiuscola».
- Il film è centrato sulle travagliate vicende di una famiglia di Bagherìa (Baarìa in siculo) dagli anni ’30 ai ’70, con prologo a inizio Novecento ed epilogo ai giorni nostri.
«Quasi un secolo di storia italica per narrare un amore, ma far anche riflettere su che cosa sia cambiato nel nostro Paese. Spesso in peggio».
- Per esempio?
«La concezione stessa della politica. Un tempo vissuta come emancipazione, speranza di un futuro migliore per sé stessi e per i propri figli. Oggi, invece, ridotta a ricettacolo di vizi pubblici e privati, coacervo d’interessi egoistici e di odii primordiali».
Protagonista è Francesco Scianna, alias Peppino, semisconosciuto alla grande platea ma attore strepitoso. Al suo fianco l’esordiente Margareth Madè, nei panni della moglie Mannina. Attorno a loro una pletora di personaggi affidati ad attori di vaglia: da Angela Molina a Lina Sastri, da Lo Cascio a Michele Placido, da Beppe Fiorello a Ficarra e Picone, da Salemme a Raoul Bova, da Monica Bellucci alla Finocchiaro. Ciascuno ruba la scena all’altro, in un gioco a incastri.
- Nessuna defezione?
«Rosario Fiorello ha dovuto rinunciare. In cambio Aldo, senza Giovanni e Giacomo, fa per la prima volta un personaggio cattivissimo».
- Perché ha girato in dialetto? Hanno ragione i leghisti?
«I dialetti, tutti, sono la ricchezza della nostra cultura popolare. Ma vanno insegnati per unire, ritrovare le radici comuni. Non per dividere».
di Maurizio Turrioni
CANNES CLASSICS giovedì 21/05 ore 15.30 Salle du Soixantième
LA VERSIONE COMPLETA E RESTAURATA DI GIÙ LA TESTA DI SERGIO LEONE
Non poteva mancare l’omaggio di Cannes Classics a Sergio Leone nel ventennale della morte: giovedì 21 maggio, ore 15.30, Salle du Soixantième, verrà presentato Giù la testa, nella versione restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata per la Cineteca di Bologna.
Alla proiezione saranno presenti i figli del regista Andrea e Raffaella, e la signora Carla Leone.
Per la Cineteca di Bologna L’Immagine Ritrovata è la terza tappa del cammino voluto dalla famiglia del regista verso il restauro dell’intera opera di Sergio Leone, dopo quelle di Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, già raggiunte assieme a Sky.
GIÙ LA TESTA
di Sergio Leone, 1971
 Soggetto: Sergio Leone, Sergio Donati. Sceneggiatura: Sergio Leone, Sergio Donati, Luciano Vincenzoni. Direttore della fotografia (Technicolor, Techniscope): Giuseppe Ruzzolini. Scene: Andrea Crisanti. Montaggio: Nino Baragli. Costumi: Franco Carretti. Musica: Ennio Morricone. Con: James Coburn (John H. Mallory), Rod Steiger (Juan Miranda), Romolo Valli (Dr. Villega), Maria Monti (Adelita), Franco Graziosi (Governor Jaime), Antoine Saint-John (Gutierez). Prodotto da: Fulvio Morsella/Rafran Cinematografica.
Soggetto: Sergio Leone, Sergio Donati. Sceneggiatura: Sergio Leone, Sergio Donati, Luciano Vincenzoni. Direttore della fotografia (Technicolor, Techniscope): Giuseppe Ruzzolini. Scene: Andrea Crisanti. Montaggio: Nino Baragli. Costumi: Franco Carretti. Musica: Ennio Morricone. Con: James Coburn (John H. Mallory), Rod Steiger (Juan Miranda), Romolo Valli (Dr. Villega), Maria Monti (Adelita), Franco Graziosi (Governor Jaime), Antoine Saint-John (Gutierez). Prodotto da: Fulvio Morsella/Rafran Cinematografica.
Durata: 153’. Colore. Lingua: inglese con sottotitoli francesi.
Il restauro di Giù la testa è stato eseguito a partire dal negativo originale e sulla colonna sonora magnetica della Fondazione Sergio Leone. Questa copia corrisponde alla versione completa che Sergio Leone approvò nel 1971.
Il negativo Techniscope è stato scansionato a una risoluzione di 2k e restaurato digitalmente; la color correction è stata eseguita tenendo come riferimento una stampa positiva del 1971.
La versione sonora inglese è stata restaurata dai materiali magnetici originali utilizzati per il missaggio in mono.
Il film è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna al laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2009, con l’approvazione della Fondazione Sergio Leone.
-----------
«Ho scelto un contesto storico e un genere, il western, come pretesto per parlare di qualcos’altro. I cadaveri nella caverna, la trincea e la fuga del governatore in treno fanno riferimento a episodi ben precisi (che il pubblico italiano conosce) accaduti nella lotta contro il fascismo in Italia, nello specifico, la scoperta di 350 corpi di cittadini ebrei in una cava vicino a Roma e la fuga di Mussolini.
Ancora una volta si rinnova la lezione di Chaplin: con le sue commedie ha detto e fatto molto di più per il socialismo di qualunque politico. La scena della banca con Steiger che guida i prigionieri liberati viene direttamente da Tempi moderni quando Charlie sventola la bandiera rossa tra la folla.
Dato il ruolo centrale che ha la musica di Morricone nei miei film, spesso questi sono stati associati all’opera. Mi sento molto più vicino al grande melodramma e a Omero, o al romanzo picaresco, dove non ci sono eroi, né buoni o cattivi.
Amo i primi piani perché esprimono l’anima. Di solito il cinema li usa per evidenziare un evento particolarmente importante, mentre si tratta della vita stessa: quando parliamo con un’altra persona o la guardiamo, questo è un primo piano. In una diligenza, la camera che si avvicina sempre di più vuole trasformare le facce borghesi in facce da culo. Mentre nel caso del colonnello Gutierez è l’espressione della violenza che monta.
In passato, nessuno è stato capace nel western di afferrare la realtà come John Ford. Ma Ford è un ottimista: nei suoi film, quando un personaggio apre la finestra guarda l’orizzonte con speranza. Io sono un pessimista: è la paura di essere ammazzati che ispira la stessa azione».
Sergio Leone, Maggio 1972 (intervistato da Guy Braucourt).
Ufficio Stampa Cineteca di Bologna: Patrizia Minghetti'
Questa è l'intervista fatta a Cristian Scardigno, un ragazzo con tanti sogni nel cassetto che è riuscito a dirigere un film in Italia.
La prima naturale domanda è stata: Come ti è nato l'amore per il Cinema?
Non saprei identificare questa “nascita” con un giorno o un momento preciso della mia vita. Ricordo un periodo dell’adolescenza in cui vedevo film a ripetizione. Entravo e uscivo dalle videoteche, soprattutto d’estate. Divoravo qualsiasi cosa, specialmente il cinema americano degli anni ’80 e ’90. Quello probabilmente è stato l’inizio di tutto. Allo stesso tempo mi piaceva cimentarmi con la scrittura, non con racconti o poesie, ma solamente con storie che potevano essere visualizzate su uno schermo. Credo di aver fatto i primi tentativi cercando di scrivere nuovi episodi di serie televisive già famose. E’ a quel punto che ho cominciato a pensare che dietro ad un film c’erano delle persone che lavoravano duramente. Con l’università ho deciso definitivamente che questa doveva essere la mia strada.
Quando e come hai deciso di girare il tuo primo corto?
Tolti i maldestri tentativi fino ai 18 anni di girare qualcosa da solo coinvolgendo i miei amici, il primo corto risale al 2007/2008. Avevo appena finito l’accademia di cinema e conosciuto diverse persone che come me avevano voglia di mettersi in gioco. Scrissi in quel periodo “Anch’io ti amo”, un piccolo corto da girare a budget zero in una stanza con due attrici. Troupe ridottissima, tre giorni intensi di lavoro, mezzi tecnici prestati o addirittura creati da zero, nel caso delle luci. E’ stata la mia prima esperienza, la prima volta che mi sono rapportato con attori e troupe.
E come sono nati gli altri due?
Gli altri due sono arrivati in automatico, uno dietro l’altro. Finito di montare il primo, ho subito scritto il secondo corto. Mentre cercavo di promuovere “Anch’io ti amo” con tanta fatica tra i festival, organizzavo la pre-produzione di “Nella sua mente”, girato poi alla fine del 2008. Ho alzato leggermente l’asticella: più persone nella troupe, più attori e ambienti, quasi una settimana di riprese in trasferta, aiutato da un mio amico che mi fece a tutti gli effetti da produttore/organizzatore. Il corto andò abbastanza bene nei festival, arrivarono i primi premi e questo mi aiutò a realizzare il terzo cortometraggio, che fu una vera e propria odissea. Più di un anno di preparazione per girare “La terra sopra di noi” nel 2009 e terminarlo nel 2010. Lì giocavo in casa, nel mio paese, Cisterna di Latina. Era un corto complicato, girato interamente sotto grotte profonde decine di metri, ambientato durante la seconda guerra mondiale, con più di 100 persone coinvolte tra troupe, cast principale e comparse. Fu un’esperienza indimenticabile. Un corto che ho prodotto personalmente con l’aiuto di istituzioni e sponsor locali. Numericamente è ancora il corto che mi ha portato in più festival, oltre 30 in tutto il mondo, con almeno una decina di premi vinti.
E cosa hai pensato quando un produttore inglese ti ha chiesto di girare un suo lungo (Teen Star Academy) per le sale, un film che ha ottenuto ottime recensioni?
C’era già stato il mio esordio nel lungometraggio con “Amoreodio”. Un’altra lunga avventura produttiva durata oltre tre anni, che mi ha portato sia in festival internazionali di prestigio (anteprima mondiale a Montreal, Canada, in concorso a Festroia, Portogallo, un premio ad Annecy in Francia) che nelle sale cinematografiche italiane. Quando mi è stato proposto di fare un film per ragazzi, inizialmente mi è sembrato molto strano, perché avevo a che fare con un’esperienza nuova e assolutamente lontana dalle mie corde. Arrivavo da un film drammatico che avevo prodotto, scritto, diretto e curato in ogni minimo particolare. Stavolta si trattava di una sfida, poichè mi veniva chiesto semplicemente di curare la parte tecnica, partendo da una sceneggiatura già scritta, un casting già organizzato e location già scelte. E’ il tipico caso di un film che appartiene al produttore e allo sceneggiatore piuttosto che al regista. La differenza stilistica e narrativa con altri prodotti che ho diretto è evidente. E’ stata sicuramente un’esperienza che mi ha fatto crescere.
E quando hai saputo che dovevi dirigere un grande attore americano come John Savage?
Inizialmente c’era euforia e anche un po’ di tensione. Il solo pensiero di stare sul set con un attore di quel calibro mi metteva un po’ di agitazione. Poi è bastata la presentazione, una stretta di mano e cinque minuti dopo eravamo già a girare il primo ciak. John ti mette a tuo agio e soprattutto è sempre a completa disposizione. E questo vale sia nel rapporto avuto con me sia con tutti i ragazzi della troupe. C’è stato un grande rispetto reciproco e non dimenticherò mai i suoi complimenti nei miei confronti a film finito. Quello probabilmente è il ricordo che mi porterò dietro per sempre.
---------------------------------------
SINOSSI “ANCH’IO TI AMO”
Due ragazze in una stanza. Un passato che irrompe, trascinandole sull’orlo di una crisi esistenziale. Quale sarà la conseguenza delle loro azioni? Un intreccio tra passato, presente e futuro. Uno sguardo su due donne innamorate. Un incubo d’amore.
SINOSSI “NELLA SUA MENTE”
Un uomo esce di casa con la propria famiglia. Una ragazza scatta foto artistiche in una piazza. L’incontro tra l’uomo e la ragazza è casuale, ma significativo per le vite di entrambi. I due incrociano lo sguardo per un attimo che sembra una vita. Nei loro occhi ci sono sentimenti oscuri che riacutizzano vecchi incubi.
SINOSSI “LA TERRA SOPRA DI NOI”
Cisterna di Latina, 22 gennaio 1944. Per sfuggire ai bombardamenti, Francesca si rifugia insieme a sua madre e ad altre centinaia di persone all’interno di grotte situate decine di metri sotto la superficie. Lì trascorreranno giorni interminabili di paura, dolore e speranza.
SINOSSI “AMOREODIO”
Katia, 17 anni, apatica e frustrata, trascorre le giornate in compagnia del suo ragazzo, Andrea. Quando non è con lui, incontra di nascosto altri ragazzi, guarda video proibiti su internet e litiga continuamente con i propri genitori. La monotonia del piccolo paese in cui vive, la trascina in un vortice di immoralità e trasgressione che, insieme ad Andrea, la porterà ad un tragico epilogo.
DATI DEL FILM "TEEN STAR ACADEMY"
- Regia: Cristian Scardigno
- Cast: John Savage, Bret Roberts, Blanca Blanco, Youma Diakite, Adriana Volpe
- Genere: Commedia musicale, colore
- Durata: 90 minuti
- Produzione: Movieon
- Distribuzione: Fourlab
- Data di uscita: 8 giugno 2017
Questo il trailer del film:
{jcomments on}
', 1, 11, 0, 38, '2017-06-21 08:47:15', 63, 'R.F.', '2017-06-21 10:31:25', 63, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2017-06-21 08:47:15', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 13, 0, 7, '', '', 0, 4478, 'robots=\nauthor='),
Ha detto che per fare film servirebbe prima studiare arte per tre anni e che, tra l'altro, «il cinema non è un mezzo adatto alla narrazione». Il suo primo cortometraggio – Death of Sentiment, del 1962 – è stato girato in quattro cimiteri di Londra. Il primo lungometraggio l’ha diretto negli anni Ottanta, dopo aver studiato, dipinto, scritto e lavorato come montatore e regista di cortometraggi (suoi) o documentari (di altri).
 Peter Greenaway è un regista, ma anche un artista: soprattutto pittore, ma non solo. E anche da regista è uno da film strani, complicati, di nicchia e d’autore. Ha fatto tante cose nel cinema e anche fuori dal cinema, o al confine tra il cinema e l’arte più concettuale. Greenaway – nato a Newport, in Galles, il 5 aprile 1942 – prima e durante la sua carriera da regista di lungometraggi cinematografici (i film) è stato, ha fatto e ha detto tante altre cose. Il primo lungometraggio l’ha diretto negli anni Ottanta, dopo aver studiato, dipinto, scritto e lavorato come montatore e regista di cortometraggi (suoi) o documentari (di altri).
Peter Greenaway è un regista, ma anche un artista: soprattutto pittore, ma non solo. E anche da regista è uno da film strani, complicati, di nicchia e d’autore. Ha fatto tante cose nel cinema e anche fuori dal cinema, o al confine tra il cinema e l’arte più concettuale. Greenaway – nato a Newport, in Galles, il 5 aprile 1942 – prima e durante la sua carriera da regista di lungometraggi cinematografici (i film) è stato, ha fatto e ha detto tante altre cose. Il primo lungometraggio l’ha diretto negli anni Ottanta, dopo aver studiato, dipinto, scritto e lavorato come montatore e regista di cortometraggi (suoi) o documentari (di altri).
Greenaway ha fatto film con un particolare approccio alla composizione delle inquadrature, alla luce, ai contrasti; e con tantissimi riferimenti alla pittura e alla sua storia. Ha fatto film di quelli che non passano al multisala, ha sperimentato molto, ha usato spessissimo il numero 92 (è anche appassionato di numerologia), ha toccato temi drammatici (a volte con approccio umoristico), ha fatto film che secondo i critici mostrano una chiara influenza rinascimentale, barocca e della pittura fiamminga, ha fatto installazioni multimediali di vario tipo, ha detto molte cose piuttosto drastiche sul cinema.
Per esempio: «Penso che nessun giovane cineasta agli inizi dovrebbe avere il permesso di usare una macchina da presa o una videocamera senza avere prima frequentato tre anni di una scuola d’arte». Del cinema ha detto anche – in una frase riportata in varie versioni, ma il cui concetto è sempre quello – che non lo ritiene un «mezzo adatto alla narrazione» perché «se vuoi raccontare una storia, è meglio che tu faccia il romanziere». Quando nel 1993, sul set del suo film Il bambino di Mâcon, alcuni suoi attori gli fecero notare che nel film che stava girando c’erano errori di continuità (quella cosa per cui, per esempio, se un personaggio indossa una maglietta rossa in una scena non può averla blu in quella subito dopo, senza che la cosa sia mostrata o motivata) rispose: «La continuità è noiosa». Queste frasi già potrebbero dare un’idea di che tipo sia Greenaway; un’idea un po’ più dettagliata la danno aneddoti, sintesi di alcuni suoi film, video dei suoi cortometraggi, curiosità e cose da sapere.
- È nato in Galles ma dopo pochi anni la famiglia si spostò nell’Essex, in Inghilterra. Suo padre era appassionato di ornitologia e uno dei suoi primi cortometraggi è intitolato Un viaggio attraverso H (La reincarnazione di un ornitologo)
- Il suo primo cortometraggio – Death of Sentiment, del 1962 – è stato girato in quattro cimiteri di Londra
- Tra i suoi film preferiti ci sono L’anno scorso a Marienbad (di Alain Resnais del 1961) e Il settimo sigillo (di Ingmar Bergman, del 1967), quello che – disse – gli fece venir voglia di fare il regista. Ha anche detto di apprezzare molto l’attrice francese Delphine Seyrig, morta nel 1990
- Ha detto di aver smesso di fare documentari dopo che, a fine anni Sessanta, vide il regista del documentario di cui era assistente che diede della colla da far sniffare a un bambino, per girare una scena che altrimenti non avrebbe potuto girare come avrebbe voluto
- Dalla metà degli anni Novanta vive ad Amsterdam
- Ha lavorato per 15 anni come montatore, documentarista e aiuto regista per il Central Office of Information, un ente del governo britannico. Tra i cortometraggi fatti in quegli anni: uno su un treno, uno su un albero che cresce in mezzo all’asfalto, uno sulle mappe di un paese che non esiste, uno (scrive MyMovies) «su tredici cicli di tredici secondi che mostrano per tre volte le stesse immagini di Venezia, montate però su colonne sonore differenti» e Windows:
- Intanto, dipingeva, scriveva romanzi, faceva illustrazioni e scriveva recensioni cinematografiche
- È esperto di musica (le colonne sonore sono parte rilevante di molti suoi film) e ha collaborato molto spesso con il compositore Michael Nyman
- Nei suoi film c’è un personaggio immaginario e ricorrente: lo scienziato Tulse Luper
- Gli piacciono molto le inquadrature centrate
-
Queste sono invece poche righe per farvi nel caso venir voglia di vedere o rivedere alcuni dei suoi lungometraggi:
- I misteri del giardino di Compton House è ambientato nel Diciassettesimo secolo e parla di un pittore che finisce in mezzo a varie vicissitudini della famiglia che gli ha commissionato un dipinto. Un film con temi che molti critici hanno paragonato a quelli di Blow Up di Michelangelo Antonioni
- Lo zoo di Venere è drammatico e grottesco (come altri film di Greenaway) e parla degli esperimenti di due zoologi e, così, tra le altre cose, ripercorre le tappe dell’evoluzione così come le individuò Charles Darwin. Contiene la frase: «Pensi che la zebra sia un animale bianco con strisce nere o un animale nero con strisce bianche?». Inizia così:
-
- Il ventre dell’architetto parla di un architetto arrivato a Roma, ed è strapieno di simboli e riferimenti all’architettura classica.
- Giochi nell’acqua parla di (SPOILER) tre donne – nonna, madre e figlia – che uccidono i mariti, con scene che, dicono i critici, ripercorrono la storia dell’arte.
- Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante è ispirato a due quadri: La cena in casa Levi di Veronese e Il banchetto degli ufficiali del corpo degli arcieri di San Giorgio di Hals.
- 8 donne e 1/2 è un omaggio a 8½ di Federico Fellini e parla, tra le altre cose, delle fantasie sessuali dell’immaginario maschile
- Nightwatching, del 2007, gira tutto intorno al quadro Ronda di notte di Peter Greenaway
Articolo de ilpost.it (5/4/2017)
 Moriva a Roma il 13 marzo Lucio Fulci paroliere, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e produttore italiano, uno dei più grandi e versatili del cinema di genere. I suoi film, spesso prodotti con budget limitati, sono dei veri e propri cult che hanno segnato la storia del cinema mondiale, grazie al suo stile inconfondibile incentrato sullo stravolgimento dei profili classici dei generi cinematografici che provoca e sciocca gli spettatori. Spesso è stato omaggiato nel cinema, nella musica e nei fumetti.
Moriva a Roma il 13 marzo Lucio Fulci paroliere, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e produttore italiano, uno dei più grandi e versatili del cinema di genere. I suoi film, spesso prodotti con budget limitati, sono dei veri e propri cult che hanno segnato la storia del cinema mondiale, grazie al suo stile inconfondibile incentrato sullo stravolgimento dei profili classici dei generi cinematografici che provoca e sciocca gli spettatori. Spesso è stato omaggiato nel cinema, nella musica e nei fumetti.
Oltre alla propria carriera cinematografica, Fulci è stato attivo anche come paroliere, scrivendo dei classici della musica leggere quali “24.000 baci” e “Il tuo bacio è come un rock” (ambedue cantate da Adriano Celentano) e come autore di racconti brevi.
Lucio Fulci, infatti, inizia la sua carriera nei musicarelli con I RAGAZZI DEL JUKE-BOX (1959) e URLATORI ALLA SBARRA (1960), entrambi con Celentano, dopo esser stato assistente di regia in alcuni peplum, aver realizzato dei documentari sull'arte ed essersi diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Nato nella capitale, il 17 giugno 1927, poco più che trentenne esordisce, per caso, alla regia nel 1959 con una commedia il cui interprete principale è Totò: I LADRI. L'attore e Fulci già si conoscevano in quanto il regista, qualche anno prima aveva scritto diverse sceneggiature che vedevano Totò come protagonista.
Dagli anni '60 Fulci dirige film comici, parodie (molte interpretate da Franco e Ciccio) e commedie sexy all'italiana, tra cui LA PRETORA, cult che presenta per la prima volta nel 1976 un nudo integrale di Edwige Fenech e che inaugura il filone del poliziesco-giudiziario erotico, grazie anche alle indimenticabili scene della doccia e dei molteplici nudi espliciti.
Nello stesso periodo inizia a dirigere anche alcuni spaghetti western tra cui LE COLT CANTARONO LA MORTE E FU...TEMPO DI MASSACRO (1966) con Franco Nero, scritto da Fernando Di Leo, considerato ancora oggi uno dei western più cruenti della storia. Seguirono ZANNA BIANCA (1973) dedicato alle famiglie e I QUATTRO DELL'APOCALISSE (1975), interpretato da Tomas Milian. Quest'ultimo film è pregno di scene splatter, cannibalismo e stupri.
 Negli anni '70 si cimenta nel giallo, altro genere che lo contraddistingue dagli altri registi. Particolari sono UNA LUCERTOLA CON LA PELLE DI DONNA (1971), la cui scena dei cani vivisezionati è rimasta impressa a molti (cani finti costruiti dal grande Carlo Rambaldi), SETTE NOTE IN NERO (1977), dai profondi aspetti psicologici e pieno di momenti onirici, il capolavoro NON SI SEVIZIA UN PAPERINO (1972), thriller ambientato nel profondo sud Italia. Il film ha una grande importanza economica-produttiva in quanto è stato il primo realizzato dalla neo casa di produzione Medusa Film. Grazie a questi film Fulci inizia a dare del filo da torcere a Dario Argento, in quanto i suoi film se pur rientravano nella categoria horror, riscuotevano un ottimo successo di pubblico grazie allo stile macabro, splatter e anticonformista. Fulci è stato un caso particolare, per la sua capacità di uscire dagli stereotipi e creare qualcosa di innovativo che la maggior parte dei film di allora non avevano, alcune sue trovate sono talmente geniali che anni dopo gli viene attribuito il soprannome di “terrorista dei generi”.
Negli anni '70 si cimenta nel giallo, altro genere che lo contraddistingue dagli altri registi. Particolari sono UNA LUCERTOLA CON LA PELLE DI DONNA (1971), la cui scena dei cani vivisezionati è rimasta impressa a molti (cani finti costruiti dal grande Carlo Rambaldi), SETTE NOTE IN NERO (1977), dai profondi aspetti psicologici e pieno di momenti onirici, il capolavoro NON SI SEVIZIA UN PAPERINO (1972), thriller ambientato nel profondo sud Italia. Il film ha una grande importanza economica-produttiva in quanto è stato il primo realizzato dalla neo casa di produzione Medusa Film. Grazie a questi film Fulci inizia a dare del filo da torcere a Dario Argento, in quanto i suoi film se pur rientravano nella categoria horror, riscuotevano un ottimo successo di pubblico grazie allo stile macabro, splatter e anticonformista. Fulci è stato un caso particolare, per la sua capacità di uscire dagli stereotipi e creare qualcosa di innovativo che la maggior parte dei film di allora non avevano, alcune sue trovate sono talmente geniali che anni dopo gli viene attribuito il soprannome di “terrorista dei generi”.

Negli anni '80 Fulci ha avuto diversi progetti incompiuti a causa di diverse questioni, compresi quelli commissionati dell'Alpha Cinematografica, che gli commissiona alcune supervisioni di pellicole horror, alcune delle quali non vanno in porto. In questo decennio sperimenta anche il fantasy e il post-atomico nei quali inserisce alcune scene horror. Stessa storia accade per il noir-poliziesco LUCA IL CONTRABBANDIERE (1980) il quale contiene scene molto violente e crude.
Gira i suoi ultimi film negli anni '90, nonostante la malattia che già l'aveva colpito nel decennio precedenti.
Muore a Roma, il 13 marzo 1996, mentre sta preparando il suo successivo film horror in collaborazione con Dario Argento, LA MASCHERA DI CERA, poi diretto dal curatore degli effetti speciali Sergio Stivaletti.
Articolo di Eleonora Gasparotto Nascimben per Manifesto 0
Oddo Bernardini è un celebre operatore di macchina, con oltre 100 film all'attivo. La sua carriera inizia a Roma nel 1961 quando, poco meno che ventenne, affascinato dal mestiere del padre Bianco Bernardini (meccanico cinematografico e operatore di macchina di film degli anni ’50) inizia a lavorare sui set di Cinecittà. Gli incontri professionali, gli aneddoti divertenti, le curiosità: nello straordinario archivio della memoria di Oddo Bernardini c'è un segmento fondamentale della storia del nostro cinema. Iniziamo questo viaggio cinefilo partendo proprio dai suoi primi passi sul set.
Ho iniziato questo mestiere per caso. Andavo a scuola, facevo il quarto anno di Elettrotecnica e, oggi come allora, balbettavo, ma molto più di adesso. Una professoressa quell’anno mi prese di punta: io studiavo, ma non riuscivo a esprimermi, così durante le interrogazioni non aprivo bocca e mi rimandava al banco con un due. Per la frustrazione ho cominciato a bigiare, a “fare sega” come si dice a Roma, e ho passato l’inverno ai giardinetti, al freddo, sotto la pioggia. A un certo punto presi coraggio e dissi a mio padre che volevo lasciare la scuola e intraprendere il suo mestiere.
Mio padre, nato a Pavia e operaio della Necchi, si era trasferito a Roma dove lavorava a Cinecittà riparando le macchine da presa. All’inizio era molto deluso, temeva che non fossi all’altezza del mestiere, ma poi si convinse e mi prese con lui sul set. Per i primi tre mesi spazzai per terra e poco altro. Nel 1961, dopo qualche mese di apprendistato accanto a mio padre, cominciai a lavorare da solo al primo film. Ero talmente agitato che non ricordo neppure il titolo: era un film americano e lavorai 88 giorni nei magazzini a caricare pellicola. Ero troppo timido per farmi vedere sul set: la mia balbuzie mi faceva vergognare e quando mi chiamavano mi nascondevo.
Solo qualche anno più tardi ho capito che per lavorare nel mondo del cinema avrei dovuto mettere da parte le mie paure e buttarmi nella mischia. All’inizio mi sono occupato soprattutto di film musicali, i cosiddetti “musicarelli” con cantanti pop come Gianni Morandi, Al Bano, Caterina Caselli. Il mestiere dell’operatore l’ho imparato da autodidatta. Mio padre aveva una squadra di sette-otto persone che lavoravano con lui sui set: cercavo di seguire il loro lavoro, ma spesso era difficile trovare risposte alle mie domande teoriche. Così ho cominciato a studiare sui libri di notte, con grande fatica, anche perché un conto è leggere e un conto è applicare la teoria alla pratica: però leggendo i concetti restano molto più in mente.
In tutto ho fatto 100 film in venticinque anni di carriera e “Caroselli” a bizzeffe. In sostanza, ho cominciato a fare l’aiuto, caricando la pellicola nei magazzini, poi l’assistente operatore e alla fine sono diventato operatore di macchina. Da un set all’altro, ho avuto lo straordinario privilegio di lavorare con grandi attori e grandi registi: da Ettore Scola a Dino Risi, da Nanni Loy a Franco Zeffirelli. Il mio racconto comincia qui.
A cura di: Camilla Maccaferri di Oddo Bernardini per farefilm.it
La prima l'ho scritta quando avevo vent'anni, era il sequel di Easy Rider, ma l'ho persa in un aereo. La seconda, Curios — negozio di cianfrusaglie — doveva essere il seguito ideale di Strada a doppia corsia di Monte Hellman. Era la storia della morte di una città, quando arrivava l'autostrada...
 Michael Tolkin ha diretto due film, The Rapture (1991, edito in cassetta come Sacrificio fatale), e The New Age (The New Age — Nuove tendenze, 1994). Ha scritto due romanzi, The Player (1990) e Among the Dead (1993), tradotti presso Bompiani come I protagonisti e Il sopravvissuto. Ha scritto le sceneggiature, oltre che dei suoi film, di Gleaming the Cube (1989, California Skate) di Graeme Clifford, Deep Cover (Massima copertura, 1992) di Bill Duke e The Player (I protagonisti, 1992) di Roberto Altman. Come romanziere, Tolkin ama mettere i suoi personaggi nelle situazioni più sgradevoli, per portare alla luce i lati più oscuri e inquietanti della loro personalità. Immaginate come scriverebbe Patricia Highsmith se fosse un uomo, e molto, molto più cattiva di quello che è già. Come regista e sceneggiatore, Tolkin parte da argomenti forti e sociologicamente connotati (la follia dei fondamentalisti religiosi in The Rapture, la crisi dei nuovi ricchi in The New Age), portando la storia verso esiti imprevedibili. Girare finti film a tesi, e scegliere l'ambiguità (in The Rapture l'Apocalisse accade veramente) significa tagliarsi ogni possibilità di successo commerciale, a Hollywood e non solo. Ma ciò che rende interessante parlare con Tolkin è anche la sua posizione di indipendente che si confronta con gli Studios, interno ed esterno al sistema: come pochi, oggi (il primo nome che viene in mente è quello di Oliver Stone), sanno fare senza compromessi.
Michael Tolkin ha diretto due film, The Rapture (1991, edito in cassetta come Sacrificio fatale), e The New Age (The New Age — Nuove tendenze, 1994). Ha scritto due romanzi, The Player (1990) e Among the Dead (1993), tradotti presso Bompiani come I protagonisti e Il sopravvissuto. Ha scritto le sceneggiature, oltre che dei suoi film, di Gleaming the Cube (1989, California Skate) di Graeme Clifford, Deep Cover (Massima copertura, 1992) di Bill Duke e The Player (I protagonisti, 1992) di Roberto Altman. Come romanziere, Tolkin ama mettere i suoi personaggi nelle situazioni più sgradevoli, per portare alla luce i lati più oscuri e inquietanti della loro personalità. Immaginate come scriverebbe Patricia Highsmith se fosse un uomo, e molto, molto più cattiva di quello che è già. Come regista e sceneggiatore, Tolkin parte da argomenti forti e sociologicamente connotati (la follia dei fondamentalisti religiosi in The Rapture, la crisi dei nuovi ricchi in The New Age), portando la storia verso esiti imprevedibili. Girare finti film a tesi, e scegliere l'ambiguità (in The Rapture l'Apocalisse accade veramente) significa tagliarsi ogni possibilità di successo commerciale, a Hollywood e non solo. Ma ciò che rende interessante parlare con Tolkin è anche la sua posizione di indipendente che si confronta con gli Studios, interno ed esterno al sistema: come pochi, oggi (il primo nome che viene in mente è quello di Oliver Stone), sanno fare senza compromessi.
La sua prima sceneggiatura che è stata realizzata...
... è stata la settima o l'ottava che ho scritto, Gleaming the Cube. La prima l'ho scritta quando avevo vent'anni, era il sequel di Easy Rider, ma l'ho persa in un aereo. La seconda, Curios — negozio di cianfrusaglie — doveva essere il seguito ideale di Strada a doppia corsia di Monte Hellman. Era la storia della morte di una città, quando arrivava l'autostrada, ma non mettevano un'uscita. La spedii a Spielberg, mi disse di mandargli qualcos'altro, ma non l'ho mai fatto (ride)... forse quando ne avevo scritto un'altra era già diventato troppo famoso. Poi sono entrato in un periodo in cui cercavo di essere commerciale, finché ho scritto una buona sceneggiatura con mio fratello, un incrocio di Piombo rovente e La dolce vita. Ne sono stati girati venti minuti a Londra, il regista era Don Boyd, ma poi il budget si è dileguato.
Come è andata con Gleaming the Cube?
L'ho venduta in tre giorni. Il mio agente l'ha letta, non ne era troppo convinto, e voleva vendere solo l'opzione per un anno. Il mio legale ha detto no, meglio venderla subito. Per l'epoca ho preso molti soldi. I produttori erano Lawrence Turner, David Foster e David Spiegelman per la Twentieth Century Fox. Il film è andato abbastanza bene, specialmente in video.
È stato soddisfatto del risultato finale?
Il film l'ha diretto Graeme Clifford, e mi ha deluso. Se avesse avuto più successo, mi avrebbero fatto scrivere un film d'azione a grosso budget, ma non era quello che cercavo. La sceneggiatura comunque è stata riscritta, anche se sono stato accreditato solo io.
Perché a Hollywood si usa spesso far riscrivere le sceneggiature?
Una delle mie teorie è che gli Studios non si fidano di un solo sceneggiatore. A loro interessa vedere quanto può essere peggiorata una storia: se può essere fatta a pezzi e sta ancora in piedi, vuol dire che resisterà anche al giudizio del pubblico; ma se la storia è fragile, e non sopporta che troppi ci lavorino, vuol dire che non va bene. A parte questo, è molto difficile per una persona sola prendere le distanze dal proprio lavoro, e vedere il film nel suo complesso. Oppure, quando si inizia a girare il film, alla star non piace il copione, e vuole battute migliori. Ci sono alcuni — pochi — che ogni anno guadagnano qualche milione di dollari per riscrivere sceneggiature, e molto spesso non sono accreditati.
Che cosa è stato modificato in Gleaming the Cube?
Christian Slater è un punk — il film l'ho scritto nell'85 — che indaga sulla morte del fratellastro, un orfano vietnamita, che è stata mascherata da suicidio. Per risolvere il crimine dove fare finta di non essere più punk, si taglia i capelli, si toglie gli orecchini, ma ogni notte esce col suo skateboard, un po' come Zorro. Nella mia storia era importante questo cambiamento tra giorno e notte: ogni volta era come se tradisse se stesso o i genitori. E questo è scomparso. Poi c'era un poliziotto che si compromette aiutando Christian. L'unico modo per giustificare il fatto era che avesse quasi la stessa età, che fosse il più giovane possibile per un poliziotto. Invece hanno preso un attore di 32 anni, è rimasto solo il cliché.
Quando ha scritto The Rapture pensava di dirigerlo lei?
Era fuori discussione, lo volevo dirigere io. Se non ci fossi riuscito, ne avrei tratto un romanzo. Ma non penso che nessun altro avrebbe voluto dirigerlo.
Qual era l'idea di partenza?
Avevo visto un adesivo su un paraurti che diceva: "Attenzione, in caso di rapimento in cielo [rapture] questa vettura sarà priva del conducente". I cristiani evangelici credono che coloro che sono rinati, Dio li trasformerà istantaneamente in spiriti prima della battaglia di Armageddon, e li trasporterà in cielo senza fargli soffrire la morte fisica. Secondo le statistiche più recenti, il 61% degli americani crede che questo succederà. quando ho scritto il film, erano il 39%. Avevamo queste cifre da sbandierare ai produttori, per mostrare che l'argomento aveva un pubblico. E poi mi sono messo a guardare la Tv evangelica via cavo. Soprattutto quando parlano dei media, la loro critica culturale può essere interessante, anche se non sono d'accordo con la cura che propongono. Cercavo di capirli, anziché disprezzarli, come fanno tutti quelli di sinistra.
Come ha fatto a girare The Rapture?
Nick Wechsler, che aveva prodotto Sesso, bugie e videotape, ha letto The Rapture in una versione più breve, e mi ha detto di scriverlo per esteso per trovare i soldi. Tannenbaum e Parker sono andati alla New Line, abbiamo avuto molti incontri, ma in pratica si sono decisi dopo che ha accettato la parte Mimi Rogers. Aveva appena divorziato da Tom Cruise, e pensavano che lo scandalo avrebbe aiutato il film.
Come è andato il film?
Male nelle sale, meglio in video. Certi l'hanno odiato, altri l'hanno amato molto. Un rabbino mi ha detto che dimostrerebbe la malvagità del Dio cristiano. Sulla Tv via cavo ha avuto tante repliche quanto i film più importanti. I distributori non sanno mai cosa fare dei miei film, avevano dei problemi anche con I protagonisti, che è andato bene, ma poteva andare meglio.
Che budget ha avuto per The Rapture?
Tre milioni di dollari, che per me erano moltissimi. Ci sono certe cose che non ho potuto fare, non ho girato la scena del rapimento in cielo: avrei dovuto avere i soldi per rifare tutta un'autostrada, ma avrebbe rischiato di essere troppo kitsch. Se l'intenzione è chiara, credo, l'esecuzione o lo stile importano di meno. Penso che per un po' non mi daranno molti soldi, e se si possono suggerire le cose è meglio. La gente finisce anche per stancarsi. Perché Natural Born Killers è migliore di True Lies? True Lies non solo è stupido e razzista, ma ha anche gli effetti speciali più complicati mai visti. Ma sono completamente inutili.
Qual era l'idea di partenza dei Protagonisti?
Quando ho iniziato a scrivere non ero tanto interessato a Hollywood, quanto all'idea di colpa, come è cambiata nel ventesimo secolo. Per Dostoevskij la colpa non scompare mai, per Kafka c'è anche se non hai fatto nulla. L'America contemporanea, specialmente i repubblicani, i tecnocrati, hanno trasceso il senso di colpa. Non penso siano perseguitati da brutti sogni. Se dovessi dare un altro titolo a The Player, lo chiamerei Il repubblicano.
Come ha lavorato con Altman?
Siamo andati d'accordo. Altman è famoso per non andare d'accordo con gli sceneggiatori. Ovviamente lui e gli attori hanno cambiato molto, ma la cosa buffa è che la maggior parte dei cambiamenti non sono finiti sullo schermo. Vedendo i giornalieri ero inorridito da alcune improvvisazioni, ma ho capito che era il suo modo: sperimentava, non funzionava, buttava via. Alla fine sono rimaste solo le scene che servivano per il racconto. E stata una lezione. Nella maggior parte dei film che si girano, il dieci-quindici per cento della sceneggiatura viene buttata via in sala montaggio: che è un bello spreco. Una volta si diceva, un po' per scherzo, che una pagina di sceneggiatura equivale a un minuto di film. Oggi la gente è così lenta che siamo sul minuto e mezzo. La cosa più furba sarebbe fare sceneggiature di 90-95 pagine anziché 110.
È soddisfatto di Massima copertura?
È stata un'altra delusione. L'avevo scritto dopo The Rapture, ed è stato riscritto da Henry Bean mentre dirigevo il mio primo film. Aveva bisogno di essere girato più alla grande, con altri 3-4 milioni. Sono contento perché comunque non è un poliziesco come tanti: è rimasto il rapporto tra il nero e l'ebreo — non il nero e il bianco — e il tema di essere corrotti mentre si cerca di scoprire la corruzione. Lo so che è buffo citare Adorno in proposito, ma quando l'ho scritto mi sono ricordato di una sua frase, che per conoscere veramente il male bisogna fare esperienza del male, e quindi esserne toccati.
Che cosa è stato cambiato?
Il personaggio dell'avvocato corrotto, Jeff Goldblum all'inizio era più grigio: era il poliziotto, Larry Fishburne, a fargli scoprire la vita in grande stile. Il personaggio che viene buttato fuori dalla limousine in origine veniva inseguito fin dentro in un ospedale e gli sparavano in una sala operatoria: mentre moriva, inciampava sul tavolo operatorio dove era in corso un'operazione a cuore aperto, e il cuore del paziente cadeva sul pavimento (ride). Adesso ne posso ridere, ma sapevo che se fosse stata girata sarebbe stata una scena memorabile. Ciò che è divertente in una scena del genere è il fatto che è tanto disgustosa, ed è tanto disgustosa non solo per il fatto di vedere l'immagine del cuore, ma per il fatto che l'abbia pensato qualcuno, e abbia osato farla.
Approfittiamone per dire qualcosa sulla violenza...
Ci sentiamo tutti molto superiori al pubblico degli spettacoli dei gladiatori, ma non credo che sia tanto diverso quando si prova piacere nel vedere cose truculente sullo schermo. Una parte del piacere di scrivere o vedere una scena violenta è il piacere della trasgressione, non solo meccanico, ma emotivo. E come la pornografia. C'è un regista, Andrew Blake, che ho scoperto in un canale porno della Tv via cavo di un albergo, e che oggi pare sia il migliore nel suo genere. Nel film che ho visto c'era una scena in cui una donna ne scopa un'altra con un fallo di ghiaccio. Un'altra volta, penso che sia interessante non solo l'immagine, quanto che qualcuno l'abbia pensata e realizzata; ma ciò che la rende eccitante, penso, è che a un certo livello tutti sappiamo che non dovremmo guardare queste cose.
Mi ricordo il culmine emotivo del suo romanzo Il sopravvissuto, quando il protagonista riconosce all'obitorio i cadaveri sfigurati della moglie e della figlia.
Ero consapevole di quanto stavo facendo. Ho due figlie, e all'inizio la bambola della bambina del libro si chiamava corna la bambola di mia figlia. Mi chiedevo: posso farlo? Posso spingermi così lontano? Non so se sia un bene. Un'ideologia dice di sì, ma non ne sono più tanto sicuro.
Da dove viene l'idea di The New Age?
L'idea era come l'amore possa sopravvivere ai problemi economici... (ride). Mi interessava il rapporto tra amore e denaro, e poi il fatto che in America la gente si rovini la vita dopo avere assorbito un paio di idee filosofiche o religiose, quante ce ne possono stare su una t-shirt.
Che cosa ha fatto Oliver Stone?
È stato uno dei produttori esecutivi, ha messo i soldi, ha sostenuto il film. Mi spiace per lui che non abbia guadagnato. E costato 7 milioni di dollari e mezzo, è andato al festival di Toronto, ma è stato distribuito dalla Warner Brothers in appena quindici città. L'hanno tenuto nascosto. Non posso dire che li odio, ma non erano adatti a distribuirlo. Per loro è più semplice spendere 5 milioni di dollari per promuovere un film, che 200.000 nel modo giusto.
Che cosa pensa della censura oggi negli Stati Uniti?
Ce n'è poca, e ce ne dovrebbe essere di più. Forse credo nella censura perché aiuta la clandestinità. Con la censura giusta rimarrebbero solo i più forti (ride) e allora si vedrebbe chi vuole affrontare veramente argomenti scomodi. Io ho subìto la censura del box office, e non voglio certo che ritorni Torquemada, ma penso che sia un peccato che non ci sia più un underground. Il pasto nudo era un libro migliore quando era più difficile da trovare. Adesso che si trova tutto, non c'è più opposizione, e il 61% degli americani non si preoccupano della giustizia o del sistema scolastico: perché investire nel futuro se non c'é futuro, se Dio da un giorno all'altro ti può prendere in cielo? La conseguenza politica è che nelle ultime elezioni abbiamo avuto una maggioranza di repubblicani privi di senso di colpa. E proprio come Shampoo di Hal Ashby: sembra che parli dei problemi di questo stupido parrucchiere, ma intanto viene eletto Nixon. Quelli che dovrebbero tenere gli occhi aperti si crogiolano nell'autocommiserazione, e lasciano che arrivino i mostri.
a cura di Alberto Pezzotta
Testo e immagini da Dentro e fuori Hollywood tra scrittura e regìa in SegnoCinema n.73 Mag/Giu 1995
Ecco perché nel "cinema" lavorare in "équipe" è indispensabile per un buon prodotto. Ognuno nella propria qualifica senza i suoi collaboratori si sente un po' perso, perché nessuno è prescindibile dagli altri. Formare una troupe, per un determinato film, significa mettere insieme capi reparto e maestranze che vadano professionalmente all'unisono.
Tempo fa incontrai Pierino Tosi.
Parlando del più e del meno, sempre inerente al nostro lavoro, gli feci la solita domanda che tanto vuol dire e anche nulla: "come va?"
Mi rispose con il suo solito innato garbo: "Mi mancano, se non lavoro, le MIE SARTINE"! Che risposta dolce e piena di amore per i propri collaboratori.
Anche un Generale senza soldati non può fare la "battaglia"!  Ecco perché nel "cinema" lavorare in "équipe" è indispensabile per un buon prodotto. Ognuno nella propria qualifica senza i suoi collaboratori si sente un po' perso, perché nessuno è prescindibile dagli altri. Formare una troupe, per un determinato film, significa mettere insieme capi reparto e maestranze che vadano professionalmente all'unisono. Questo va a vantaggio della qualità del prodotto ed al risparmio della produzione.
Ecco perché nel "cinema" lavorare in "équipe" è indispensabile per un buon prodotto. Ognuno nella propria qualifica senza i suoi collaboratori si sente un po' perso, perché nessuno è prescindibile dagli altri. Formare una troupe, per un determinato film, significa mettere insieme capi reparto e maestranze che vadano professionalmente all'unisono. Questo va a vantaggio della qualità del prodotto ed al risparmio della produzione.
Quando ciò non avviene è tutto il film a non reggere ed è come non averlo fatto. Un grande costumista ha grandi assistenti, pignoli tagliatori, sarte molto esperte e laboratori -sartorie che sanno tutto, e così il trucco - calzolai - parrucchieri e quanti altri. E con tutto questo, se gli attori non sono bravi e la fotografia è poco curata, certo non si migliora la situazione!
Ecco perché è necessario lavorare in una troupe cinematografica "tutti" a favore del prodotto con amore. Sempre e comunque perché siamo "liberi" in un lavoro che ci lega per sempre - tutti più che necessari, indispensabili.
Grazie "COSTUMISTI" (grandi creatori, grandi artisti, grandi... educatori di pellicole) insieme a tutti gli altri "GRAZIE" per aver condiviso con me il mio lavoro e renderlo... ricordabile!
Vi sono grato.
Sergio Salvati
I met Pierino Tosi some time ago. While we were talking about this and that, but always in relation to our work, I asked him the usual question - which can either mean a lot or nothing:"How's it going?" He replied with his innate charm: "If I don't work, I miss MY LIME SEAMSTRESSES!" What a sweet thing to say, so full of regard for his collaborators.
Even a general can't fight a baule without soldiers!
That's why working as a team in movies is essential to creating a good product. Each of us, in our relative professions, feels a bit lost without our coworkers, because everyone is necessary. Making up a crew for a film means putting together department heads and skilled workers who are capable of working as one, which improves the quality of the product and saves the production company money.
When that doesn't happen the film falls apart; it's as if it hadn't been made. A great costume designer has great assistants, meticulous cutters, expert seamstresses, and wardrobe work-rooms that know all there is to know, and the same goes for makeup, footwear, hairdressing and all the other departments. But if the actors are no good and the photography is slapdash, it doesn't help any!
So everyone in the crew has to work for the product, with love. Because we're always 'free', anyhow, in this profession that will always see us united - everyone is more than necessary, indispensable.
Thank you COSTUME DESIGNERS (great creators, great artists, great... educators of film) and everyone else, THANK YOU for having shared my work and made it... memorable!
I'm truly grateful to you.
Sergio Salvati
Brani ed immagini da Cinematografia & Costumi by AIC
INCONTRI - IL MESTIERE DELLA SCENEGGIATRICE (parte 2)
Anita Trivelli a colloquio con Doriana Leondeff
A proposito di figure femminili. Che cosa significa essere oggi in Italia una giovane sceneggiatrice, in termini di accesso alla professione e di rapporto con colleghi, registi e produttori?
È difficile, ma credo non più che in altri campi. Personalmente, ho passato i primi anni che mi sono affacciata alla professione quasi cercando di far dimenticare il più possibile il fatto che ero una donna. Ogni volta che mi trovavo in una riunione di lavoro, partecipavo a incontri, cercavo proprio di azzerare la mia femminilità, di pormi il più possibile così, per non creare equivoci, per essere apprezzata per quella che ero. Poi ho capito che tutto questo era abbastanza contraddittorio e forzato. Solo che l'insicurezza, l'inesperienza, il trovarsi comunque sempre di fronte a interlocutori che, tranne rare eccezioni, sono per la maggior parte uomini, mi metteva in una condizione strana. Come se dovessi scusarmi di qualcosa. Usando sempre il condizionale, insomma. Quando poi gli uomini sono lì, sempre all'indicativo presente, affermativi. Maturando e facendo esperienza ho progressivamente imparato a convivere con il fatto di essere una donna, che lavora, collabora spesso con registi, senza dare un colpo di spugna a tutto il resto. Quello che succede, ad ogni modo, è che spesso, anche i registi più aperti, più illuminati, «si aspettano» da una donna determinate doti, determinate cose.
Del tipo?
Pazienza, gentilezza. Già poichè gli sceneggiatori sono considerati una sorta di terapeuti del regista.
Allora sembra che sia cambiato poco in cento anni di storia del cinema. Parafrasando una studiosa americana di cinema delle origini, le sceneggiatrici sono ancora «le loquaci partner dei registi». Mentre i registi «sono quelli che dicono a tutti cosa fare». E quanto alla possibilità di lavorare con registe? Accennava prima alla collaborazione con Anna Negri.
Anche nel lavoro di Anna Negri la protagonista è una donna, una venticinquenne che racconta la propria educazione sentimentale, o meglio la sua mancata educazione sentimentale, attraverso una serie di vicende che hanno poi determinato la sua sgangherata formazione. Alla quale partecipano, da un lato, taluni personaggi chiave di una certa generazione (la Carrà, Mina, Patti Pravo) e dall'altra una serie di letture.
Avete già iniziato a lavorare insieme? Come si realizza la vostra collaborazione? Lei è presente sul set, oppure il suo apporto si conclude con la definitiva rifinitura della sceneggiatura?
Le riprese del film di Anna non sono ancora iniziate. Siamo stati a Genova, dove il film sarà ambientato, a fare i sopralluoghi insieme. In fase di riscrittura della sceneggiatura e prima della versione definitiva era molto importante avere in mente alcuni luoghi precisi della città. Ora Anna sta preparando il cast, sta facendo i provini e sicuramente anche questa è una fase del lavoro molto utile. Ha fatto lunghi provini, così, nel momento in cui vedi recitare ciò che hai scritto, capisci tantissimo. Ti rendi conto di quello che funziona e di quello che non funziona. Se ci sono tempi morti, battute che non arrivano, che non corrispondono alla tua intenzione. Comunque, la sceneggiatura del suo film è stata ultimata adesso. Nel caso del film di Silvio Soldini, sono stata a Treviso, a Taranto, sul Monte Bianco. A Treviso, dove si svolge la prima parte del film, sono andata una settimana prima dell'inizio delle riprese perché erano necessari alcuni tagli di sceneggiatura. Poi ho partecipatp alle prove di Licia Maglietta e di Mira Sardoch, quest'ultima è un'attrice slovena che interpreta il ruolo della protagonista più anziana del film, di nome Anita. Anche lì abbiamo fatto alcuni cambiamenti proprio su questa base: rendendoci conto meglio di quanto non funzionava o raccogliendo qualche suggerimento delle attrici. D'altra parte, lo sceneggiatore sul set non ha una vita particolarmente esaltante. Ti ritrovi di colpo a non avere più alcun ruolo. C'è una macchina enorme che si è messa in moto sulla base di una sceneggiatura e, tuttavia, al tempo stesso, l'ultimo dei macchinisti (e lo dico senza nessun razzismo) è ovviamente più importante di te in quel momento. E giusto che sia così, in qualche modo. Poiché lui ha un ruolo preciso e tu non ce l'hai. Inoltre, anche il regista non sempre vive serenamente la presenza dello sceneggiatore sul set, dato che, in fondo, siete soltanto tu e lui che sapete che cosa deve succedere, che cosa sta succedendo.
Pensa che in questi umori, nell'atmosfera del set scatti anche, per così dire, una sorta di competitività tra sceneggiatore e regista; si crei un certo disagio, la sensazione di una presenza ingombrante o cosa?
Non è questo. Semplicemente, a un certo punto il regista si deve completamente riappropriare del film. E, forse, l'unico modo per poter avere in pugno la situazione e tenere in mano questa gigantesca macchina che deve girare, non si può fermare. Si tratta di questo, forse, ed è comprensibile. Un pò ti fa soffrire, ma poi la cosa si ridimensiona.
Ha mai pensato, come accade di frequente a un certo numero di sceneggiatori, di girare un film?
No. Per fare il regista è necessario avere un carattere abbastanza speciale, e io sicuramente non ce l'ho. Però è vero che, per stare al cinema italiano più recente, sono numerosi i passaggi di sceneggiatori dietro la macchina da presa. L'ultimo film di Bernini, per esempio, Le mani forti, Pasquini, che scriveva spesso in coppia con Bernini, sta anche lui ultimando il suo primo film. Paolo Virzì. E altri ancora. Ma io non ci penso. Proprio per una questione di temperamento. Nel mestiere di regista ci vogliono anche un cinismo e una spietatezza che io non ho.
Crede che questa sua convinzione di inadeguatezza al mestiere di regista possa avere un qualche legame con la circoscritta presenza delle donne dietro la macchina da presa, non solo in Italia, pur con le debite eccezioni che indicano, qua e là, considerevoli cambiamenti in atto nell'industria cinematografica internazionale?
Sì, un pò sì. Perché, insomma, devi faticare il doppio in quanto donna in qualche modo. Oltre a tutte queste qualità che sono necessarie, se sei una donna devi elevare tutto all'ennesima potenza. Io ho amiche registe che ammiro proprio per questo.
Ha mai preso in considerazione l'idea di andare a lavorare all'estero, grazie anche al fatto che conosce bene l'inglese?
È qualcosa che avrei dovuto pensare concretamente qualche anno fa. Sotto i trent'anni è tutto più semplice. Per chi scrive, al di là delle peraltro superabili difficoltà linguistiche, ritengo che non siano di poco conto le radici culturali. Faccio un esempio, tagliando le cose con l'accetta. Se, per ipotesi, io andassi a lavorare negli USA credo che potrei portare uno sguardo «esterno» su quella che
per me sarebbe una realtà nuova; e questo sguardo, a mio avviso, per avere una sua credibilità, dovrebbe probabilmente essere sempre filtrato da un punto di vista che mi risulti vicino. Il rischio potrebbe essere, in definitiva, quello di ritrovarsi a raccontare solo storie di italiani che vivono in America. Per raccontare storie veramente americane ci sono gli scrittori americani, che sicuramente hanno a disposizione più strumenti di me.
So che è in stretto contatto con la regista italo-australiana Monica Pellizzari. *
Monica è una cara amica che ho conosciuto al CSC, all'epoca in cui lei frequentava la scuola di cinema di Sidney. Venne a Roma durante il secondo anno di corso, la sua famiglia è di origini venete, così lei aveva il desiderio di trascorrere un certo periodo in Italia. Alcuni mesi fa, proprio con lei si era formulato un progetto che poi è sfumato per questioni produttive, e tuttavia, da parte di tutte e due, c'è il desiderio di fare cose insieme. Con lei sarebbe sicuramente diverso, in quanto ci conosciamo e abbiamo una serie di affinità: sono sempre basi importanti queste. Scrivere con qualcun altro è veramente qualcosa di estremamente difficile perché richiede una intimità, una capacità di mettersi a nudo, in discussione. Non puoi farlo con chiunque, a meno che non imposti le cose in modo completamente «professionistico». Io non ne sono capace. Forse non sono una professionista vera. Ho sempre delle implicazioni profonde. Non riesco a raccontare storie che non mi interessino in qualche misura. Verso le quali non trovo una necessità per raccontarle.
Crede che questa sua disposizione abbia a che fare con un modo «differente» di essere della creatività femminile, o la considera prettamente un fatto di temperamento personale?
Non lo so. Forse sì. Probabilmente c'è anche questa componente. L'aspetto umano è imprescindibile. Tu puoi provare una stima enorme per un regista o un certo sceneggiatore, però poi, se umanamente non c'è intesa, sintonia, qualsiasi collaborazione è impossibile. Almeno per me. Questa è una cosa che può anche succedere. Un film, in fondo, è sempre un viaggio.
In base alla sua esperienza, con chi ha raggiunto finora una maggiore sintonia professionale?
Con Soldini, sicuramente. A volte il timore era di essere troppo simili. Poi, naturalmente, non era vero, perché ci sono tantissime e profonde differenze tra noi. Di certo, però, sulle questioni di fondo non ci sono mai stati motivi rilevanti di disaccordo. Motivi di disaccordo ce ne sono stati qualche volta su questioni più marginali, periferiche. Io, di mio, ho cercato di portare una lievità maggiore, una leggerezza, che era peraltro anche un suo desiderio. E di usare, soprattutto con i personaggi, uno sguardo più «interno», più affettuoso. Che facesse pensare a questi personaggi come a persone con cui andare volentieri a cena, a prendere un caffé, magari trascorrere un fine settimana insieme. Perché le senti vicine, familiari, che fanno parte di un mondo che ti appartiene. In questo caso, almeno. Non è assolutamente una regola. A volte, mettere distanza può essere, invece, molto utile e interessante. Dipende dalle scelte che si fanno a monte. In questo caso era come dicevo prima. Mentre, per esempio, ne L'aria serena dell'Ovest, un precedente film di Soldini che mi è piaciuto moltissimo,lo sguardo è diverso. C'è uno sguardo «dall'alto» sui personaggi. In questo nuovo film volevamo tutti e due accorciare un pò le distanze. Speriamo di esserci riusciti.
Anita Trivelli
* Ho riferito del corto Best wishes e dell'esordio nel lungometraggio Fi-stful of lies di Monica Pellizzari su Cinema Sessanta, nn.3, maggio-giu-gno 1994 e nn.5-6, settembre-dicem-bre 1995.
dall'incontro di Anita Trivelli su Cinema Sessanta, n.3, maggio-giugno 1996
... Avevo diciotto anni. Poi ho iniziato a frequentare clandestinamente quella scuola, che è privata e molto costosa, e ho incominciato a collaborare con alcuni studenti, diventati miei amici, che la frequentavano e dovevano realizzare ogni tre mesi dei cortometraggi. In una certa misura, questo è stato il mio primo vero approccio al cinema.
INCONTRI - IL MESTIERE DELLA SCENEGGIATRICE
Anita Trivelli a colloquio con Doriana Leondeff
Vorrei chiederle anzitutto come è arrivata a fare la sceneggiarice, e qual'è la sua formazione.
In qualche modo ho sempre scritto racconti per esempio. Finito il liceo a Bari, sono stata un anno a Londra per imparare l'inglese. Un giorno mi sono ritrovata per caso alla London Film School, che era vicinissima al mio college, e stavano proiettando Ombre di Cassavetes. Rimasi alla proiezione, ed ebbi così una sorta di fascinazione. Avevo diciotto anni. Poi ho iniziato a frequentare clandestinamente quella scuola, che è privata e molto costosa, e ho incominciato a collaborare con alcuni studenti, diventati miei amici, che la frequentavano e dovevano realizzare ogni tre mesi dei cortometraggi. In una certa misura, questo è stato il mio primo vero approccio al cinema. In seguito mi sono trasferita a Roma, dove ho frequentato il Centro sperimentale di cinematografia.
Frequentava anche l'università in quegli anni?
Sì, seguivo parallelamente l'università. Mi sono laureata in Storia del cinema, con una tesi sul rapporto tra letteratura e cinema. Più precisamente, mi sono occupata del rapporto tra Zurlini e Pratolini. Zurlini è un regista poco conosciuto, che, a mio avviso, meriterebbe di essere rivalutato, riscoperto. È una figura abbastanza atipica nel panorama del cinema italiano di quegli anni.
La stesura di questo tipo di tesi ha avuto una qualche «ricaduta» sullo sviluppo della sua professionalità?
Ho scelto naturalmente un argomento che mi permettesse in qualche modo di approfondire temi che mi stavano a cuore. Durante il corso di sceneggiatura al CSC abbiamo lavorato su racconti, romanzi, fa-cendone adattamenti. Ma l'adattamento è qualcosa che ti capita, almeno all'inizio della professione, molto di rado. In circa dieci anni di attività, mi è capitato finora solo una volta, di recente, di lavorare: nel film di Anna Negri, liberamente ispirato al romanzo di Rossana Campo, In principio erano le mutande. Sono intervenuta nel lavoro di Anna quando già esisteva una prima sceneggiatura stilata da lei e da Rossana, una sceneggiatrice che io e Ivan Cotroneo, un collega napoletano che collabora con Corsicato, abbiamo in larga misura rielaborato.
A proposito di questo crinale che percorre il lavoro della sceneggiatura tra adattamento di un testo pre-esistente e nuova creazione, puo parlarci della sua esperienza, anche nel quadro di un certo orientamento del cinema italiano più recente, che sembra tornare all'adattamento?
È un fenomeno ancora agli inizi, in realtà. Di certo c'è un'attenzione maggiore nei riguardi dell'adattamento, considerando le strette parentele tra cinema e narrativa, e i loro confini sempre più sfumati. Ciò che purtroppo è scomparsa è la figura del soggettista, che invece nel cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta era attivissima, se si pensa a Zavattini, Flaiano, Pinelli, Age, Scarpelli, Benvenuti, De Bernardi, i quali non erano solo sceneggiatori. Oggi, diversamente da allora, si è diffusa un pò quest'idea tra i registi, e in una certa misura tra i produttori: che gli sceneggiatori siano costruttori di storie più che soggettisti, perchè, molto spesso, i registi hanno in qualche modo un imprinting sul soggetto o per lo meno sull'idea di partenza del film. Personalmente, ritengo di essere stata abbastanza fortunata, poiché, coi pochi registi con i quali ho finora collaborato, ho avuto comunque modo di seguire tutto l'iter, a partire proprio dal soggetto.
Ci puo citare i registi per i quali ha lavorato finora?
Uno è Claudio Del Punta, che ha firmato un piccolo film, Trafitti da un raggio di sole, e un altro di cui dovrebbero iniziare le riprese in estate. Anche lì, appunto, siamo partiti proprio chiacchierando insieme, dalla messa a fuoco dell'idea, al soggetto, alla sceneggaitura. Un altro è Silvio Soldini, del cui ultimo film, Le acrobate, io firmo, insieme a lui, soggetto e sceneggiatura. Al film ha anche collaborato la scrittrice Laura Bosio. Poi ho lavorato con Marco Turco, un giovane regista esordiente, che ha in preparazione il suo primo film. Anzi, sta contemporaneamente partendo, speriamo, una sceneggiatura che avevamo scritto insieme alcuni anni fa e di cui lui aveva già fatto la preparazione, ma il lavoro si era poi bloccato per un improvviso crack produttivo. Adesso, sembra che questo progetto si realizzi con un'altra produzione. Inoltre, sta per partire per la RAI un altro soggetto, scritto da Marco e da me, con un altro sceneggiatore, Andrea Porporati. Si tratta, anche in questo caso, di lavori in cui sono stata chiamata a collaborare per il soggetto e poi, adesso, per la sceneggiatura.
Quali sono i suoi riferimenti per la pratica di sceneggiatura e di regia?
In merito alla scrittura, ho riferimenti più legati alla letteratura che al cinema, in qualche modo. Credo che, comunque, anche leggere i classici come Tolstoj e Flaubert, per esempio, sia un esercizio utilissimo. Leggere testi del genere, analizzarli, magari scalettarli, può aiutare moltissimo chi voglia scrivere, e probabilmente più di qualunque manuale di sceneggiatura, poiché la tecnica, di fatto, si esaurisce in poco. Questo tipo di lettura ti costringe a riflettere, a mettere a nudo dei meccanismi drammaturgici che poi funzionano in letteratura, al cinema, in teatro. Per quanto riguarda il cinema mi piacciono registi molto diversi tra loro. A dispetto delle divisioni che solitamente si fanno, in base alle quali se ti piace Truffaut non può piacerti Godard e viceversa, io apprezzo molto tutti e due questi registi. L'ammirazione per Truffaut risale a quando ero ragazzina, e poi si è estesa dal cinema, ai suoi scritti, alla sua figura, alle lettere, riflessioni critiche, interviste. Insomma l'immagine che mi ha dato di sé. Quella di Godard è sicuramente più respingente, può avere una sua sgradevolezza. Ma Godard ha fatto film bellissimi, come Fino all'ultimo respiro, che quando lo vidi a Londra per la prima volta, mi fulminò. È uno di quei film che con Ombre ha segnato il mio avvicinamento al cinema. Ma poi mi piacciono moltissimo Douglas Sirk, Max Ophuls, il Bertolucci di Ultimo tango a Parigi, creatori di un cinema di grande suggestione con una marca autoriale. Poi c'è anche la commedia, Lubitsch, i cui film trovo straordinari per il modo in cui riesce a fare ironia sempre con uno sguardo molto acuto e, di nuovo, autoriale.
Oltre a Bertolucci, altri registi italiani?
Rossellini e De Sica, sopra tutti. Miracolo a Milano, per esempio, è un film in cui, ogni volta che lo rivedo, scopro qualcosa di nuovo e di bello. Di recente ho rivisto Europa '51, che, a mio avviso, è davvero un capolavoro, tra l'altro con un personaggio femminile straordinario.
A proposito di personaggi femminili, il film che ha preparato con Soldini presenta quattro figure femminili, di cui in seguito due prendono in mano le redini della narrazione.
Si tratta appunto di due donne, la prima delle quali è una quarantenne che vive a Treviso in una situazione di benessere, di calma piatta, ma percorsa da motivi sotterranei di inquietitudine. Si trova in un momento di confusione, in cui non capisce più bene ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. A che cosa dar valore e a che cosa no. Anche se poi è una donna professionalmente realizzata: fa il chimico in una ditta di cosmetici, è separata ma ha un nuovo compagno.
Com'è nata l'idea?
Lo spunto, da cui siamo partiti io e Silvio faceva capo proprio all'idea di due donne, una residente al Nord, l'altra al Sud. Questo lo sfondo geografico-sociale che entra in gioco nel film, come del resto nei suoi lavori precedenti. Poi c'è l'incontro tra questa donna del Nord (Licia Maglietta) e quella che vive nel Sud (Valeria Golino), una trentenne che lavora in un supermercato, ha una figlia di 7 anni ed è colta anche lei in un momento di fragilità. Tutti e due questi personaggi, ma il discorso vale anche per le altre figure femminili, sono donne forti che attraversano una fase di vulnerabilità. Desiderano un cambiamento, anche se non sanno bene in che direzione orientarlo, e sono in una condizione di particolare ricettività. Insomma, si verifica un concorso di più elementi. Da un lato c'è il caso, una serie di coincidenze che nel film rappresentano una sorta di filo rosso. e dall'altro però c'è lo stato d'animo in cui si trovano queste donne. Si verifica una sintonia tra gli eventi esterni e il sentire delle protagoniste. Nella struttura del film, avviene qualcosa di abbastanza insolito in termini narrativi, drammaturgici: cioè, a un certo punto, dopo che per 40' si è seguita una protagonista (la Maglietta) c'è un passaggio del testimonal, e il film si sposta sull'altra protagonista (la Golino), a Taranto, in questa sua vita che è completamente diversa da quella dell'altra donna. Un tale spostamento, credo provochi un certo disorientamento nello spettatore, che, spero, viene riassorbito quando ci si rende conto che, in fondo, sono cambiate le coordinate geografiche, ma il racconto che si sta evolvendo è sempre lo stesso. Queste due donne, che se non fossero accadute certe cose non si sarebbero mai incontrate, hanno in comune una serie di gesti, reazioni, affinità, che le avvicinano.
È significativo, in una certa misura, che questo road-movie italiano esistenziale abbia come esecutrici delle donne?
Sicuramente ci è sembrato più semplice, più plausibile, più verosimile raccontare questa storia attraverso due personaggi femminili.
Perché parla di semplicità e di plausibilità rispetto a questa scelta? Al riguardo, mi vengono in mente alcuni mad-movies europei con un certo respiro, alla Wenders. Dove i promotori del movimento sono uomini, a fronte di una lacerante ma sommessa latitanza del femminile.
Non escludo in assoluto che questa storia potesse accadere anche tra due uomini. Ma ho difficoltà a immaginarla, perché, magari, avrebbe assunto risvolti di comicità involontaria. Nell'ipotesi di lavorare su due personaggi maschili, questi sarebbero in qualche modo diventati delle eccezioni. Allora, la scelta su personaggi femminili forse è dovuta al fatto che, in qualche modo, le donne sono in questo momento le antenne più sensibili della nostra società. Proprio perché, come accennavo, hanno insieme queste caratteristiche di forza e di fragilità, che erano per noi un pò le condizioni necessarie per far scaturire questa scintilla. Ci sembrava che, avendo per protagoniste due donne, tante cose che potessero essere date per scontate, non andassero necessariamente spiegate. Un ribaltamento di genere sessuale avrebbe complicato tutto, avrebbe implicato davvero costruire il film secondo altri percorsi, facendo attenzione alle «trappole». Mi spiego: se io penso a un chimico o a un dirigente del Nord e al cassiere di un supermercato del Sud che si incontrano ad un certo punto e tutto il resto, i parametri e il registro della storia si trasformano enormemente.
dall'incontro di Anita Trivelli su Cinema Sessanta, n.3, maggio-giugno 1996
Quando sono fiero, sono fiero. Non voglio nemmeno dilungarmi in tante parole, anche perché questa intervista è (secondo il mio punto di vista) la migliore che io abbia mai fatto, almeno nelle domande (ci mancherebbe che lo fosse per le risposte). Vi presento un piccolo assaggio di vita della dolcissima Liù Bosisio...



















