♥ Film e dintorni
 Titanic, un nome entrato ormai nella leggenda. Al momento della sua presentazione, nel lontano 1912, fu accolto nell'entusiasmo generale. La sua esistenza provava che l'uomo era finalmente in grado di governare le forze della natura.
Titanic, un nome entrato ormai nella leggenda. Al momento della sua presentazione, nel lontano 1912, fu accolto nell'entusiasmo generale. La sua esistenza provava che l'uomo era finalmente in grado di governare le forze della natura. Partito da Southampton per il viaggio inaugurale con un carico di 2223 tra passeggeri e membri dell'equipaggio, era pronto a sfidare irriverente l'oceano, forte dei suoi 269 m di lunghezza. Era la 'Nave dei sogni'.
Soltanto dopo pochi giorni, il sogno si è infranto nelle gelide acque del Nord Atlantico: dopo aver urtato un iceberg, nella notte senza luna del 15 aprile 1914, il Titanic si è spento lentamente, trascinando con sè più di 1500 anime.
Per ricreare un'atmosfera il più possibile realistica, il regista ha fatto ricorso a tutti i mezzi offerti al cinema dalla tecnologia digitale. Risultato di tutto ciò è un autentico e raro capolavoro -su cui tuttavia non sono mancate le polemiche - che tenterò di analizzare nelle prossime pagine.

Perchè Titanic non è solo una storia che vuole essere da monito, un mito, una parabola, una metafora dei guasti della razza umana. E' anche una storia fatta di fede, di coraggio e, soprattutto, d'amore."

L'intento di Cameron è quello di "portare lo spettatore a bordo del Titanic". A tale scopo, il regista deve necessariamente far rivivere il Mito, e deve riprodurre le suggestioni di un complesso periodo storico. La nave, le luci, i colori tenui dell'età edoardiana sono ricostruiti nel minimo dettaglio, sempre per amore del realismo.
Il Titanic era la nave dei sogni, quindi un sogno è al centro dell'intera vicenda: altrove l'amore tra Jack e Rose sarebbe stato impensabile. Sul Titanic, invece, tutto è realizzabile, anche un intenso legame che trascende le insormontabili barriere che in quel periodo dividevano le varie classi sociali.
Ad un tratto, l'armonioso affresco dipinto nel film si infrange contro un immenso iceberg: gli spettatori assistono impotenti ad un grandioso e terrificante spettacolo di dolore e morte.
Per ricreare la nave e dare allo spettatore questa straordinaria impressione di stare vivendo un'esperienza reale, Cameron ha adoperato le più avanzate tecnologie digitali; la critica mossa da
più parti al suo lavoro è quella di aver abusato di questi interventi tralasciando la cura per la trama ed il messaggio.
A parte qualche dialogo un po' zoppicante, infatti, in Titanic c'è tutto:fedele ricostruzione storica, pathos, ironia, dramma, paura, poesia, amore, morte... il tutto accompagnato dalla splendida colonna sonora firmata da un maestro come James Horner. Come si può negare che un film del genere sia un autentico capolavoro?
La vicenda ha inizio ai nostri giorni, a largo delle coste del Canada orientale: Brock Lovett (Bill Paxton) è a capo di una squadra di ricercatori impegnata in una delicata missione: rivisitare il relitto del Titanic alla ricerca di un diamante blu di inestimabile valore, chiamato 'Cuore dell'Oceano'. Durante una delle tante immersioni, il gruppo riporta in luce una cassaforte contenente il ritratto di una giovane donna che indossa il gioiello: la donna, ormai ultracentenaria, è Rose Calvert (Gloria Stuart), sopravvissuta alla notte del disastro.
Invitata dai ricercatori a bordo della loro nave allo scopo di ottenere informazioni, Rose ritrova alcuni degli oggetti che più di ottant'anni prima l'avevano accompagnata sulla nave inaffondabile e, sopraffatta dall'emozione dei ricordi, comincia a narrare la sua avventura sul Titanic.
Inizia così un viaggio nel tempo che ci riporta al 1912, sul molo di Southampton, dove una folla di gente attende per imbarcarsi alla volta degli Stati Uniti.
La giovane Rose (Kate Winslet), appartenente ad una famiglia dell'alta borghesia di Philadelphia, è in viaggio con la madre (Frances Fisher) e il fidanzato, il facoltoso Cal Hockley (Billy Zane), personaggio arrogante e classista. Giunti negli Stati Uniti, i due si sposeranno.
Sul Titanic, però, la vita della ragazza subisce una svolta profonda: l'incontro con Jack Dawson (Leonardo di Caprio), giovane - e bello - pittore vagabondo, imbarcatosi dopo aver vinto il biglietto giocando una mano fortunata di poker, fa esplodere in lei un desiderio di vita fino ad allora sopito sotto il peso delle convenzioni e delle etichette. Rose si avvede dell'ipocrisia del mondo aristocratico in cui fino allora è vissuta e, dopo alcuni momenti di esitazioni, si lascia travolgere dall'amore per Jack, suscitando l'ira del fidanzato ed il disprezzo della madre.
Questo amore dura soltanto poche ore, ma è così intenso da legare indissolubilmente le anime dei due giovani, che non esitano a rischiare la vita l'uno per l'altra durante i tragici momenti dell'affondamento.
Alla fine, il destino interviene a dividere i due amanti: Jack muore da eroe, assiderato nelle acque dell'Atlantico mentre veglia sulla sua Rose, nella vana attesa di veder tornare indietro le scialuppe di salvataggio.
Preparazione: la raccolta dei documenti e l'allestimento del set
 In ambienti holliwoodiani, Cameron è noto per la completa dedizione e la cura maniacale dei dettagli, elementi che caratterizzano fortemente il suo approccio al lavoro. E' ovvio dunque che il regista, prima di iniziare le riprese, si sia impegnato in una meticolosa ricostruzione storica di usi e costumi dell'epoca, di tutti i dettagli riguardanti la nave (a tal fine aiutato dall'illustratore Ken Marschall e dallo storico Don Linch), e soprattutto della dinamica dell'affondamento.
In ambienti holliwoodiani, Cameron è noto per la completa dedizione e la cura maniacale dei dettagli, elementi che caratterizzano fortemente il suo approccio al lavoro. E' ovvio dunque che il regista, prima di iniziare le riprese, si sia impegnato in una meticolosa ricostruzione storica di usi e costumi dell'epoca, di tutti i dettagli riguardanti la nave (a tal fine aiutato dall'illustratore Ken Marschall e dallo storico Don Linch), e soprattutto della dinamica dell'affondamento.
A quest'ultimo proposito, Cameron ha imposto come condizione necessaria per la realizzazione del film quella di poter scendere personalmente a 4000 metri di profondità per filmare il relitto. Nel corso di dodici successive immersioni, il regista ha ottenuto una documentazione del relitto sufficientemente dettagliata da poter approntare i preparativi per le riprese del film, iniziate nel luglio 1996.
Alcune delle suggestive immagini filmate durante le spedizioni sono state inserite nelle scene iniziali del film.
Per girare la parte contemporanea di Titanic, la troupe ha allestito un set sul Keldysh, la nave usata come base per le immersioni subacquee; ci troviamo ad Halifax, Nova Scotia, non lontano dal relitto del Titanic.
Per realizzare la parte centrale del film, quella ambientata a bordo del Titanic, Cameron ha scelto di allestire un enorme set a Rosarito, Baja California, lungo una fascia di costa di circa 16 ettari. I lavori per la costruzione del set son iniziati il 30 maggio 1996 e, nel tempo record di 100 giorni, hanno portato alla realizzazione di un 'modellino' della nave, sospeso a quattordici metri sopra il livello del mare, della lunghezza di 236 m (poco meno di quanto misurasse realmente il Titanic, 268 m) e di due grandi vasche piene di acqua dell'oceano depurata: la prima, dalla capacità di ben 65 milioni di litri, sarebbe servita per simulare l'affondamento. La seconda, più piccola (poteva contenere fino a 19 milioni di litri...), era alloggiata all'interno di un teatro di posa e vi sarebbero state girate le riprese con gli attori. Un solo set però si è rivelato insufficiente per simulare le fasi dell'affondamento della nave, e sono stati costruiti tre set con diversa inclinazione. Il numero complessivo di sequenze digitali utilizzate per riportare il Titanic sugli schermi ammonta a 550. Il lavoro in CG è però talmente accurato, che la differenza tra riprese reali ed effetti digitali è impercettibile: in questo modo lo spettatore avverte il dramma che si consuma sul transatlantico come un'esperienza vissuta quasi in prima persona. In realtà, tutto (più o meno) sul Titanic di Cameron è frutto del paziente lavoro degli impiegati della Digital Domain, a cominciare dal background notturno dell'affondamento (gli attori sono stati ripresi su sfondo verde), dai gabbiani che volano nel cielo o dai delfini che sfruttano la rotta della nave, per concludere con le centinaia di comparse che affollano i ponti alla partenza da Southampton, o che precipitano da 60 m di altezza durante l'affondamento.
Il numero complessivo di sequenze digitali utilizzate per riportare il Titanic sugli schermi ammonta a 550. Il lavoro in CG è però talmente accurato, che la differenza tra riprese reali ed effetti digitali è impercettibile: in questo modo lo spettatore avverte il dramma che si consuma sul transatlantico come un'esperienza vissuta quasi in prima persona. In realtà, tutto (più o meno) sul Titanic di Cameron è frutto del paziente lavoro degli impiegati della Digital Domain, a cominciare dal background notturno dell'affondamento (gli attori sono stati ripresi su sfondo verde), dai gabbiani che volano nel cielo o dai delfini che sfruttano la rotta della nave, per concludere con le centinaia di comparse che affollano i ponti alla partenza da Southampton, o che precipitano da 60 m di altezza durante l'affondamento. Per realizzarle, un team di artisti ha catturato i movimenti di alcuni stuntman reali; i modelli, archiviati nelle memorie dei computer, sono stati animati digitalmente prendendo come riferimento gli scheletri in wireframe; apportando loro alcune variazioni nei movimenti, o semplicemente cambiandone gli abiti, è stato possibile creare l'elevato numero di stunt virtuali che vediamo affollare tranquillamente i ponti.
Animare le comparse durante le fasi dell'inabissamento è stata, per vari motivi, un'impresa più complessa; in primo luogo, perchè gli artisti non disponevano di modelli dei movimenti da catturare come era avvenuto per le tranquille sequenze della prima parte di film. Come simulare la caduta disordinata di un uomo, ad esempio un sessantenne, che lungo il tragitto urta contro oggetti o altre comparse? Il problema è stato risolto mettendo a punto una nuova tecnica, denominata Rotocap (rotocapture): in pratica, dei movimenti catturati da stuntman reali (che si lanciavano da set inclinati a 45 o 90 gradi), sono state considerate soltanto le pose estreme; il modello è stato poi animato in cinematica inversa nelle stesse posizioni e l'effetto ottenuto è stato di un sorprendente realismo.
Per filmare il Titanic, invece, è stato usato in parte l'enorme set (di cui i tecnici hanno ricostruito in CG la parte sinistra, mancante), in parte un modellino. Per realizzare le riprese notturne dei ponti e della prua, Cameron si è servito di un'imponente gru (che in alcune scene ha raggiunto i 60 m di altezza) al cui braccio meccanico estendibile è stato applicato un alloggio per una telecamera girevole: in tal modo si potevano effettuare riprese lungo tutta l'estensione del set.
Anche l'oceano in cui naviga il Titanic o nuotano le comparse è sintetico: per la sua creazione è stata implementata una versione aggiornata dello stesso software Aretè sfruttato in Waterworld, di Kevin Costner; il team che si occupava di questo incarico ha dovuto creare parametri per l'ora del giorno, la velocità del vento, la posizione del sole ed i riflessi, in modo da far corrispondere il mare in CG alle riprese dal vivo.
La sequenza dell'impatto con l'iceberg è stata affrontata da Cameron e Carpenter quasi con religiosa dedizione, utilizzando la stessa tecnica sperimentata per simulare l'incidente dell'Apollo13. Venne utilizzato un modello in grande scala del blocco di ghiaccio, sul quale fu fatta schiantare la chiglia laterale in sottile stagno di un modellino; una cinepresa posta all'interno di una custodia stagna correva sott'acqua insieme alla nave per riprendere il momento dell'impatto. Gli artisti hanno poi dovuto affrontare il delicato lavoro di ritoccare le tinte dell'acqua, eliminare le bollicine che inevitabilmente si formavano al momento dell'impatto e che avrebbero alterato le immagini, ricostruire i frammenti di iceberg staccatisi in seguito all'urto. Ma il problema più complesso è stato quello di ricostruire un sistema di illuminazione credibile: nella notte in cui il Titanic si inabissò, infatti, la visibilità era nulla a causa dell'assenza della Luna.
Per creare lo spaventoso effetto dell'acqua che irrompe nelle paratie stagne, Cameron e la sua troupe si sono serviti di un sistema antincendio che si attivava automaticamente nel momento in cui avveniva l'impatto tra il modellino e l'iceberg: l'acqua, 'sparata' a 40 litri al secondo, lacerava le sottili pareti in stagno della chiglia.
Per simulare la giusta dinamica dell'affondamento,alcune inquadrature sono state filmate riprendendo da un elicottero un modellino. Per girare le scene in cui si vedono gli attori aggrappati al parapetto della poppa, invece, il set principale è stato letteralmente spezzato in due tronconi; la poppa, che nel film galleggia qualche minuto prima di sprofondare nell'Oceano, è stata montata su una speciale piattaforma idraulica che ha permesso di girare le riprese finali dell'inabissamento.
Il salone della prima classe e la celebre scalinata, infine, sono state ricreate a grandezza naturale su un'altra piattaforma idraulica costruita all'interno della seconda vasca, profonda nove metri e progettata per essere inclinata e progressivamente riempita d'acqua.
Ma quando gli artisti della Digital Domain si sono resi conto che non avrebbero potuto realizzare tutti gli effetti speciali rispettando le scadenze imposte dalla produzione, hanno deciso di affidare alcuni incarichi (per un totale di 150 sequenze) alla VIFX, già nota per aver lavorato a Relic o Speed.
I compiti assegnati alla VIFX includevano la creazione di un cielo stellato, l'inserimento di alcuni operai negli ambienti della sala macchine, nonchè l'elaborazione delle nuvolette di vapore generate dal respiro dei naufraghi quando giungevano in prossimità dell'acqua gelida.
Il cielo stellato non è stato fonte di grandi problemi: è stato sufficiente usare del software apposito, il Chalice 2-D della Silicon Grail.
Per le sequenze della sala macchine le riprese degli operai, effettuate su sfondo verde, sono state inserite tramite fotomontaggi all'interno della sala macchine della Liberty, una fregata statunitense che presenta press'a poco le stesse caratteristiche del Titanic. Tuttavia, le dimensioni della sala della Liberty erano tre volte inferiori rispetto a quelle del transatlantico; per conferire a queste scene le giuste proporzioni, quindi, la VIFX ha messo a punto uno strategico sistema di illuminazioni e ha proceduto alla riduzione in scala degli operai.
La realizzazione delle nuvolette di vapore è stata la più difficile sfida affrontata dallaVIFX; inizialmente, gli esperti avevano pensato di catturare le immagini del fumo di sigaretta, ma l'idea è stata soppiantata da un sistema meno dispendioso in termini di costi e tempi di realizzazione, che consisteva nel porre un uomo in una cella frigorifera con background rivestito di velluto nero e filmarne da più angolazioni il respiro; tuttavia, i tecnici hanno dovuto superare il problema, ben più complesso, derivante dalla necessità di sincronizzare (in più di cento riprese!) il 'respiro digitale' agli effettivi dialoghi degli attori.
 (la poppa si solleva grazie ad una potente pompa idraulica)
(la poppa si solleva grazie ad una potente pompa idraulica)
Per portare a termine Titanic la produzione (20th Century Fox) ha speso più di 360 miliardi di lire, a cui vanno aggiunti gli altri 180 impiegati per pubblicizzare il prodotto.
Tuttavia il film, record d'incassi a livello mondiale (sembra abbia riscosso grande successo anche in Giappone, nonostante le ragazze preferiscano i lottatori di sumo a di Caprio...), ha incassato in Italia più di 81.220.022.000 (campione di 173 città, fonte: Giornale dello spettacolo/Agis).
Sembra che ad un certo punto Cameron, accortosi di aver bisogno di un budget superiore a quello inizialmente stabilito, abbia sacrificato gli 85 miliardi di compenso che gli spettavano come autore, regista e produttore pur di portare a termine il film senza tagliare neppure una scena.
La ricostruzione degli interni del Titanic è in gran parte basata sui dati disponibili relativi alla nave gemella Olympic, che ha navigato per 25 anni. Per realizzare le migliaia di elementi di arredamento presenti nel film, è stato necessario un lavoro di quattro anni che ha visto impegnati diversi studi di design.
Ultimata la costruzione del set di Rosarito, la troupe si accorse con orrore che il modello in scala 9/10 della nave mancava di realismo, poichè dagli oblò della fiancata fuoriusciva una luce tenue ed uniforme; gli artisti hanno proceduto allora ad un paziente lavoro di ricostruzione digitale degli interni delle cabine; le immagini ottenute sono state poi ingrandite ed inserite, una alla volta, dentro gli oblò, con l'aggiunta di una leggera curvatura per aumentarne il realismo.
I movimenti delle comparse digitali catturati per girare le riprese di vita quotidiana sui ponti del transatlantico sono quelli di dodici impiegati della Digital Domain con mogli e figli.
Durante la scena del ballo in terza classe, viene inquadrato un insolito Cameron che si diverte nei panni di una comparsa.
Il regista è inoltre l'autore del ritratto di Rose sul divano: per dipingerlo, Cameron ha tratto ispirazione da alcune foto di Kate Winslet.
Per illuminare l'intero set durante le riprese è stato impiegato un impianto elettrico da 40.000 ampère.
Nella notte in cui il Titanic si inabissò la temperatura dell'acqua era di alcuni gradi inferiore allo zero ed in una simile situazione chuunque avrebbe esalato intense nuvolette di vapore. In un primo momento il regista pensò di girare le scene in cui gli attori nuotavano nelle acque dell'Oceano in una piscina a 10 gradi, in modo da simulare le stesse condizioni; gli attori avevano accettato, pensando che la loro interpretazione sarebbe risultata più reale.
Ma dopo le prime riprese, fu chiaro che quella soluzione avrebbe sensibilmente rallentato i tempi di produzione: nessuno poteva restare immerso nella piscina per più di dieci minuti consecutivi ed inoltre bisognava attendere un quarto d'ora (durante il quale gli attori si riscaldavano in vasche ad una temperatura più umana) prima di poter dare il ciak successivo.
Fu allora che Cameron e Legato pensarono ad una soluzione alternativa: effettuare le riprese in piscine a temperatura ambiente ed aggiungere le nuvolette di vapore in post-produzione.
Questa tesina è stata discussa da Licia Barreca
durante l'appello di Informatica generale del 31/07/98
Robert De Niro l'attore morto più volte di tutti: ben 14. Quelli che invece (per ora) gli sceneggiatori hanno fatto morire di meno sono Harrison Ford e Will Smith: 2 soltanto. La rivista Premiere ha stilato la bizzarra classifica dei grandi divi di Hollywood che hanno perso la vita più volte (sul grande schermo naturalmente) con alcune curiosità che, nonostante l'argomento, fanno sorridere.
Per esempio Bruce Willis, che con 11 morti tallona De Niro, è stato ammazzato ben due volte dalla ex moglie Demi Moore: ne L'Ombra del testimone e in Charlies Angels. Al Pacino, la cui barocca morte in Scarface è gia nella storia del cinema, è stato ucciso due volte da attori prevalentemente comici: John Leguizamo in Carlitos Way e Robin Williams in
Insomnia. Pacino è morto complessivamente nove volte, una per mano di De Niro (nel recente Sfida senza regole), che a sua volta era stato ucciso da Pacino in Heat. Il tenebroso Johnny Depp è morto meno di Willis (nove volte e mezzo) in compenso le sue morti sono state particolarmente cruente. Basti pensare al suo esordio, Nightmare-Dal profondo della notte, dove veniva risucchiato da Freddy Krueger e trasformato in una fontana di sangue. La mezza volta di Depp si riferisce alla serie Pirati dei Caraibi perché prima muore, ma nel terzo episodio risorge.
Dopo Depp c'è Brad Pitt che muore nove volte (l'ultima in Il curioso caso di Benjamin Button). Ci sarebbero altre due volte ma non valgono: nel film Fuga dal mondo dei sogni muore, ma subito resuscita come cartone animato; anche in Fight Club muore, ma sul finale si scopre che in realtà non era mai esistito. Anche Jack Nicholson è morto nove volte e in modo violento: la prima quando faceva il motociclista hippy in Easy Rider, la seconda quando
faceva il matto in Qualcuno volò sul nido del cuculo; solo l'ultima volta, impersonando il miliardario malato in Non è mai troppo tardi, è morto dolcemente.
Dustin Hoffman morto nove volte anche lui, vanta il primato della morte più fantasiosa: in Hook-Capitano Uncino viene mangiato da un coccodrillo. A quota otto Christian Bale, sette Denzel Washington (con due morti che valgono mezza ciascuna: quella nel film Un fantasma per amico perchè era un fantasma e quella in Uno sguardo dal cielo perché era un angelo), cinque George Clooney (la più recente in Syriana) a pari merito con Robert Downey jr. Tom Cruise muore quattro volte, una in modo spettacolare, quando in Taps viene fucilato dall'artiglieria della Guardia Nazionale. Per Mel Gibson tre morti (in Mrs. Soffel, Amleto e Breaveheart) a cui si aggiungono tremende torture, subite anche in altri film.
Arriviamo così alle due volte di Harrison Ford (in The Mosquito Coast e Le verità nascoste) e Will Smith (Sette anime e Io sono la leggenda), ma Ford ha un po' barato perché in Indiana Jones-L'ultima crociata era stato reso immortale, anche se per poco tempo.
da: http://www.ilmessaggero.it
 E pensare che nel 2007 ricevette pure un premio dalla Fapav per il suo impegno contro la pirateria. Oggi, alla vigilia del primo ciak di Io, loro e Lara, dove fa un prete piuttosto speciale, Carlo Verdone è ben più scettico di due anni fa sulla possibilità di contrastare il morbo che viaggia su Internet, tramite down-loading o direttamente in streaming. I magazzini di San Marino ricolmi di dvd taroccati, spesso di pessima qualità, sono un ricordo. Oggi c’è la rete. «Una bomba atomica», tuona l’attore-regista: «Ormai Internet ha ucciso tutto. Lo sappiamo come funziona. Prendono il video originale, ci montano l’audio italiano, ancora prima che il film americano esca nelle sale, e il gioco è fatto. La copia è pronta per essere scaricata all'’nfinito».
E pensare che nel 2007 ricevette pure un premio dalla Fapav per il suo impegno contro la pirateria. Oggi, alla vigilia del primo ciak di Io, loro e Lara, dove fa un prete piuttosto speciale, Carlo Verdone è ben più scettico di due anni fa sulla possibilità di contrastare il morbo che viaggia su Internet, tramite down-loading o direttamente in streaming. I magazzini di San Marino ricolmi di dvd taroccati, spesso di pessima qualità, sono un ricordo. Oggi c’è la rete. «Una bomba atomica», tuona l’attore-regista: «Ormai Internet ha ucciso tutto. Lo sappiamo come funziona. Prendono il video originale, ci montano l’audio italiano, ancora prima che il film americano esca nelle sale, e il gioco è fatto. La copia è pronta per essere scaricata all'’nfinito».
Lui se ne intende. «Tra gli italiani sono il più piratato. Chieda alla Guardia di finanza. Come difendersi? Mi sono stufato di fare il testimonial. Posso girare uno spot, divertente o minaccioso, ma non serve a niente. Ti fai pure ridere dietro. È la magistratura che deve intervenire. Serve una legge dura, ma non le fanno». Ci sarebbe il modello francese. Due avvisi, il primo via mail, il secondo per lettera raccomandata. Dopo di che, per decisione di un’autorità ad hoc, ci si ritrova scollegati da due a dodici mesi, e in sovrappiù si continua a pagare l’abbonamento.
«Sì, ci sarebbe - sorride Verdone -, peccato che la legge proposta da Sarkozy sia stata appena bocciata dall’Assemblea nazionale. Pensi, anche Costa-Gavras era d’accordo con la misura. Intanto da noi è un disastro. Se la pirateria è il cancro che uccide il cinema, allora perché nessuno fa niente? Perché il governo non elabora una legge severa?». Verdone ormai è scatenato. «Sono danni industriali per milioni di euro, significa fare meno film, chiudere i negozi, i Blockbuster. Non è pensabile che la rete abbia tutta questo potere. Ecco, lo dico, noi non possiamo fare niente se non interviene Obama. Deve muoversi l'America».
Anche per Verdone manca la percezione del reato, specie tra i più giovani. «La percezione è questa: “Faccio come caz... me pare”. Io sono contro. Uno dice: i figli. Ma io i miei li ho educati bene. Vanno al cinema o comprano i dvd. Guardi, non è solo una questione di soldi, che certo incide, c’entra anche la cultura». Domandiamo: e lei, mai scaricato nulla? «Inutile essere ipocriti. Pure io ho scaricato illegalmente, ma solo file musicali introvabili. Non scarico la musica che deve uscire, compro il cd, mi piace l’oggetto. I film men che meno. Cercavo Amore tossico di Caligari. Stava in rete, ma ho resistito». Bravo, però intorno a lei... «Se non si corre ai ripari chiudiamo baracca e burattini. Ne vuole sapere una? Ero a San Pietroburgo per girare Italians, si avvicina una ragazza russa e mi ringrazia. “Ho imparato l’italiano vedendo i suoi film”, dice. E io: “Grazie, dove li ha visti?”. Lei: «Sono in rete”. C’era tutta la mia vita professionale spiattellata lì, illegalmente, in quel sito russo. Una pena infinita».
Commenti dal sito:
Caro Verdone, non è la pirateria che uccide il cinema italiano, infatti il cinema americano continua ad essere florido ma la mancaza di autori, attori i registi quali pensano solo al compenso. Per quanto riguarda poi la diffusione su internet, se la SIAI fosse meno esosa, qualche dvd in più si potrbbe anche comperare. Un tuo ex estimatore.
Verdone non sa (o fa fintadi non sapere) che la Siae intasca una consistente tassa su ogni CD/DVD venduto e che redistribuisce in misura maggiore agli attori più famosi .... tutto questo danno non lo vedo
Oggi c'è la rete. Tanto i film a 35 Euro l'uno non li compera nessuno. Idem per i CD musicali. Cerchino di cambiare prima di duemila anni invece di invocare sempre le leggi durissime, che non le applica nessuno e non le vuole nessuno. Che mettano i contenuti disponbili in rete a prezzi infinitamente più bassi poi vediamo se la gente scarica illegalmente. La verità è che Internet taglia completamente la catena distributiva e 50 Euro a DVD non sono più giustificati carissimi cialtroni. La verità è che non vogliono cambiare. Che falliscano allora.
7euro e 70 andare al cinema. 1990 la maggior parte delle volte acquistare un dvd nuovo: verdone ragiona con le sue tasche e non con quelle degli italiani. Strano perchè avendo fatto l'attore e il regista per 40 anni dovrebbe sapersi impersonare nell'italiano comune che per acquistare un suo film non può usare mediamente il guadagno netto di 2 ore di lavoro per acquistare un film o portare la famiglia al cinema. Che si batta per prezzi accessibili poi si combatterà la pirateria.
Non sono affatto convinto di quello che dice Verdone in questa intervista. La pirateria per conto mio credo abbia addiritura rilanciato certi prodotti. Guardo un sito cinematografico: sui primi dieci film della scorsa settimana sei sono americani e il primo, che tra l'altro è una schifezza, ha incassato 2,112.000 Euro in un fine settimana in Italia. In america ha già incassato 105.700.000 dollari: tanti soldi. Mediamente in italia in un fine settimana incassano 500.000 euro, e la settimana che sto guardando non offre niente di qualità.E' chiaro che un film italiano che non esce dai nostri confini non farà mai certi incassi ; ma state tranquilli che se non fa incassi non viene nemmeno piratato. Insomma la pirateria non andrebbe assunta come alibi per il poco successo commerciale di certi prodotti perchè in realtà l'equazione - pirateria + incassi al cinema proprio non ha senso, anzi.
... Verdone dovrebbe ringrazziare quel sito russo altrimenti non sarebbe nessuno in russia ... ricevono pubblicita' gratis ... dovrebbero essere grati ad internet ... chi ama veramente il cinema e la musica compra alla fine comunque l'originala ... la qualita' si paga ... internet serve come informazione pubblicitaria ... molti artisti senza internet sarebbero degli sconosciutu ... perche dovrebbero vietarmi di scambiare dei prodotti legalmente acquistati ? ... michele
da perfetto ignorante mi domando:perchè se mi va di prestare film e dvd ad un conoscente è perfettamente legale ed online non posso? perchè se vado in biblioteca posso prendere un libro tranquillamente e leggermelo? lo so che non è la stessa cosa,ma il principio è quello... le case discografiche e i burattinai del business del cinema e della canzone dovrebbero capire che 8 euro per una sera al cinema o 20 euro e passa per un CD sono prezzi dell'altromondo...quando mi sento rapinato alla luce del sole,non mi vergogno di scaricarmi un film o una canzone.se dev'essere una faida tra furbi,che vinca il migliore...
Non è questione di furbizia, la morale non c'entra. È solo una questione di tecnologia: prima di Internet la tecnologia ha reso possibile lo sfruttamento del diritto d'autore dando la possibilità ad attori e musicisti di riprodurre in copie non riproducibili le loro opere che prima erano solo degli eventi di cui si poteva fruire dal vivo. Prima che inventassero le tecniche di incisione e riproduzione gli artisti vivevano di spettacoli dal vivo e guadagnavano molto meno. Prima solo gli scrittori e i pittori potevano produrre copie e guadagnare di più. Sono poi venuti i videoregistratori, le cassette e infine Internet. la tecnologia è cambiata. La questione è tutta nelle compagnie telefoniche che mettono a disposizione a poco prezzo un prodotto Internet dalle possibilità enormi. Devono regolarsi a monte tra Case produttrici, artisti e compagnie telefoniche. L'utente finale non ha alcuna responsabilità morale. Probabilmente il problema non si può risolvere, il mondo sta finendo.
Caro Verdone romano e sinistrorso, siete voi che avete distrutto certi principi presentando come normale l'Italiano furbetto e rendendolo anche simpatico, l'Italiano alla Alberto Sordi, anche tu hai scaricato la musica e allora cosa vuoi? chi è causa adel suo mal..... Io non mi sono mai riconosciuto in quell'Italiano e, nel mio periodo romano, quando cercavo di richiamare ai valori dell'onestà e dei principi del vivere civile mi davano del bigotto o del fascista o, se andava bene, del fesso, ero soltanto onesto. Certo voi tanto buonisti, ma se vi toccano la tasca diventate Savonarola.
da: http://www.ilgiornale.it
Verdone: "Basta pirateria serve una legge durissima" di Michele Anselmi
E noi come la pensiamo?
Abbiamo sempre detto, e qui lo ripetiamo, che se non si fa cultura cinematografica, non si può pretendere niente! Oggi noi piccole associazioni culturali senza scopo di lucro NON possiamo proiettare a scopo didattico un film di 50 anni fa, come non lo possono fare le scuole! i film classici che hanno fatto grande l'italia nel mondo, non sono minimamente conosciuti dai giovani di oggi, e quindi come possiamo pretendere da loro una cultura cinematografica? Moltissimi film piratati su internet sono inguardabili. Comprare un dvd originale per poter apprezzare un bel film (italiano od estero), un'ottima recitazione, sentire un ottimo sonoro, vedere le belle immagini così come immaginate e create dai registi, è Cultura Cinematografica. E nessuno, nè la classe politica nè la cinematografia fa nulla, quindi....
', '', 1, 9, 0, 35, '2009-04-14 05:58:27', 62, '', '2009-04-14 06:33:47', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2009-04-14 05:58:27', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 3, 0, 515, 'legge, film, pirateria', 'Sì, ci sarebbe - sorride Verdone -, peccato che la legge proposta da Sarkozy sia stata appena bocciata dall’Assemblea nazionale. Pensi, anche Costa-Gavras era d’accordo con la misura. Intanto da noi è un disastro. Se la pirateria è il cancro che uccide il cinema, allora perché nessuno fa niente? Perché il governo non elabora una legge severa?', 0, 2320, 'robots=index,follow\nauthor=Michele Anselmi'),
13 apr. (Adnkronos/Ign) - Il cineasta di culto David Lynch è contro il doppiaggio dei film. Secondo il regista di 'Velluto Blu' e 'Twin Peaks', i lungometraggi dovrebbero essere proiettati all'estero solo in lingua originale e con i sottotitoli. Il doppiaggio è quasi un "peccato", ha detto l'artista 63enne in una visita a Mosca.
Secondo il regista, sceneggiatore e anche pittore i doppiatori, con le "loro voci esagerate" distruggono l'atmosfera originale dei film e il carattere degli attori. "Tutti i rumori rimangono in secondo piano", ha commentato a Mosca, dove ha inaugurato la sua esposizione 'The Air is on Fire', con pitture e disegni e mostra fotografica 'Fetish'.
Lynch si è detto inoltre favorevole alla meditazione trascendentale che amplia la coscienza e porta alla pace interiore. "Il mio lavoro con la meditazione non può liberarmi da tutte le paure. Ma quanto più ampia è la coscienza, meno sono le paure", dice Lynch al quotidiano 'Moskovski Komsomolez'. Nelle sue varie presentazioni, Lynch ha spiegato che la meditazione è ottima contro lo stress e la paura. L'artista, conosciuto per le scene di estrema violenza che mostra nei suoi film, pratica questa tecnica dal 1973, quando studiava cinema.
Sui doppiaggi interviene il produttore cinematografico, nonché presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis. "Sottotitoli nei film sì o no? Dipende dai costi - sottolinea - ma prima di tutto il cinema deve essere promulgabile, esportabile. Poi il maggiore sfruttamento popolare di un'opera avviene attraverso il mezzo televisivo e non può mettere i sottotitoli in tv, i film vanno doppiati perché c'è chi non sa leggere, a chi viene il mal di testa".
De Laurentiis non sopporta chi fa rumore al cinema, "luogo magico dove musica, dialoghi ed effetti dominano e rendono magica l'atmosfera". "Al cinema la gente, in maniera anche molto cafona, fa suonare il cellulare - afferma il produttore - e io impazzisco. Il rumore di chi mangia il pop-corn invece mi diverte''.
Lista di film sportivi, suddivisi per disciplina sportiva e in ordine cronologico.
Apnea
* Le grand bleu (idem, FRA 1988) di Luc Besson con Jean Reno. Ispirato alla amicizia/rivalità sportiva tra Enzo Maiorca e Jacques Mayol
* Ocean Men: Extreme Dive (2001), documentario sulla amicizia/rivalità sportiva tra Umberto Pelizzari e Pipin Ferreras - Scheda su Ocean Men: Extreme Dive dell’Internet Movie Database.
* Apnea (idem, ITA 2005) con Claudio Santamaria
Arti marziali
* Fighter in the Wind (2004)
Jūdō
* Throw Down (2004), regia di Johnnie To
Atletica leggera
* Pelle di rame (1951), regia di Michael Curtiz
* Cammina, non correre
* Gioventù, amore e rabbia (The Loneliness of the Long Distance Runner) (1962), regia di Tony Richardson
* Jericho Mile (1979), regia di Michael Mann
* Running (1979) Steven Hilliard Stern
* Momenti di gloria (1981), regia di Hugh Hudson
* Due donne in gara (1982), regia di Robert Towne
* Running Brave (1983), regia di D.S. Everett
* Un ragazzo di Calabria (1987), regia di Luigi Comencini
* Prefontaine (1997)
* Without Limits (1998), regia di Robert Towne
* Marathon (2005)
Automobilismo
* Gran Prix (1966), regia di John Frankenheimer
* Un attimo una vita (1977), regia di Sydney Pollack
* Giorni di tuono (Days of Thunder) (1990), regia di Tony Scott
* Driven (2001), regia di Renny Harlin
* Adrenalina blu (Michel Vaillant) (2003)
* Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) (2006)
* La 24 ore di Le Mans (Steve McQueen) (1971)
Baseball
* L'idolo delle folle (1942), regia di Sam Wood
* Che botte se incontri gli Orsi (The Bad News Bears) (1976), regia di Michael Ritchie
* Gli Orsi interrompono gli allenamenti (The Bad News Bears Breaking Training) (1977), regia di Michael Pressman
* Gli Orsi vanno in Giappone (The Bad News Bears Go to Japan) (1978), regia di John Berry
* Il migliore (The Natural) (1984), regia di Barry Levinson
* Bull Durham - Un gioco a tre mani (Bull Durham) (1988), regia di Ron Shelton
* Otto uomini fuori (1988), regia di John Sayles
* Major League - La squadra più scassata della lega (1989)
* L'uomo dei sogni (Field of Dreams) (1989), regia di Phil Alden Robinson
* The Babe La leggenda (1991) Hiller
* Mr. Baseball (1992), regia di Fred Schepisi
* Ragazze vincenti (1992), regia di Penny Marshall
* Cobb (1994), regia di Ron Shelton
* The Fan - Il mito (The Fan) (1996), regia di Tony Scott
* Gioco d'amore (1999), regia di Sam Raimi
* Hardball (2001), regia di Brian Robbins
* Un sogno, una vittoria (2002), regia di John Lee Hancock
* Bad News Bears - Che botte se incontri gli Orsi (2005), regia di Richard Linklater
Beach Volley
* Il re della spiaggia (1990) Israelson
Bowling
* Kingpin (1996), regia di Peter e Bobby Farrelly
Calcio
Per approfondire, vedi la voce Lista di film sul calcio.
* L'inafferrabile 12 (1950) Mattoli
* Gli undici moschettieri (1952) De Concini
* Il presidente del Borgorosso Football Club (1970) D'Amico
* Prima del calcio di rigore (1971), regia di Wim Wenders
* Un uomo in vendita (’71) Harris
* Fimpen il goleador (‘73) Widerberg
* L'epoca d'oro del calcio (‘74) Sandor
* Fuga per la vittoria (1981), regia di John Huston
* Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento (‘83) Cicero
* L'allenatore nel pallone (1984), regia di Sergio Martino
* Ultimo minuto (1987), regia di Pupi Avati
* Sfida per la vittoria (2000) Michael Corrente
* Sfida per la vittoria (2000) Suarez
* Jimmy Grimble (2001)
* Mean Machine (2001) Barry Skolkick
* Shaolin Soccer (2001), regia di Stephen Chow
* Sognando Beckham (2001), regia di Gurinder Chadha
* Goal! (Goal!) (2005), regia di Danny Cannon
* Garpastum (‘05)
* In campo per la vittoria (The Game of Their Lives) (2005), regia di David Anspaugh
* Goal! 2 - Vivere un sogno (2007), regia di Jaume-Serra
* Il mio sogno più grande (Gracie) (2008)
* L'allenatore nel pallone 2 (2008), regia di Sergio Martino
Calcio - I tifosi
* Eccezzziunale... veramente (1982), regia di Carlo Vanzina
* Il tifoso, l'arbitro e il calciatore (1983), regia di Pingitore
* À mort l'arbitre! (1984) Mocky
* Appuntamento a Liverpool (1988), regia di Marco Tullio Giordana
* Ultrà (1991), regia di Ricky Tognazzi
* Hooligans (1995), regia di Philip Davis
* Febbre a 90° (1997) Evans
* Hooligans (2005)
Canottaggio
* True Blue - Sfida sul Tamigi (1996) Ferdinand Fairfax
Ciclismo
* Totò al Giro d'Italia (1948) Mattoli
* All American Boys (Breaking Away) (1979), regia di Peter Yates
* Il vincitore (American Flyers) (1985), regia di John Badham
* Le vélo de Ghislain Lambert
Cricket
* Lagaan (2001)
Dodgeball
* Palle al balzo - Dodgeball (2004), regia di Rawson Marshall Thurber
Football americano
* Quella sporca ultima meta (1974), regia di Robert Aldrich
* I mastini del Dallas (1979), regia di Ted Kotcheff
* Tempi migliori (1987), regia di Roger Spottiswoode
* Un amore una vita (1988), regia di Taylor Hackford
* La grande promessa (1988)
* Campioni di guai (1991), regia di Stan Dragoti
* L'ultimo boy scout (1991), regia di Tony Scott
* The Program (1993), regia di David Ward
* Rudy (1993), regia di David Anspaugh
* Jerry Maguire (1996), regia di Cameron Crowe
* Waterboy (1998), regia di Frank Coraci
* Ogni maledetta domenica (Any Given Sunday) (1999), regia di Oliver Stone
* Varsity Blues (1999), regia di Brian Robbins
* Le riserve (The Replacements) (2000), regia Howard Deutch
* Il sapore della vittoria (2000), regia di Boaz Yakin
* The Slaughter Rule (Radio) (2002), regia di Alex Smith e Andrew J. Smith
* Mi chiamo Radio (2003), regia di Michael Tollin
* Friday Night Lights (2004), regia di Peter Berg
* L'altra sporca ultima meta (2005), regia di Peter Segal
* Facing the Giants (2006)
* La gang di Gridiron (Gridiron Gang) (2006), regia di Phil Joanou
* We Are Marshall (2006), regia di McG
* Imbattibile (Invincible) (2006)
* In amore niente regole (2008), regia di George Clooney
* Il paradiso può attendere (1978), regia di Warren Beatty
Ginnastica artistica
* Stick it - Sfida e conquista (2006)
* La piccola campionessa (1991)
Golf
* Scuola di golf (Caddyshack) (1980), regia di Harold Ramis
* Due palle in buca (Caddyshack II) (1988), regia di Allan Arkush
* Tin Cup (1996), regia di Ron Shelton
* Un tipo imprevedibile (Happy Madison) (1996), regia di Dennis Dugan
* Miracolo alla 17a buca (1999), regia di Michael Switzer
* La leggenda di Bagger Vance (2000), regia di Robert Redford
* Bobby Jones - Genio del golf (Bobby Jones: Stroke of Genius) (2004), regia di Rowdy Herrington
* Il più bel gioco della mia vita (The Greatest Game Ever Played) (2005), regia di Bill Paxton
Hockey su ghiaccio
* Colpo secco (1977) Hill
* Spalle larghe (’86) Peter Markle
* Stoffa da campioni (’92) Stephen Herek
* Piccoli grandi eroi (’94) Sam Weisman
* Una squadra a tutto ghiaccio (’96) Robert Lieberman
* Mystery, Alaska (1999), regia di Jay Roach
* Miracle (2004), regia di Gavin O'Connor
Nuoto
* Alex (1993), regia di Megan Simpson Huberman
* Swimming Upstream (2003), regia di Russell Mulcahy
* Agua (2006) Chen
* Pride (2007)
Pallacanestro
* Yellow 33 (1971), regia di Jack Nicholson
* Voglia di vincere (1985), regia di Rod Daniel
* Colpo vincente (1986), regia di David Anspaugh
* Che aria tira lassù? (1993) Glaser
* Blue Chips - Basta Vincere (1994), regia di William Friedkin
* Chi non salta bianco è (1992), regia di Shelton
* Ritorno dal nulla (1995), regia di Scott Kalvert
* L'allenatrice (1996), regia di Steve Gomer
* Celtic Pride (1996), regia di Tom DeCerchio
* Eddie (1996)
* Rebound: La vera storia di Earl "The Goat" Manigault (1996)
* Space Jam (1996), regia di Joe Pytka
* Una ragazza vincente (1996), regia di Michael McClary
* He Got Game (He Got Game) (1998), regia di Spike Lee
* My Giant (1998) Lehmann
* Il prezzo del successo – La storia di Dennis Rodman (1998), regia di Jean de Segonzac
* Il sogno di Calvin (2002), regia di John Schultz
* Coach Carter (2005) Carter
* Glory Road - Vincere cambia tutto (2006) Gartner
Pallavolo
* Iron Ladies (Satree lek) (2000), regia di Yongyooth Thongkongthoon
* All You've Got - Unite per la vittoria (All You've Got) (2006), regia di Neema Barnette
Paracadutismo
* Omicidio nel vuoto (1994), regia di John Badham
* Cutaway (2000), regia di Guy Manos
Pattinaggio artistico
* The Cutting Edge (1992)
* Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio (Ice Princess), regia di Tim Fywell (2005)
* Blades of Glory (2007)
* Tutta colpa di un angelo
* La piccola campionessa (A promise kept)
* The Cutting Edge 2 ('In due per la vittoria') (2006)
Pesca
* Lo sport preferito dall'uomo (1964), regia di Howard Hawks
Pugilato
* Io e la boxe (1926), regia di Buster Keaton
* Il campione (The Champ) (1931), regia di King Vidor
* L’uomo di bronzo (1937) Curtis
* Passione (1939) Mamoulian
* Il sentiero della gloria (1942), regia di Raoul Walsh
* Il gigante di Boston (1945)
* Anima e corpo (1947), regia di Robert Rossen
* Pugno di ferro (1947) Rowland
* Il grande campione (1949) Robson
* Stasera ho vinto anch'io (1949), regia di Robert Wise
* L’uomo di ferro (1951) Pevney
* Furia e passione (1952) Pevney
* Era lei che lo voleva! (1953) Girolami
* The Joe Louis Story (1953)
* Il bacio dell'assassino (1955), regia di Stanley Kubrick
* Il colosso d'argilla (1956) Robson
* Lassù qualcuno mi ama (1956) Wise
* Una faccia piena di pugni (1962) Nelson
* Pugno proibito (1962)
* Per salire più in basso (1970) Martin Ritt
* Fat City – Città amara (1972) Huston
* L'eroe della strada (1975), regia di Walter Hill
* Rocky (1976) Avildsen e sequels
* Io sono il più grande (1977) Tom Gries
* Il campione (The Champ) (1979), regia di Franco Zeffirelli
* Toro scatenato (1980), regia di Martin Scorsese
* Homeboy (1988) Seresin
* Tokyo Fist (1995), regia di Shinya Tsukamoto
* La grande promessa (1996), regia di Reginald Hudlin
* The Boxer (1997), regia di Jim Sheridan
* Ventiquattrosette (1997), regia di Shane Meadows
* Incontriamoci a Las Vegas (1999), regia di Ron Shelton
* Hurricane - Il grido dell'innocenza (Hurricane) (1999), regia di Norman Jewison
* Girlfight (2000) Kusama
* Alì (2001), regia di Michael Mann
* La rentrée (2001)
* Pesi leggeri (2002) Pau
* Undisputed (2002), regia di Walter Hill
* Against the Ropes (2004)
* Million Dollar Baby (2004)
* Cinderella Man (2005)
* Jump in (2007)
* Carnera - The Walking Mountain (2008)
Rugby
* Io sono un campione (1963), regia di Lindsay Anderson
Skateboarding
* California Skate (1989), regia di Graeme Clifford
* Dogtown and Z-Boys (2001), regia di Stacy Peralta
* Lords of Dogtown (2005), regia di Catherine Hardwicke
Sport invernali
* Sapore di hamburger (’85) Savage Steve Holland
* Cool Runnings (1993), regia di Jon Turteltaub
* Vincere insieme (’92) Paul Michael Glaser
* Johnny Tsunami (’99) Steve Boyum
Surf
* Un mercoledì da leoni (1978), regia di John Milius
* Point Break (1991), regia di Kathryn Bigelow
* Il silenzio sul mare (1991), regia di Takeshi Kitano
* Johnny Tsunami (’99) Steve Boyum
* Blue Crush (2002)
Tennis
* L’ultimo gioco (’79), regia di Anthony Harvey
* Wimbledon (2004)
Tennis tavolo
* Ping Pong (2002), regia di Sori Fumihiko
* Balls of Fury (2007)
Vela
* Wind - Più forte del vento (’92) Carroll Ballard
Wrestling
* The Wrestler (2008) regia di Darren Aronofsky
Sport immaginari
* Rollerball (1975), regia di Norman Jewison
* Baseketball
* Rollerball (2002), regia di John McTiernan
* Ski Jump Pairs - Road To Torino (2006)
Lista di film sportivi. (13 febbraio 2009). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 6 marzo 2009, 07:22 da http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_di_film_sportivi&oldid=22064507.
“Manuale d’amore”, “Italians” e “Ex” sono esempi recenti di un trend destinato a crescere: i produttori italiani, e a giudicare dai risultati al botteghino anche il pubblico, preferiscono i film a episodi
Il film a episodi è una prerogativa del cinema italiano sin dagli anni d’oro della commedia, con molti degli attori e registi che hanno reso grande questo genere: Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Dino Risi, Vittorio De Sica (che con “Ieri, oggi, domani” vinse l’Oscar per il miglior film straniero nel ‘64), solo per citarne alcuni. La struttura a episodi ricorre anche nella commedia all’italiana degli anni ’70, i cosiddetti b-movies: film di calibro completamente diverso, ma come comun denominatore c’è l’intenzione di fotografare l’italiano medio, di metterne in risalto e spesso in ridicolo vizi e manie, offrendo spaccati quanto più variegati per quanto riguarda ceto e provenienza geografica. Questo linguaggio cinematografico ha poi trovato terreno fertile con un altro grande della commedia tricolore, Carlo Verdone: si è rivelato infatti ottimale per dare sfoggio della sua comicità in tutte le possibili forme, in film come “Un sacco bello” e “Bianco, rosso e Verdone”, che ci hanno regalato personaggi e macchiette memorabili. Poi sono arrivati i Vanzina e i cinepanettoni, filone che dopo un quarto di secolo ancora non conosce declino e che ogni Natale puntualmente esibisce un’umanità quantomai varia e sgangherata, basandosi sull’intreccio delle vicende di personaggi che rappresentano stereotipi, spesso opposti, dell’italianità (il romano cafone, il milanese snob). Solo negli ultimi due anni si è deciso di optare per la struttura a episodi separati, in cui i protagonisti delle diverse storie non hanno nessun contatto tra di loro, probabilmente per consentire alle varie star, ormai sempre più televisive, di avere un proprio spazio.
Fotografie di una generazione
Sembrava un modo di fare cinema relegato ad un’altra epoca, invece negli ultimi anni molti registi hanno scelto di realizzare film corali che si reggono su varie storie legate tra loro attraverso i fili più disparati, o spesso completamente staccate l’una dall’altra. Questo soprattutto da quando si è affermato un filone che ha portato alla ribalta molti giovani registi: l’affresco generazionale. A fare da iniziatore è stato l’imitatissimo Gabriele Muccino, ormai adottato da Hollywood, che con “L’ultimo bacio”, spaccato sui trentenni di oggi, confusi e spaventati dalla vita e dall’amore, ottenne un successo tale da ispirare anche un remake americano. Molti dopo di lui hanno cercato di percorrere la stessa strada: l’ultimo in ordine di tempo è Luca Lucini, uno dei nuovi alfieri della commedia sentimentale made in Italy, con “Amore, bugie e calcetto”, girotondo sentimentale con un buon cast, tra cui Claudio Bisio, Filippo Nigro, Angela Finocchiaro e Claudia Pandolfi, in cui un gruppo di amici di tutte le età condivide la passione per il calcetto e i problemi con le donne. Ancora storie parallele, ancora l’amore in raccontato in tutte le salse e attraverso ogni combinazione possibile, ma Lucini sembra un po’ indeciso se stare dalla parte di Muccino o da quella del totale disimpegno. Il risultato è un divertissment a tratti anche piacevole, ma che non riesce a lasciare il segno.
Da “Manuale d’amore” a “Ex”
Chi rimpiange le grandi storie e non apprezza questo tipo di cinema, che rischia di risultare un po’ frammentato e dal sapore televisivo, dovrà rassegnarsi: i produttori italiani sembrano voler andare sempre più verso questa direzione, specialmente di fronte all’evidenza che per ottenere un grande successo non servono necessariamente una grande idea o una sceneggiatura fortissima, ma può bastare un manipolo di star, possibilmente ben diretto.
Uno dei successi più eclatanti in quest’ambito è stato “Manuale d’amore” di Giovanni Veronesi: quattro episodi per raccontare tutte le fasi di una relazione, dall’innamoramento all’abbandono. Silvio Muccino, Jasmine Trinca, Luciana Littizzetto, Sergio Rubini, Margherita Buy e Carlo Verdone sono solo alcuni degli attori schierati. Un film a episodi ha bisogno di un’idea di fondo che leghi le varie storie e renda l’insieme credibile e non troppo eterogeneo. Se questo elemento, unito ad ottime prove recitative, era presente nel primo “manuale”, non si può dire lo stesso del secondo capitolo, parata di attori un po’ fine a se stessa che, nonostante qualche momento riuscito, nel complesso risulta poco più di una serie slegata di macchiette condita con qualche trovata furba, come la chiacchieratissima scena di sesso Bellucci-Scamarcio. Insomma, un’operazione commerciale più che un film con qualcosa da dire. Veronesi deve averci preso gusto, perché la sua ultima fatica, “Italians”, è un altro film a episodi: due, stavolta, affidati all’accoppiata inedita Castellitto-Scamarcio e all’istrionico Carlo Verdone, per raccontare gli italiani all’estero. Anche in questo caso tutte le fasce di pubblico sono accontentate ed è subito trionfo al botteghino. É proprio questa la recente tendenza delle grandi produzioni italiane, il voler giocare sicuro a tutti costi, dal momento che correre un rischio paga molto meno. Ed ecco che ai recenti successi della Filmauro rispondono i Lucisano con “Ex”: un regista quotato come Fausto Brizzi ed un cast straripante di grandi nomi sono i perfetti ingredienti per un altro successo annunciato. La commedia funziona (quasi sempre), la sceneggiatura c’è e questo è già un merito, ma la sensazione di pre-confezionato alla fine della visione è inevitabile, come se tutto fosse stato orchestrato (bene, va detto) per piacere ad un pubblico il più vasto possibile, prima che per raccontare una storia. Gli attori sono validi, ma troppi, e se alcuni sono ben collocati nella storia, altri sembrano presi appositamente per avere quel nome sulla locandina. Forse però, per il momento, è il massimo a cui la commedia italiana può aspirare.
16.02.2009 - di Emanuele Lisi da: http://www.meltinpotonweb.com
PREMESSA:
Tra i film visti, il laureato è quello che mi ha dato più emozioni.
Ben inizia la scena con un volto molto significativo: E’smarrito e incerto sull’avvenire. Tutto ciò che gli si pone dinanzi nei primi minuti è “impostato”.
Ben infatti rifiuta la parte che il suo nuovo mondo gli vuole dare: un futuro scontato e costruito da altri. La signora Robinson rappresenta quella vita tra qualche anno. Anche la Robinson probabilmente si è dovuta accontentare di una vita impostata e forse sa già che Ben vuole una vita “Diversa”.
Una scena particolare che forse sfugge è quando Ben vede il “ritratto della figlia dei Robinson” il nostro protagonista cambia il tono e l’atteggiamento.
Ben proverà la diversità di una vita con la sig. Robinson seguendo il consiglio del Signor Robinson “spassandosela con le donne” (uscendo poi con la Signora Robinson) Ben seguirà il consiglio per provare questa vita diversa e meno impostata.
La metafora della vita impostata torna nuovamente quando si fa il bagno in piscina vestito da sub, il bello è che i suoi genitori gli trattengono la testa sott’acqua quando cerca di risalire per uscire e provare a fare qualcosa che vuole: “respirare un po’”. Questa scena è una metafora del seguire un percorso “impostato”, per tale ragione subito dopo tenterà una via di fuga con la sig. Robinson.
Fino a questo momento siamo all’inizio, il nostro protagonista varca la soglia della sua vita nuova quando va in albergo con la signora Robinson.: 1° approccio per una vita diversa o così sembra…anche se tutto è innaturale come la scena in cui fanno l’amore.
Ben è ancora impacciato e impostato.
Ora Ben galleggia in piscina sdraiato su un lettino gonfiabile, è significativa questa immagine perché ci rimanda al significato di vedere da una prospettiva diversa la nuova vita, non più sott’acqua, ma a galla…ma una cosa non cambia: “LO SGUARDO è SEMPRE VUOTO”
È lo sguardo che segna la via giusta da seguire in Benjamin. E nel diverbio con la signora Robinson che seguirà, Ben farà presente i suoi disappunti su come sta vivendo. In realtà sta seguendo la vita diversa che la Sig. Robinson vuole avere
Ben è a galla in piscina, ma poi…cade ancora sott’acqua con lo sguardo perso nel vuoto.
Ben non vuole uscire con la figlia dei Robinson, perché da quanto si ricorda molti anni prima non andavano d’accordo. Ora la signora Robinson ha lo stesso sguardo di Ben “perso nel vuoto” perché non vuole che esca con la figlia. Ben assicura che non ci uscirà più e se lo fa è solo perché è stato costretto…
Ma quando la vede, impercettibilmente, il suo sguardo è più rassicurato e interessato anche se fa di tutto per farla allontanare.
LA SCENA SIGNIFICATIVA
Il bacio che gli da fuori dal club della spogliarellista sancisce o chiude quelle impercettibili fasi “il ritratto” e “il primo incontro” in cui Ben si sente più coinvolto più a proprio agio.
Questa scena è a quasi metà film e Ben esterna i suoi sentimenti e i suoi “villani” modi di comportarsi…Ora infatti è lui il trascinatore è lui che cerca intimità, ora finalmente sorride spontaneamente…è una scena cruciale del film ,qui Ben, conosce le due realtà “la sua strada” e “quella degli altri”. La difficoltà è quella di tagliare la corda dalla vita degli altri e seguire la propria…questa scena è la prima che ho amato di più, per la situazione che si è venuta a creare.
La vita degli altri sembra senza via di fuga e Ben è incastrato in una realtà che non gli appartiene, da ora in poi dipenderà da lui e avendo conosciuto ed essendosi innamorato della strada che cercava, non può e non vuole tornare indietro.
Il finale è una delle scene più belle mai viste, a parer mio. Quando corre dietro l’autobus con ELEINE a bordo( una metafora di lui che corre dietro il suo sogno) Quando arriva nella chiesa e grida il nome di ELEINE. Tutta la sua disperazione è nel fatto che sta perdendo ciò che ha reso la sua vita diversa: L’amore per Eleine.
Ma la scena davvero significativa è l’ultima e nuovamente sul volto di Ben, questa volta SALITO SUL PULLMAN INSIEME AD ELEINE Ben corre verso qualcosa e ride con gioia, i suoi occhi hanno trovato ciò che cercavano. Una vita “diversa” ma voluta.
COMMENTO DI G.M.
di Francesco Spagnuolo
 Quello di Kubrick su Napoleone, quello di Leone con un complicatissimo piano sequenza, molti di Welles e poi di Hitchcock, Lynch, Spielberg e Coppola. Oltre a essere piena di film, la storia dei film è anche piena di film che non lo sono diventati. Alcuni sono rimasti nella testa dei registi che li hanno immaginati, altri sono diventati una sceneggiatura o si sono trasformati in qualche scena. Qualcuno è persino stato tutto girato ma poi non è stato montato. A volte è stata colpa dell’indecisione di chi li ha fatti, più spesso si è trattato di questioni di soldi: perché (questa torna buona come frase motivazionale da appendere in camera) anche i migliori registi della storia del cinema hanno faticato – spesso fallendo – a convincere qualcuno a spendere tutti quei soldi per il film che avevano in mente.
Quello di Kubrick su Napoleone, quello di Leone con un complicatissimo piano sequenza, molti di Welles e poi di Hitchcock, Lynch, Spielberg e Coppola. Oltre a essere piena di film, la storia dei film è anche piena di film che non lo sono diventati. Alcuni sono rimasti nella testa dei registi che li hanno immaginati, altri sono diventati una sceneggiatura o si sono trasformati in qualche scena. Qualcuno è persino stato tutto girato ma poi non è stato montato. A volte è stata colpa dell’indecisione di chi li ha fatti, più spesso si è trattato di questioni di soldi: perché (questa torna buona come frase motivazionale da appendere in camera) anche i migliori registi della storia del cinema hanno faticato – spesso fallendo – a convincere qualcuno a spendere tutti quei soldi per il film che avevano in mente.
Il bello dei film che non esistono è che sono rimasti tali e quali a come li desiderava il loro autore: il brutto è che si possono solo immaginare e raccontare. Di seguito abbiamo raccolto le storie di quelli più famosi e di quelli che ci piacerebbe che esistessero: il tutto con tanti condizionali, tanti forse e tanti pare che. Se anziché immaginare preferite sperare potete leggere la storia a – forse – lieto fine di The Other Side of the Wind, il film incompiuto (uno dei tanti) di Orson Welles, che ora sarà finito grazie a Netflix.
COSA NON VA NEL CINEMA ITALIANO? PIERA DETASSIS DOMANDA E PARTE IL VELENO DEGLI ADDETTI AI LIVORI: MANCANO IDEE, BRAVI AUTORI E FANTASIA. TROPPI GAY MACCHIETTA E DONNE ISTERICHE – E BASTA CON L’ACCENTO ROMANO ANCHE SE IL FILM SI SVOLGE IN ALTO ADIGE…
A Ferzan Ozpetek e Fausto Brizzi, a Federico Moccia, oltre ai fratelli Vanzina, e un po' anche ai fratelli Muccino, devono fischiare le orecchie. "Ciak", la rivista del cinema italiano diretta da Piera Detassis, ha fatto un'inchiesta tra i critici cinematografici per capire cosa non vada nel cinema italiano. Un cinema in ripresa, sotto certi aspetti, e infatti tutti citano la doppietta di Cannes, apprezzata anche negli Usa, di "Il Divo" e "Gomorra". Ma anche molto omologato e omogeneizzato, nel ruolo per gli attori, negli intrecci, nelle ambientazioni.
Il risultato dell'indagine, curata da Massimo Lastrucci e Stefano Lusardi, con Alessandra De Luca e Andrea Morandi, in sintesi è questo: troppi gay, ridotti a macchiette (Violetta Bellocchio, "Rolling stones") donne solo isteriche (contro Margherita Buy e Laura Morante si va già pensate, come Raffaella Giancristofaro, "Rolling Stones"), troppe notti prima degli esami «che non supereranno perché sono ignoranti e volgari» (Maurizio Porro, "Corriere della sera"), troppi film generazionali, attoruncoli presi da tv e in particolare reality show.
Teresa Marchesi, Rai3, parla di «vent'anni di cernobylizzazione televisiva del pubblico»; e se non lo sa lei che lavora in tv. Per molti, la musica è sempre la stessa, rock inglese e Vasco Rossi a tutto spiano. Ma la vera stonatura è il romanocentrismo linguistico, oltre che scenografico e narrativo.
Le donne sono isteriche e di passione ce n'è poca e poco credibile: si fa l'amore senza togliersi i pantaloni. Va bene le precauzioni, ma così non ci crede nessuno.
Sesso poco e fatto male, mentre di lucchetti dell'amore e della stessa parola amore nel titolo dei film non se ne può più.
I cinepanettoni? Ne parlano tutti male, tranne il democristianissimo Gian Luigi Rondi. «Permettono incassi utili all'industria», dice; ma è un commento da critico o da commercialista? Pasolini, buonanima, diceva: «Sei così ipocrita, che come l'ipocrisia ti avrà ucciso sarai all'inferno, e ti crederai in paradiso»). Certo è che a tutti, alla fine, tocca dedicare pagine e pagine per «mangiare il panettone».
Emergono problemi strutturali e di dialettica produttiva, pochi investimenti di privati, colpa anche del duopolio Rai-Medusa, e confusione tra registi e autori, con un lavoro di scrittura sempre deficitario (Mariarosa Mancuso, del Foglio, «i bravi registi non sono necessariamente bravi sceneggiatori, e vale anche il contrario»). Ma c'è soprattutto un problema architettonico, di arredamento. Insomma, immobiliare.
Le scenografie, per i critici italiani, sono sempre uguali a se stesse, improntate a pauperismo, minimalismo al punto da essere spesso descrivibili per un annuncio immobiliare. Quasi in coro, dicono basta con «il solito microcosmo fatto di cucina e tinello» (Massimo Rota, "I duellanti"), con «i frigoriferi sempre vuoti» (Michele Anselmi, "Il Riformista"), «le storie 3 camere e cucina» (Giovanni Spagnoletti, "Close-Up"), diventate «due camere e cucina» (Sandro Rezoagli, "Ciak"), «salotti borghesi, cucinotti proletari e terrazze con vista gasometro» (Federico Pontiggia, "La rivista del cinematografo"), «salotti con mobili e suppellettili firmati da designer e cucine etniche (come quelle di Ozpetek)» (Bruno Fontana, "Cineforum"). Piacciono poco anche le ville in campagna per ritrovarsi a elaborare lutti di amici scomparsi.
In barba - o forse rimpiangendo - Fellini e Pasolini, l'ostilità si concentra però verso Roma. Priva dei fasti di Cinecittà, ridotta a location antropologica intollerabile, per quasi tutti. Roma, ovviamente, va intesa come ambientazione, come patina linguistica, come intreccio narrativo standardizzato. Basta «Roma», grida Mauro Gervasini, "Filmtv", basta «romanità» rilancia Alberto Barbera, museo cinema di Torino.
Emanuele Martini non sopporta più i «ragazzini che parlano romanesco» (Torino film festival): complotto torinese? No, anche Alberto Crespi, "l'Unità", non sopporta più «i bambini che parlano romanesco anche quando la trama si svolge in Alto Adige». E Raffaella Giancristofaro ("Rolling Stones") sottoscrive: basta «attori che recitano in romanesco anche se il film è girato a Praga». Tutti trovano assurdo che ovunque, in Italia e nel mondo, i film italiani abbiano attori che parlano come i ragazzi di Pasolini.
Scorrendo questo interessante spaccato dei critici italiani, assai divertente perché ognuno, a turno, sputa quel po' di veleno che magari nelle recensioni non si può sempre tirar fuori, si ha l'impressione che il serpente - cioè i critici - si mordano la coda. C'è chi addirittura si lamenta degli Uffici stampa perché «PROVINCIALI», risponde a caratteri maiuscoli Aldo Fittante, «POCO FANTASIOSI E POCO PROFESSIONALI», colpevoli, dando fiducia solo alla stampa quotidiana, «di non aver fatto crescere nell'immaginario italiano la consuetudine alla rivista, al settimanale, al periodico specializzato».
Ma come, la qualità di una rivista è data dall'eco che ha negli uffici stampa? Nessuno, purtroppo, ha riflettuto sulle responsabilità della critica. Attori, registi, sceneggiatori, colonne sonore, arredatori, tutti sono responsabili, secondo i critici. Ma i critici? Quanti scrivono una recensione in base, liberamente, ai propri gusti? Quanto le proprie egotiche idiosincrasie possono danneggiare un bel film? Quanti fenomeni di massa e successi di moda bisogna rincorrere per cercare una legittimazione?
Luca Mastrantonio per "Il Riformista"
 ... poi venne la crisi del 1956 in quanto gli americani cercavano di soffocarci e per un anno non si batteva un chiodo. Fino a che Pietro Francisci salvò il cinema italiano (non è mai stato riconosciuto da nessuno) con "Le fatiche di Ercole". La moda della barba che in fondo è venuta da Ercole, è dovuta ad una pochade di Labiche del 1880 che io vidi alla televisione. C'era un bell'uomo con la barba (era Nino Pavese). Pensai che con la barba e baffi erano tutti più belli. La mattina dopo vado da Francisci in produzione a guardare le fotografie dei culturisti. Steve Reeves era il meglio di tutti... gli telegrafammo di farsi crescere la barba. Lui arrivò e ci fu il boom del cinema italiano.
... poi venne la crisi del 1956 in quanto gli americani cercavano di soffocarci e per un anno non si batteva un chiodo. Fino a che Pietro Francisci salvò il cinema italiano (non è mai stato riconosciuto da nessuno) con "Le fatiche di Ercole". La moda della barba che in fondo è venuta da Ercole, è dovuta ad una pochade di Labiche del 1880 che io vidi alla televisione. C'era un bell'uomo con la barba (era Nino Pavese). Pensai che con la barba e baffi erano tutti più belli. La mattina dopo vado da Francisci in produzione a guardare le fotografie dei culturisti. Steve Reeves era il meglio di tutti... gli telegrafammo di farsi crescere la barba. Lui arrivò e ci fu il boom del cinema italiano.
di Mario Bava
Testo tratto da La città del cinema, Edizioni Napoleone 1983 (ora in «Dizionario del Cinema Italiano», Edizioni Gremese).
Il filone degli Ercoli e Maciste l'ha inventato De Concini.
Lui ebbe l'idea del primo Ercole, e così nacque il genere. Gli nacque con Francisci. Francisci aveva fatto dei filmetti, negli anni `50, tipo "La regina di Saba", che già avevano molte di queste cose fantastiche. E alle spalle c'erano sempre "La corona di ferro", Ulisse... Credo che il boom di questi film sia dovuto anche a com'era l'Italia di quegli anni, con tutti questi cambiamenti, e questi contadini inurbati, disorientati... Erano film che andavano molto bene anche nel Terzo Mondo.
Francisci aveva avuto la pensata di sfruttare un Mister Muscolo, però come un Ercole ancora dentro imprese realistiche. De Concini invece ebbe la botta di genio di farne un Ercole tutto sopra le righe, un Ercole che, se lanciava un disco, questo disco diventava veramente un disco volante, non si fermava più. Con la partecipazione straordinaria di Castore e Polluce sul modello delle gemelle Kessler, ossia vestiti uguali e uguali nei movimenti.
di Duccio Tessari  Sì, in un momento di crisi cinematografica ho inventato i cosiddetti "sandaloni", gli Ercole.
Sì, in un momento di crisi cinematografica ho inventato i cosiddetti "sandaloni", gli Ercole.
Era un periodo in cui Il cinema italiano sembrava morto. E allora dissi: «Ma perché non facciamo una favola con un personaggio da favola?». A pensarli e scriverli mi divertii moltissimo, tanto che poi diventai una specie di firmatore ad onorem di questi film, perché tutti quelli che facevano pellicole di “sandaloni” venivano a farmi firmare i copioni, anche se non li avevo scritti mi pagavano soltanto perché li firmassi, dato che in un certo senso ero stato il padre di questo tipo di film.
Mi era venuto in testa di farli semplicemente perché l'idea di travisare Ercole in chiave ironica mi divertiva molto. E difatti questi film erano molto ironici, c'erano battute tipo: «Esculapio, muoviti, traversa il fiume e vieni qua!» con Esculapio che rispondeva: «Non posso, non ho ancora inventato niente contro i reumatismi!». Oppure: «Ehi, tu, bel giovane dallo sguardo furbo, come ti chiami?», «Ulisse!», «Ah, da grande ti chiameranno l'astuto Ulisse».
Insomma erano film fatti così, ridendoci sopra, con un regista però, che ci credeva molto e che amava queste cose. E fu certamente questo a fare la loro fortuna.
Il regista si chiamava Pietro Francisci, ed era un uomo molto semplice. Il nostro primo film della serie, "Le fatiche di Ercole", interpretato da Steve Reeves, non costò neanche 100 milioni, e in America ha incassato non so quanti milioni di dollari, credo dieci! Comunque, quando mi venne l'idea per questo personaggio buono e forzuto, per Ercole, uno a cui tutti gli uomini in cuor loro sognano di somigliare, nessuno dei produttori nostri era propenso a realizzarla, tutti storcevano il naso. L'unico a coglierla al balzo fu Nello Santi, anche perché Francisci la sostenne molto e loro erano reduci da alcuni film di successo fatti assieme tipo "Orlando e i paladini di Francia". Quelli però erano film più avventurosi mentre qui c'era la favola per bambini proposta nella maniera più elementare e più semplice alla evasione degli adulti. E da Ercole a Maciste il passo fu molto breve.
di Ennio De Concini
Reeves era un culturista.
Deve tutto a un signore che si chiama Giovanni Cianfriglia, uno stuntman, che da vicino gli somigliava abbastanza e da lontano era un suo sosia. Era Cianfriglia a fare qualsiasi cosa forzuta o faticosa nei suoi film. Reeves, prima di cominciare una scena, si limitava a gonfiare i muscoli uno per uno con dei movimenti di ginnastica. Erano però muscoli turgidi di proteine, burro e miele, che non avevano nessuna forza. Difatti, non ce la faceva neppure a sollevare tra le braccia una attrice. Era sempre Cianfriglia di spalle che la tirava su, poi, in campo ravvicinato, Reeves lo sostituiva mentre però fuori campo la ragazza era puntellata da sotto da un macchinista rannicchiato a mo' di cariatide. Inoltre, non aveva assolutamente il senso dell'equilibrio e alla minima richiesta di una corsa sbatteva delle terribili culate a terra. Sul set era seguito come un'ombra da una ragazza polacca che poi divenne sua moglie, la quale lo curava attentamente, credo lo limitasse anche sessualmente per non affaticarlo. Era comunque consapevole in pieno di vivere un fenomeno momentaneo di cui doveva profittare al massimo badando a risparmiare per l'avvenire. Difatti era di una tircheria sordida.
di Duccio Tessari
Testi tratti da: L'avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti 1935-1959, a cura di Franca Faldini e Goffredo Fofi, Feltrinelli, 1979.
IL GLADIATORE di Ridley Scott
Sceneggiatura: David H. Franzoni, John Logan, William Nicholson; musiche: Klaus Badelt. Lisa Gerrard, Hans Zimmer; fotografia: John Mathieson; montaggio: Pietro Scalia; scenografia: Arthur Max; architetto-sceno-grafo: Keith Pain: arredatori: Jille Azis, Elli Griff, Sonja Klaus, Crispian Sallis; costumi: JantyYates. Interpreti: Russell Crowejoaquin Phoenix. Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris. Derek Jacobi, Djimon Hounsou, David Schofield, John Shrapnel. Tomas Arana, David Hemmings. Gianina Facio. Giorgio Cantarini. Colore (Technicolor). UK/USA, I 999/2000.
LE FATICHE DI ERCOLE di Pietro Francisci
Dal poema Le Argonautiche di Apollonio Rodio. Adattamennto di Pietro Francisci; sceneggiatura: Ennio De Concini, Pietro Francisci, Gaio Frattini: musiche: Enzo Masetti, dirette da Carlo Savina; fotografia ed effetti speciali: Mario Bava; montaggio: Mario Serandrei; architetto-scenografo: Flavio Mogherini; arredatore: Flavio Mogherini; costumi: Giulio Coltellacci. Interpreti: Steve Reeves. Sylva Koscina, Fabrizio Mioni, Ivo Garrani, Arturo Dominici, Mimmo Palmara, Lidia Alfonsi, Gina Rovere, Luciana Paluzzi, Lily Granado. Gianna Maria Canale. Afro Poli, Aldo Fiorelli, Gino Mattera, Andrea Fantasia, Gian Paolo Rosmino, Gabriele Antonini. Prodotto da Federico Teti per la Oscar Film, Galatea. Colore (Eastmancolor). Italia, 1957.
---------------------------
COLOSSEO - PEPLUM
Passeggiate Romane partecipa ad uno dei grandi eventi dell'estate in città: l'istituzione dell'isola pedonale dei Fori, suggestiva indicazione a tutti i romani (siano essi i cittadini stanziali che i turisti sempre più rapiti dalla città) di come può essere vissuta una delle aree più spettacolari di Roma. Ed è certo una suggestione antica e attualissima allo stesso tempo, quella che ha provato chi si è trovato a passeggiare per quest'area in queste settimane. Così sarà anche per chi vorrà seguirci in questa macchina del tempo del cinema peplum, mitologico o dei "sandaIoni" che dir si voglia. A "II gladiatore", recente reincarnazione planetaria-hollywoodiana del genere abbiamo affiancato il mitico (è veramente il caso di dirlo!) "Le fatiche di Ercole", il vero e primo capofila, il film che "salvò il cinema italiano" (proprio dallo strapotere di Hollywood), in una copia recentemente ristampata dalla Cineteca Nazionale in occasione di una importante retrospettiva tenutasi all'ultimo Festival di Locarno.
Testi da LA CITTA' SU GRANDE SCHERMO del Comune di Roma e Associazione Roma Città di Cinema - 2001
Ingrid Bergman, Buster Keaton, Orson Welles, Stanley Kubrick. Ma c’è anche il restauro di Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti e di Ascensore per il patibolo di Malle con un Miles Davis spolverato di fresco, un cortometraggio inedito di Truffaut e un altro documentario mai visto di Aki Kaurismaki, i film in Technicolor di Hitchcock, Tourneur, Anthony Mann e perfino il Mago di Oz in 3D. Basta aprire il catalogo, o tuffarsi dentro alle otto sale della 29esima edizione del Cinema Ritrovato (27 giugno – 4 luglio 2015), per ritrovare tra gli oltre 420 titoli qualcosa che può andare a genio allo spettatore: dal muto di fine ottocento, ai grandi titoli degli anni ’10, per arrivare a La sottile linea rossa di Terence Malick.
Lo chiamano il “paradiso dei cinefili” e forse approssimano per difetto. Intanto perché vista la quantità, i titoli e le novità potrebbero benissimo parlare anche di inferno e purgatorio, intesi come film maledetti nel primo caso ritornati alla luce, o film dimenticati nel secondo caso quindi accantonati temporaneamente. “È complesso presentare questo festival. Il punto è che viviamo una rivoluzione: a differenza dei nostri nonni noi oggi abbiamo a disposizione una memoria sempre più estesa, almeno 120 anni di immagini in tasca. Forse stanno diventando troppe, ma abbiamo la possibilità esclusiva di comporre ognuno il proprio percorso a seconda dei gusti personali”, spiega Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, sotto la cui egida si organizza e svolge il Cinema Ritrovato.
Quindi bisogna andare con ordine e salutare il profeta del Cinema Ritrovato, quel cinefilo del direttore Peter Von Bagh che ci ha lasciati poco tempo fa e che tutto recuperava, indirizzava e sceglieva: “È impossibile sostituirlo. Per questo abbiamo composto un board internazionale, un comitato scientifico del festival, al quale appartengono Alexander Payne, Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker e il premio Oscar Kevin Brownlow”.
Gente che oltre a fare cinema, prova spesso a recuperarlo e a mostrarlo a larghe platee. Ecco che elencare le sette sere in cui gli highlight restaurati del Cinema Ritrovato vengono mostrate gratuitamente nell’immensa Piazza Maggiore di Bologna davanti a migliaia e migliaia di nasi puntati all’insù diventa imbarazzante: il citato Louis Malle (sabato 27 giugno); Il terzo uomo di Carol Reed (28); l’omaggio a Von Bagh con il suo Olavi Virta (29); Malick (30); Casablanca di Curtiz introdotto da Isabella Rossellini (1 luglio); il restauro de La Palla n.13 e One Week di Buster Keaton accompagnate da un’orchestra dal vivo (2); Visconti il 3; e infine l’unica copia in 70mm conservata al mondo di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, quella che comprende l’Intervallo in nero proiettato sullo schermo con tanto di Zarathustra di Strauss che continua a sentirsi mentre si va a prendere il gelato o il ghiacciolo.
Essendo un festival di ricerca e non una competizione tra opere prime, bisogna andare a scavare tutto l’anno e procedere nel recupero delle opere nascoste e dimenticate. Si passa così dal centenario della nascita di Ingrid Bergman (ci sono gli esordi svedesi e tedeschi degli anni trenta e perfino le riprese dell’attrice con il suo Super8 delle prime marce naziste e dei cartelli antiebraici appesi fuori dai negozi) a titoli della misconosciuta Nouvelle Vague iraniana degli anni sessanta; i filmati inediti di una troupe inglese entrata nel campo di concentramento di Bergen Balsen nel ’45 e le donne registe della Bluebird tra il 1916 e il ’19; le due retrospettive su Renato Castellani e Leo McCarey, e i più classici progetti Chaplin e Keaton. Tra l’altro di quest’ultimo ricorre appunto il centenario della nascita e si rivedranno due capolavori tra cui quel One Week con la lunga sequenza della costruzione della casa a cui perfino Frank Lloyd Wright deve aver dato un’occhiatina. Insomma, non esiste angolo del pianeta in cui il Cinema Ritrovato non sia andato a pescare, tanto che c’è perfino il pioniere del cinema africano, il tunisino Albert Samama Chickly, film e foto di un artista, avventuriero, sposatosi con un italiana, che riuscì a filmare perfino i soldati africani che prestarono servizio sul fronte francese nel ’14-’18, facendosi gasare a Ypres e mitragliare a Verdun.
di Davide Turrini per ilfattoquotidiano.it
 film con questo linguaggio cinematografico - sottolinea - è un impresa colossale, un impegno pazzesco: ho dovuto imparare a memoria 150 pagine di sceneggiatura, gli attori conoscevano soltanto la loro parte». La storia, scritta da Nero con Timothy Keller, s’incentra su Paolo, uno scrittore che sta cercando di ultimare il primo romanzo: il film comincia con lui che litiga con la fidanzata, va al bar dove incontra un vecchio compagno di scuola che si arricchisce con lo sfruttamento della prostituzione, poi va alla ricerca di una poesia cantata da dedicare alla sua ragazza. Il protagonista è Daniele Savoca, in evidenza lo scorso anno sul piccolo schermo con «Le stagioni del cuore»; al suo fianco recitano Giorgia Cardaci, la segretaria del direttore nella situation comedy di Italia 1 «Camera Cafè», Tiziana Catalano e Simona Nasi. Film sull’incomunicabilità, «Pianosequenza» è stato presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ora comincia il suo cammino nelle sale e dopo Torino uscirà nelle prossime settimane, distribuito da L’Altrofilm e Rven, in una trentina di città italiane.
film con questo linguaggio cinematografico - sottolinea - è un impresa colossale, un impegno pazzesco: ho dovuto imparare a memoria 150 pagine di sceneggiatura, gli attori conoscevano soltanto la loro parte». La storia, scritta da Nero con Timothy Keller, s’incentra su Paolo, uno scrittore che sta cercando di ultimare il primo romanzo: il film comincia con lui che litiga con la fidanzata, va al bar dove incontra un vecchio compagno di scuola che si arricchisce con lo sfruttamento della prostituzione, poi va alla ricerca di una poesia cantata da dedicare alla sua ragazza. Il protagonista è Daniele Savoca, in evidenza lo scorso anno sul piccolo schermo con «Le stagioni del cuore»; al suo fianco recitano Giorgia Cardaci, la segretaria del direttore nella situation comedy di Italia 1 «Camera Cafè», Tiziana Catalano e Simona Nasi. Film sull’incomunicabilità, «Pianosequenza» è stato presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ora comincia il suo cammino nelle sale e dopo Torino uscirà nelle prossime settimane, distribuito da L’Altrofilm e Rven, in una trentina di città italiane. Da La Stampa 24 febbraio 2005 di Daniele Cavalla
Da Il Manifesto, 11 Marzo 2005 di Silvana Silvestri
Da Il Messaggero, 18 Febbraio 2005 di Francesco Alò
Pianosequenza
da http://www.mymovies.it/dizionario ricercando la parola Sperimentale
“Le ombre rosse”
Uscita in Italia: venerdì 4 settembre 2009 / Distribuzione: 01 Distribution

Titolo originale: “Le ombre rosse”
Genere: drammatico
Regia: Francesco Maselli
Sceneggiatura: Francesco Maselli
Musiche: Giovanna Marini, Angelo Talocci
Sito web ufficiale (Italia): nessuno
Cast: Roberto Herlitzka, Valentina Carnelutti, Flavio Parenti, Lucia Poli, Luca Lionello, Carmelo Galati, Veronica Gentili, Eugenia Costantini, Roberto Citran, Federica Flavoni, Valerio Morigi, Letizia Sedrick, Giovanni Capalbo, Alessandro Averone, Gabriele Bocciarelli, Ninni Bruschetta, Laurent Terzieff, Daniela Piperno, Pino Strabioli, Ricky Tognazzi, Ennio Fantastichini, Arnoldo Foà
La trama in breve…
Un intellettuale di fama mondiale viene invitato nel centro sociale “Cambiare il mondo”, creato nei locali fatiscenti di un vecchio cinema romano. L’uomo resta profondamente colpito dal fermento e dalla vita che anima questo luogo. Da una intervista rilasciata alla “Tv di strada” nasce casualmente un’idea rivoluzionaria: da questi luoghi giovanili così vitali possono svilupparsi delle realtà socialmente e culturalmente innovative. L’idea raccoglie l’entusiasmo generale e diventa un progetto destinato a creare grande clamore mediatico. Si apre un caso internazionale. Tutti si mobilitano e vogliono cavalcare l’occasione. Ma quel fermento vitale che tanto aveva colpito l’intellettuale viene ben presto stravolto, fatto oggetto di diatribe e scontri tra le diverse anime della sinistra. Fino allo smarrimento.
Note di regia
A sessant’anni da quello che, con il documentario “Bagnaia paese italiano” proiettato e premiato nella Venezia del 1949, fu il mio esordio professionale, mi trovo davanti gli stessi identici problemi di allora. Avevo diciotto anni e mi ero cinematograficamente formato sul cinema francese degli anni Trenta e poi sul Visconti di “Ossessione” e “La terra trema”. E dunque già da quel mio piccolo documentario di esordio mi ponevo i due temi che soprattutto Jean Renoir ci aveva indicato: gli sfondi – e cioè l’importanza delle azioni che s’intravedono dietro l’azione principale dei protagonisti – e l’inquadratura legata che oggi si chiama piano sequenza…
…anche qui nel centro sociale che ci siamo reinventati con Dentici nel vecchio cinema Paris, mi trovo davanti questi due vecchi temi di regia: con la differenza che nel frattempo ho avuto la possibilità di parlarne direttamente sia con Renoir che con Visconti. E soprattutto con Antonioni di cui, giusto in quel 1949, ero stato aiuto regista ne “L’amorosa menzogna” iniziando anche a scrivere con lui “Cronaca di un amore”.
Perché gli anni e anche i mezzi secoli passano, ma le indecisioni su una determinata inquadratura – come la notte in bianco per decidere in angoscia come risolvere una scena che sai fondamentale – restano identici. Per me, poi, che fin da “Storia di Caterina” e “Gli sbandati” mi trovo sempre nell’impossibilità di mettere in scena quello che è stato scritto magari sei mesi prima nel chiuso di una stanza.
… così, per questi appunti di regia mi trovo oggi a dire l’ansia quasi infantile per quell’ultima scena che finisce con la vittoria delle destre che ho riscritto di notte nello studio fotografico che, con Dentici, avevamo trasformato in una specie di loft preparato dall’editore per Siniscalchi-Herlitzka. Era una scena difficile e non è un caso che, con Marzia Mete, l’abbiamo ancora rielaborata in fase di montaggio.
In fase di montaggio e di edizione, del resto, io rivedo sempre profondamente i miei film: me l’aveva insegnato Cristaldi durante le lavorazioni dei cinque film che abbiamo fatto insieme e, insieme al rapporto creativo che stabilisco tutte le volte che è possibile con gli attori, è diventato parte del mio modo di lavorare…
STEFANO RODOTÀ, FURIO COLOMBO e GIOVANNI BERLINGUER su FRANCESCO MASELLI
(dalle prefazioni tratte dal libro “Cultura e politica nel cinema di Francesco Maselli” di Giacomo Gambetti di imminente pubblicazione, CG Editrice elettronica)
Citto non sa quando per la prima volta cadde su di lui il mio occhio cinefilo. Uso questo termine (che non mi piace) perché con il cinema coltivo un vecchio amore, ne ho scritto in tempi lontani, ho presieduto quello che, negli anni ’50, era il più grande cineclub d’Italia, il Centro universitario cinematografico di Roma. E proprio qui, trovato forse da uno dei fratelli Leto o da Lino Del Fra, vidi il suo Bagnaia paese italiano, perché andavamo alla ricerca di cortometraggi di qualità (doveva essere una serata in cui vennero proiettati anche Nettezza urbana e L’amorosa menzogna di Michelangelo Antonioni). Venne di lì a poco l’esordio con Gli sbandati, e poi La donna del giorno, I delfini, Gli indifferenti: e io gli andavo dietro, sempre più convinto non solo dal suo modo di rappresentare la società italiana, ma proprio dal suo fare cinema, dal suo linguaggio forte (che pena guardare oggi le tante, piatte trascrizioni che ci affliggono!).
Non mi giunse inattesa, quindi, la Lettera aperta a un giornale della sera, che tuttavia mi parve una svolta per la capacità di penetrazione, la mancanza d’ogni compiacenza, che davano al suo realismo uno spessore che lo distingueva da tutti gli altri. Non è questo il luogo per seguire l’intera sua filmografia. Ma non posso tacere de Il sospetto, che per stile, asciuttezza, rigore della narrazione rimane profondamente impresso nella mia memoria. Né dell’ultimo suo lavoro, il fortissimo Civico 0, che spinge la sua scoperta dove nessuno si era avventurato: il mondo delle nuove oppressioni e solitudini, dell’umanità dei cassonetti e dei bordi delle strade, che oggi troppi vogliono nascondere attraverso i divieti, invece di avviare quella comprensione sociale che proprio il lavoro di Citto può contribuire a costruire. E ancora il linguaggio, il bianco e nero, il sonoro in presa diretta…
Stefano Rodotà
Citto Maselli è l’allegro e disperato autore italiano di un cinema che non c’è. È un carovaniere avventuroso che si spinge nei canyon del non detto e del non visto, non perché vada lontano, ma perché il suo esotico è dentro le case, le vite, i legami, le solitudini, le festose speranze e il precipitare brutale di qualunque percorso nelle nostre vite quotidiane. Col suo testardo rifiuto di invecchiare (tutto interiore, tutto di testa, ma che finisce per riflettersi non solo nel suo immaginare, ma anche in come noi lo vediamo in quel suo continuo andare) Citto Maselli riesce a vedere, riesce a filmare ciò che noi non vediamo, per esempio l’incrocio dei sentimenti con la politica.
Il punto in cui la più intima e la più privata delle storie si impiglia nella rete dei grandi eventi pubblici, il momento che trasforma in militanza o partecipazione o accettazione o consapevolezza un sentire (d’amore, di odio, di attesa, di rabbia, di disperazione, di routine, di festa) che – diresti – non ha niente a che fare con gli altri, non ha niente a che fare con il mondo. Invece c’è sempre il mondo, tutto presente, nelle messe in scena spesso intellettuali, spesso eleganti, spesso di sentimento apparentemente privato, di Citto Maselli.
È come se nella scena “borghese” e qualche volta “proletaria” – ma sempre storia di alcuni – del suo cinema fossero presenti l’Africa con la sua fame, l’America Latina con le sue sanguinose lotte contraddittorie, le ferite aperte delle guerre del mondo, gli Usa in cerca di un senso perduto del che fare e del dove andare, del che cosa essere.
Ecco, un cinema in apparenza da camera, in apparenza elegante e mite, a volte persino mondano, a volte duro e aspro, si svolge di fronte a una platea immensa, la Storia, ai nostri giorni, da cui l’autore non vuole, non sa separarsi. È ciò che fa diventare ogni volta un film di Citto Maselli – magari girato con due soldi – un grande spettacolo.
Furio Colombo
Quando venni a Roma dopo la Liberazione, per proseguire gli studi e l’impegno politico, il primo incontro fu con Carlo Lizzani, dirigente dei giovani e cineasta “in pectore”. Poco dopo conobbi Citto Maselli, chiaramente orientato verso la cinematografia: e fummo amici per sempre. Ebbi poi la gioia di conoscere altri giovani registi, come Giuliano Montaldo ed Ettore Scola, e fui da loro indottrinato verso i sogni, le difficoltà e le soddisfazioni di chi sa trasformare le idee e i progetti in persone, immagini e storie.
Anni dopo fui arricchito di conoscenze (e più ancora di sentimenti) da un’insegnante personale, Giuliana, che frequentava allora l’Accademia di arte drammatica. La sposai nel 1958, e abbiamo goduto mezzo secolo di felicità. Sposai anche Citto, ma non equivochiamo. Parlo del rapporto fra Citto e Stefania Brai, che sono convissuti a lungo con molto amore e con due abitazioni. Quando decisero di unirsi, non certo per ragioni condominiali, si ricordarono che io ero stato consigliere comunale di Roma, abilitato quindi a legalizzare matrimoni; e mi chiesero di officiare la cerimonia. Ci fu gioia e perfino commozione, e adesso c’è una sola abitazione e un solo cuore.
Ho da aggiungere, ovviamente, che la politica è stata sempre presente tra le persone di cui ho parlato. Ci ha aiutato a congiungere le nostre speranze e le nostre idee, e a ricercare i temi, i linguaggi e gli scopi da raggiungere, nell’interesse di tutti. Oltre che impegnarsi nella politica, Citto ha dedicato due terzi della sua vita a filmare, e un terzo a promuovere, stimolare, organizzare. E’ stato a più riprese (ed è ora) presidente dell’ ANAC, la prestigiosa Associazione nazionale degli autori cinematografici, e iniziatore di un’analoga istituzione sul piano europeo. Nel 2001, ha organizzato a Genova le riprese dei cineasti che hanno documentato gli scontri tra i giovani e le “forze dell’ordine”, e le preordinate violenze nei confronti dei manifestanti. E inoltre…Potrei parlare a lungo, ma concludo con un augurio dei sardi: “A zent’anni, carissimo Citto”.
Giovanni Berlinguer
 Il regista siciliano ha presentato il suo 10° lungometraggio. Costato circa 14 milioni di euro, uscirà in sala il 1° gennaio 2013 in 360 copie. Con loro erano presenti anche la giovane protagonista Silvia Hoeks e il compositore Ennio Morricone. L'attore australiano era invece in collegamento video da Melbourne e ha attivamente partecipato per tutta la durata dell'incontro. Ecco l'intervista.
Il regista siciliano ha presentato il suo 10° lungometraggio. Costato circa 14 milioni di euro, uscirà in sala il 1° gennaio 2013 in 360 copie. Con loro erano presenti anche la giovane protagonista Silvia Hoeks e il compositore Ennio Morricone. L'attore australiano era invece in collegamento video da Melbourne e ha attivamente partecipato per tutta la durata dell'incontro. Ecco l'intervista.
In quest'ultimo film ritornano alcuni temi ricorrenti del tuo cinema come l’isolamento, la memoria, il cinema (l'esempio casa come troupe)
Giuseppe Tornatore: Trattandosi del rapporto vero/falso il cinema finisce inevitabilmente per entrarci. La battuta della villa affittata per il cinema era solo un vezzo. Tra gli altri temi, quello della memoria è un po’ meno forte. Quello dell’ossessione dello spazio invece è presente anche in altri film come per esempio La leggenda del pianista sull’Oceano.
Per il suo personaggio sorge naturale un paragone con Peter Sellers di Oltre il giardino, figura che tra l'altro lei ha anche interpretato in Tu chiamami Peter
Geoffrey Rush: Ho appena visto sullo schermo che sono un gigante (e ride). Mi sento quasi come un burattinaio. Non ho pensato a Peter Sellers per questo personaggio ma dato che Giuseppe è un regista che non ha paura di ricorrere alle metafore, gli ho detto: “Penso che il tuo film sia una conversazione tra la vecchia Europa e la Nuova Europa". Il personaggio da l’impressione di essere spiazzato nel mondo moderno ma alla fine c’è un barlume di speranza,
Il finale?
Giuseppe Tornatore: L’ho vissuto come un finale non tragico. Non solo perché il personaggio è comunque trasformato e comunque è diventato più umano. L’ho visto come positivo perché in questa ostinazione dell’attesa c’è una forza incredibile, c’è l’essere fedeli a ciò che si ama.
 Perche intitolare il film "La migliore offerta"?
Perche intitolare il film "La migliore offerta"?
Giuseppe Tornatore: Dal momento in cui avevo deciso di fare del protagonista un battitore d’asta (e ho un po' frequentato questo mondo), mi ha colpito che alcuni oggetti non hanno una valutazione di base e viene delegato al giudizio del pubblico. Il fatto che alcuni articoli venivano venduti al buon cuore del pubblico, ‘la migliore’ offerta' appunto, mi aveva incuriosito. Nelle gare d’appalto invece questo termine è utilizzato per l'offerta più bassa.
Come avete lavorato sul personaggio di Virgil Oldman e su quello di Claire?
Giuseppe Tornatore: Il personaggio era già così nel copione. Con Geoffrey ci siamo divertiti a mettere a fuoco le sue ossessioni e le sue manie come per esempio il suo rapporto con i guanti.
Geoffrey Rush: La migliore offerta è stata per me è stato lavorare con Silvia come protagonista. La sceneggiatura era enorme e impegnativa come una piece teatrale perché avevo dialoghi molto intensi nelle aste. Nei momenti più intimi la protagonista ce l’ho davanti ma non la vedo. Silvia è un’attrice divina ed è molto coraggiosa perché lascia che la macchina da presa si avvicini. Io sono invece uno di quegli attori da 19° secolo che, al contrario, si muove lui verso la macchina da presa.
Silvia Hoeks: Abbiamo fatto molte prove con Geoffrey. Per metà del film sono solo una voce e bisogna cercare di attirare il pubblico, di incuriosirlo, di portarlo a desiderare di conoscere questa ragazza. Poi con Geoffrey ci siamo anche molto divertiti. Consentire aun uomo di entrare nella vita del personaggio, era una scelta rischiosa. Ma questo rapporto mi ha coinvolta ed è stato per me un grande onore partecipare a questo film. Per me è stata sicuramente ‘la migliore offerta’.
La scelta dell'ambientazione nella Mitteleuropa?
Giuseppe Tornatore: Quando decido di fare un film, procedo per fedeltà alla storia. Se un villaggio siciliano non esiste, come per Baaria, lo ricostruisco. In questo film non riuscivo a immaginare un’ambientazione italiana e allora la scelta della Mitteleuropa mi è sembrata pertinente ai personaggi e al contesto produttivo.
L'automa sembra simile a quello di Hugo Cabret di Scorsese. Pira coincidenza?
Giuseppe Tornatore: Quando ho consegnato la sceneggiatura ad Arturo Paglia, nello stesso giorno ho visto un trailer e c’era l’automa del film di Scorsese che poi ho visto dopo. Qui però ha una funzione, lì ne ha un’altra
Il lavoro sulle musiche?
Ennio Morricone: La lettura del copione per me è stata decisiva. Alcune idee di un lavoro libero le avevo già dentro, ma alcune scene, dopo averle lette, mi hanno spinto ad osare. C’è quindi anche un’improvvisazione organizzata. Leggendo il copione, per esempio, con la scena dei quadri, già mi immaginavo come Peppuccio avrebbe girato questa scena,. Anzi, uno di quei momenti è stato composto prima di girare la scena. In qualche percentuale quindi Tornatore è anche coautore delle musiche.
Giuseppe Tornatore: Lui comincia a lavorare dopo che gli ho fatto leggere il copione. Dopo che sento i primi temi di Ennio, io sono già in fase di preparazione. E difficile che il tema musicale m’illumini su un personaggio ma mette meglio a fuoco quello che gia c’è. Il tema della voci? Lì ogni voce è un madrigale, Ennio ne ha composti circa 30.
Il valore della bellezza e dell’arte
Giuseppe Tornatore: Ho riflettuto a lungo su questo tema anche se non era determinante averne una precisa opinione per fare un film. Ma la bellezza era un tema di fondo del film ed è anche frutto dell’impostura dell’arte non è detto che debba essere solo di purezza. Poi, per esempio, a fine giornata noi tornavamo sempre nella stanza dei quadri per discutere
Tornatore ha detto che lei è un po’ Marlon Btrando per la precisione e Mastroianni per la simpatia. E' d'accordo e come valuta il suo lavoro col regista?
Geoffrey Rush: E’ interessante sentire queste cose ora perché Tornatore a me non l'ha mai fatto questo paragone con Brando e Mastroianni. Al limite con Bob Hope. Come regista è fantastico perché ha un concetto forte, viscerale di come deve essere la storia. Alcune location le ha rifiutate perché la porta era nel posto sbagliato rispetto a come se l’era immaginata lui. Sapevo che avevo difronte a me una partitura intrigata dove tutti gli elementi dovevano suonare in una certa maniera. E’ venuto a Melbourne, l’ho portato in molti ristoranti italiani. A Trieste invece era lui che conosceva tutti i ristoranti. Come gruppo abbiamo trascorso un periodo molto speciale.
Le differenze con Il discorso del re?
Geoffrey Rush: Il mio background è in teatro e a volte mi piace fare un ruolo diverso dal mio repertorio. Con Virgil Oldman Giuseppe ha scritto un personaggio così complesso – è ricco, è solo – come se non appartenesse al mondo reale. E’ stato ovviamente un lavoro molto diverso da Il discorso del re.
 Come è nato il progetto?
Come è nato il progetto?
Giuseppe Tornatore: Questo film nasce dalle ceneri di due storie diverse che mi piacevano molto ma non riuscivo a fargli prendere forma autonoma. Sovrapponendoli ho trovato la storia. E’ stato proprio un lavoro di gioia della narrazione.
Come giudica i dati negativi del box office sotto Natale?
Giuseppe Tornatore: Il crollo degli incassi quest’anno non è dovuto solo alla pirateria che è comunque da tempo una delle cause principali ed è il cancro del nostro mondo. Questa flessione ulteriore degli incassi a Natale smentisce la diceria che nei periodi di grande crisi economica il cinema se ne avvantaggia. A Natale le commedia erano i film che si salvavano.Forse c’è poca varietà nel ventaglio dell’offerta. Più invece questo è ampio, più è forte. Invece noi ci chiediamo sempre: quanto ha incassato? Il cinema d’autore poi ha sempre faticato ad avere un rapporto col pubblico. Ci deve essere invece un maggiore incontro tra il cinema d’autore e quello popolare, come accadeva nella commedia italiana degli anni ’60.
Il tuo passaggio dalla pellicola al digitale?
Giuseppe Tornatore: E’ stato doloroso e con Fabio Zamarion (il direttore della fotografia) ci siamo interrogati a lungo, abbiamo provato. Se non avessi fatto la scelta oggi, l’avrei comunque dovuta fare. Ma non mi sono pentito neanche un secondo di aver fatto il film in digitale. Anzi, se tornassi indietro, lo rifarei di nuovo.
da sentieriselvaggi.it - Scuola di Cinema di Roma
 Era il 1979 quando il viaggio nelle tenebre del cuore umano firmato Francis Ford Coppola strabiliò il pubblico al Festival di Cannes e vinse la Palma D’Oro. Una discesa lungo il fiume nero del Vietnam, il Mekong (in realtà la maggior parte delle riprese del film si tenne sul fiume Pasangjan, nelle Filippine) che è un naufragio senza appello nei gironi danteschi dell’Inferno: questo era “Apocalypse Now”, affresco monumentale e allucinato del lato oscuro della coscienza umana cui la guerra in Vietnam fa da cornice e la degenerazione dell’io corre parallela alla carneficina umana.
Era il 1979 quando il viaggio nelle tenebre del cuore umano firmato Francis Ford Coppola strabiliò il pubblico al Festival di Cannes e vinse la Palma D’Oro. Una discesa lungo il fiume nero del Vietnam, il Mekong (in realtà la maggior parte delle riprese del film si tenne sul fiume Pasangjan, nelle Filippine) che è un naufragio senza appello nei gironi danteschi dell’Inferno: questo era “Apocalypse Now”, affresco monumentale e allucinato del lato oscuro della coscienza umana cui la guerra in Vietnam fa da cornice e la degenerazione dell’io corre parallela alla carneficina umana.
Scritto e realizzato da Federico Fellini in collaborazione con i fedeli Ennio Flaiano e Tullio Pinelli ,
" I vitelloni " rimane a tutt'oggi il più sagacemente abile nel rappresentare sogni, ambizioni e paure
di una generazione di italiani, quella del pre-boom
Nei ritratti di Moraldo ( Franco Interlenghi ), Fausto ( Franco Fabrizi ), Alberto ( Alberto Sordi ), Leopoldo ( Leopoldo Trieste ) e Riccardo ( Riccardo Fellini ) troviamo le caratteristiche principali dell'italiano medio nato e cresciuto in provincia, il quale si adagia alla propria estrazione sociale, evitando ogni possibile forma di reazione e negando a se stesso l'auspicio che tutto rimanga così com'è, età compresa.
Non appena resosi conto che la fidanzata Sandra è in attesa d'un bambino, Fausto si appresta a preparare le valige e a giustificarsi col padre dicendo di voler partire per cercare un lavoro, fingendo aria di responsabilità; lo ritroviamo immancabilmente sull'altare (" hai visto, è stato un momento! " gli dice stringendogli la mano Alberto ) e, poco dopo il viaggio di nozze, il suocero lo accompagna dal proprietario d'un negozio d'articoli religiosi per lavorare da commesso.  Mentre Leopoldo nella sua stanzetta da scapolo, seguendo delle enfatiche ambizione artistiche, passa le notti pensando ai personaggi delle commedie che scrive, Alberto e Riccardo vivono ancora in famiglia e trascorrono le loro giornate preferibilmente al biliardo o in riva al mare, giocando spesso a provocarsi a vicenda.
Mentre Leopoldo nella sua stanzetta da scapolo, seguendo delle enfatiche ambizione artistiche, passa le notti pensando ai personaggi delle commedie che scrive, Alberto e Riccardo vivono ancora in famiglia e trascorrono le loro giornate preferibilmente al biliardo o in riva al mare, giocando spesso a provocarsi a vicenda.
Moraldo, cognato di Fausto, ha un carattere meno strafottente degli altri, coi quali comunque condivide lo scorrere dei trent'anni in questo goliardico stile di vita.  Al termine del grande veglione di carnevale, squillano per tutti i campanelli d'allarme, come fosse definitivamente finito il tempo di scherzare: Alberto travestito da donna e completamente ubriaco tra le braccia di Moraldo afferma: " Non siete nessuno tutti, mi fate schifo " poi estendendo l'invito anche a Riccardo dice con convinzione: " Ti devi sposare Moraldo, ci dobbiamo sposare… " Mentre di lì a poco tornando verso casa troverà la sorella in procinto d'andarsene per seguire un uomo, nella molto vana speranza d'un avvenire migliore; Fausto , dopo aver insistentemente corteggiato la moglie del principale, perderà il posto di lavoro e verrai conseguentemente castigato dalla moglie allontanatasi da casa con la bambina per rifugiarsi dal padre di lui, che non esiterà a dargli una severa lezione, una volta per tutte. Leopoldo rimarrà deluso perfino dall'incontro con un capocomico famoso, il quale finirà per rivelarsi un omosessuale, mettendolo in fuga nonostante lo abbia dapprima molto lusingato. Soltanto Moraldo, una notte, troverà il coraggio di staccarsi dalle proprie radici, abbandonando per sempre quella piccola realtà che ora non può che apparirgli monotona e nell'insieme squallida, salendo su di un treno senza nemmeno sapere la destinazione.
Al termine del grande veglione di carnevale, squillano per tutti i campanelli d'allarme, come fosse definitivamente finito il tempo di scherzare: Alberto travestito da donna e completamente ubriaco tra le braccia di Moraldo afferma: " Non siete nessuno tutti, mi fate schifo " poi estendendo l'invito anche a Riccardo dice con convinzione: " Ti devi sposare Moraldo, ci dobbiamo sposare… " Mentre di lì a poco tornando verso casa troverà la sorella in procinto d'andarsene per seguire un uomo, nella molto vana speranza d'un avvenire migliore; Fausto , dopo aver insistentemente corteggiato la moglie del principale, perderà il posto di lavoro e verrai conseguentemente castigato dalla moglie allontanatasi da casa con la bambina per rifugiarsi dal padre di lui, che non esiterà a dargli una severa lezione, una volta per tutte. Leopoldo rimarrà deluso perfino dall'incontro con un capocomico famoso, il quale finirà per rivelarsi un omosessuale, mettendolo in fuga nonostante lo abbia dapprima molto lusingato. Soltanto Moraldo, una notte, troverà il coraggio di staccarsi dalle proprie radici, abbandonando per sempre quella piccola realtà che ora non può che apparirgli monotona e nell'insieme squallida, salendo su di un treno senza nemmeno sapere la destinazione.
 I temi di base descritti nel film (La monotonia della vita di provincia, la paura di crescere e soprattutto il desiderio d'evasione dalle responsabilità familiari) verranno nei decenni a seguire aggiornati e rianalizzati da Pietro Germi : in " Divorzio all'italiana " (1961) vedremo il siculo barone Fefè ( Marcello Mastroianni ), fare di tutto per liberarsi della moglie per unirsi in seconde nozze alla cugina sedicenne Angela ( Stefania Sandrelli ) la quale, durante una gita in mare, non esiterà ad intendersela col marinaio di turno; in " Alfredo Alfredo " (1972) Dustin Hoffman verrà soffocato dal temperamento della fidanzata Maria Rosa (ancora la Sandrelli ), per poi trovare conforto nel rapporto con una cassiera di bar dalle idee divorziste ( Carla Gravina ) che lo ricondurrà in trappola.
I temi di base descritti nel film (La monotonia della vita di provincia, la paura di crescere e soprattutto il desiderio d'evasione dalle responsabilità familiari) verranno nei decenni a seguire aggiornati e rianalizzati da Pietro Germi : in " Divorzio all'italiana " (1961) vedremo il siculo barone Fefè ( Marcello Mastroianni ), fare di tutto per liberarsi della moglie per unirsi in seconde nozze alla cugina sedicenne Angela ( Stefania Sandrelli ) la quale, durante una gita in mare, non esiterà ad intendersela col marinaio di turno; in " Alfredo Alfredo " (1972) Dustin Hoffman verrà soffocato dal temperamento della fidanzata Maria Rosa (ancora la Sandrelli ), per poi trovare conforto nel rapporto con una cassiera di bar dalle idee divorziste ( Carla Gravina ) che lo ricondurrà in trappola.
Nell'ultimo film, poi ultimato da Monicelli, ossia " Amici miei " (1975), i cinque cosiddetti " Vitelloni " ( Tognazzi, Noiret, Moschin, Celi e Del Prete ) pur avendo raggiunto un buon livello d'affermazione sociale continuano a fuggire la realtà esorcizzando la paura di invecchiare attraverso feroci scherzi ch'essi definiscono zingarate; al termine del film, uno di loro (il giornalista Silvio Perozzi ), colto da un infarto, abbandonerà per sempre il gruppo suo malgrado: nemmeno il suo funerale verrà preso sul serio.Arrivando ai giorni nostri, troviamo nei film dei giovani registi Gabriele Muccino (" L'ultimo bacio ", divenuto già il cult degli attuali trentenni) e Alberto Taraglio (" Amarsi può darsi ") quei protagonisti che potremmo definire i nipoti stretti dei "Figli" di Fellini e Germi, i quali in pieno terzo millennio, epoca d'Internet e telefonini, continuano a vedere il matrimonio come una minaccia alla spensieratezza della giovane età e ad avere dentro di sé il prepotente desiderio di evadere dalla routine di una vita limitata da responsabilità sempre più pesanti. Doverosi complimenti vanno espressi alle nuove leve per non aver dimenticato le lezioni degli illustri predecessori: i Vitelloni grazie a loro esistono ancora, oggi come ieri, domani come sempre.
di Graziano Marraffa
FELLINI, UN ARTISTA SUPERLATIVO CHE HA MOLTO POCO DA DIRE, GLI SFONDI VOGUE DI ANTONIONI, VIVA DE SICA ...
Così il grande cineasta descriveva la sua vita e il suo lavoro. Le donne che ha conosciuto, i film che ha girato e quelli che ha interpretato. A volte ne parlava con crudeltà, altre con ironia. Le confessioni di un uomo che ha fatto della provocazione un´arte e del talento una forma estrema di dissipazione.
| (Orson Welles fa scherzi alla radio) |
1 – VIZIARE L'ORSON
Ero una di quelle abominevoli creaturine impettite, non so se ha presente, con la bacchetta da direttore, suonavo il violino e il pianoforte, e non c´è niente di più odioso sulla faccia della terra. Ero uno di loro. Mia madre, che di professione era musicista, morì quando avevo nove anni, e smisi immediatamente di suonare. Fu una specie di trauma, uno shock dovuto alla sua morte, mescolato, credo, a una pigrizia di fondo... e al piacere di non dover continuare a esercitarmi sulle scale armoniche. Così abbandonai la mia carriera musicale, perché era a questo che ero stato destinato inizialmente.
Sì, da bambino sono stato viziato in modo molto strano. Perché tutti, dal giorno in cui sono stato in grado di comprendere, mi hanno detto che ero assolutamente meraviglioso. Non ho mai sentito una parola scoraggiante per anni. Non avevo idea di cosa mi aspettava. Dipingevo, e mi dicevano che non si erano mai visti dipinti simili; suonavo, e nessuno aveva mai suonato così. E a me sembrava proprio che non ci fossero limiti alle mie possibilità.
2 - UN DUE PER CENTO DEL MIO TEMPO L´HO IMPIEGATO A FARE FILM, E UN NOVANTOTTO PER CENTO A SBATTERMI QUI E LÀ PER POTERLI FARE
Essenzialmente, credo di aver commesso un errore a restare nel mondo del cinema, ma è un errore di cui non posso rimproverarmi, perché sarebbe come dire che non avrei dovuto restare sposato con una certa donna, ma che l´ho fatto perché la amavo. Avrei avuto molto più successo se non avessi sposato proprio lei. Avrei avuto molto più successo se avessi lasciato immediatamente il cinema, se fossi rimasto nel teatro, o se fossi entrato in politica, se avessi fatto lo scrittore o qualsiasi altra cosa.
Ho gettato via gran parte della mia vita nello sforzo di cercare denaro e di cavarmela in qualche modo, per poter fare il mio lavoro usando questa scatola di colori estremamente costosa che è un film. E ho sprecato fin troppa energia dietro a cose che non hanno nulla a che vedere con il fare un film. Diciamo che un due per cento del mio tempo l´ho impiegato a fare film, e un novantotto per cento a sbattermi qui e là per poterli fare.
Continuerò a essere fedele alla mia ragazza. La amo. Mi innamoro così tanto del fare un film che il teatro per me ha perso tutto quel che aveva, davvero. Amo soltanto fare film. Non sono un appassionato del cinema. Non vado spesso a vedere film. Credo sia perfino dannoso per un regista vedere altri film, perché si finisce sempre o per imitarli, o per preoccuparsi di non imitarli affatto. Invece bisogna fare il film con innocenza. Nello stesso modo in cui Adamo diede un nome agli animali il primo giorno nel paradiso terrestre.
E io ho perso la mia innocenza. Ogni volta che vedo un film perdo qualcosa, non ne guadagno niente. Non capisco cosa vogliano dire i registi quando si complimentano con me, i giovani registi, quando dicono di aver imparato dai miei film. Perché io non credo affatto di poter imparare qualcosa da un film altrui. Credo che bisogna imparare solo dalla propria visione interiore delle cose e scoprire, come ho detto, con innocenza, come se non fossero mai esistiti né David Wark Griffith, né Ejsenstejn, o Ford o Renoir o chiunque altro.
 |
| (L'occhio del grande cineasta) |
3 – LA REGIA E' IL MONTAGGIO
Per me, quasi tutto ciò che viene battezzato come mise en scène è un enorme bluff. Nel mondo dei film, sono davvero poche le persone che si possono considerare veramente dei registi, e tra di essi sono ancora meno quelli a cui viene davvero data l´opportunità di dirigere un film. L´unico momento di vera regia ha luogo durante il montaggio. Mi ci sono voluti nove mesi per montare “Quarto potere”, lavorando sei giorni a settimana.
Certo, ho diretto io “L´orgoglio degli Amberson”, malgrado alcune scene non fossero mie: ma il mio montaggio è stato modificato. Il montaggio basilare è mio, e quando nel film c´è una scena che funziona, è perché l´ho montata io. In altre parole, è come se uno stesse dipingendo un quadro. Lo finisce, e poi arriva qualcuno e lo ritocca, ma chiaramente non può aggiungere altra pittura sull´intera superficie della tela.
Non posso fare a meno di pensare che il montaggio sia la cosa essenziale per un regista, l´unico momento in cui controlla completamente la forma del suo film. Quando sto filmando, il sole è il fattore determinante di qualcosa contro cui c´è poco da combattere; gli attori portano in gioco qualcosa a cui devo adattarmi; e così anche la storia. Io mi limito a predisporre le cose in modo da dominare tutto quel che posso. L´unico posto in cui il mio controllo è assoluto, però, è lo studio di montaggio. di conseguenza, è quello il momento in cui il regista è, in potenza, un vero artista, perché a mio avviso un film è buono nella misura in cui il regista è riuscito a controllare i diversi materiali e non si è accontentato semplicemente di mantenerli intatti.
4 - NON MI INTERESSA IL LAVORO ARTISTICO, LA POSTERITÀ, LA FAMA, MA SOLO IL PIACERE DELLA SPERIMENTAZIONE IN SE STESSA
Io cerco sempre la sintesi. E´ un lavoro che mi affascina perché devo essere sincero riguardo a me stesso, e io sono un puro sperimentatore. Il mio unico valore ai miei occhi è che non detto leggi, ma sono uno sperimentatore. Sperimentare è l´unica cosa che mi entusiasma. Non mi interessa il lavoro artistico, capite, la posterità, la fama, ma solo il piacere della sperimentazione in se stessa.
E´ l´unico ambito in cui posso sentire di essere onesto e sincero. Io non mi consacro a quel che faccio. Davvero, non ha alcun valore ai miei occhi. Sono profondamente cinico riguardo al mio lavoro e alla maggior parte delle opere che vedo nel mondo. Ma non sono cinico riguardo al lavoro sui materiali. E´ una cosa difficile da spiegare. Noi sperimentatori di professione abbiamo ereditato un´antica tradizione. Alcuni di noi sono stati tra i maggiori artisti, ma le nostre muse non sono mai diventate le nostre amanti.
Per esempio, Leonardo si considerava uno scienziato che dipingeva piuttosto che un pittore che faceva lo scienziato. Non voglio certo paragonarmi a Leonardo; sto solo cercando di spiegare che c´è una lunga linea ininterrotta di persone che giudicano il proprio lavoro secondo una diversa gerarchia di valori, che sono quasi valori morali.
 |
| (Barba e sguardo feroce) |
Quindi non cado in estasi quando sono di fronte a un´opera d´arte. Sono in estasi quando mi trovo di fronte alla funzione umana, che è sottesa a tutto ciò che facciamo con le nostre mani, con i nostri sensi, eccetera. Il nostro lavoro, una volta finito, non ha l´importanza che la gran parte degli esteti gli attribuiscono. E´ l´atto che mi interessa, non il risultato, e io vengo preso dal risultato solo quando questo sa di sudore dell´uomo, o di pensiero espresso.
Sto pensando seriamente di smettere il mio lavoro nel cinema o nel teatro, smetterla una volta per tutte, dico, perché sono rimasto troppo deluso. Ci ho investito troppo lavoro, troppo impegno rispetto a quel che ho avuto in cambio... non in termini di denaro, ma di soddisfazione. Quindi sto pensando seriamente di abbandonare cinema e teatro, perché in un certo senso loro mi hanno già abbandonato.
5 - LA RESPONSABILITÀ È DELLA MIA PERSONALITÀ, NON DELLE MIE INTENZIONI
Più o meno di mia volontà, lo sapete, ho fatto molte volte la parte del cattivo. Odio Harry Lime, quel mascalzoncello del mercato nero, tutti i personaggi orribili che ho interpretato e che tuttavia non sono «piccoli», perché io sono un attore per grandi personaggi. Come sapete, nel vecchio teatro classico francese, c´erano sempre attori che interpretavano il re e attori che non lo interpretavano: io sono di quelli che fanno il re.
Con la mia personalità, è necessario. Perciò recito naturalmente sempre parti di capi, di persone che hanno una dimensione straordinaria: devo sempre essere bigger than life, più grande della natura. E´ un difetto della mia indole. Dunque non bisogna pensare che ci sia qualcosa di ambiguo nelle mie interpretazioni. La responsabilità è della mia personalità, non delle mie intenzioni.
6 - IL PUBBLICO INCONCEPIBILE
Si possono orientare le cose quanto si vuole, ma cosa ne penserà poi il pubblico americano? Io non ne avevo la più pallida idea. Non si tratta di disprezzo per il pubblico, è solo che il pubblico di un film davvero non è concepibile. Il sessanta per cento del pubblico non sentirà mai le parole che diciamo, perché il film sarà doppiato. Forse dieci milioni di persone lo vedranno soltanto in seguito, quando saremo tutti morti. Sono poveri, sono ricchi, sono grandi, sono piccoli. Non sappiamo chi sia il pubblico di un film, perciò non possiamo far altro che qualcosa in cui crediamo.
7 – SOGNATE I VOSTRI FILM
Non ho mai messo piede in una scuola di cinema. E non avevo mai messo piede su un set prima di girare “Quarto potere”. Senza dubbio sono stato toccato dalla grazia di una totale ignoranza. Ho imparato tutto quel c´era da sapere in tre ore, non perché sia particolarmente intelligente, ma perché il cinema è semplice! Voi di certo avrete passato troppo tempo a guardare film. Non chiudetevi troppo nell´universo cinematografico, come fosse una scatola d´aringhe.
Sognate i vostri film, piuttosto. E prestate attenzione all´incanto delle muse più perverse... la decadenza del cinema è il risultato della glorificazione del regista. Ma l´attore è più importante. Oggi il regista è l´artista più sopravvalutato del mondo. Pensate ai grandi momenti del cinema: sono tutti in bianco e nero. Più avanza il progresso tecnico, più lo spirito creativo va in declino. E io temo che l´elettronica finirà per aiutare solo i film di terza scelta.
8 – A COLAZIONE CON HITLER
Sono stato a Berlino per circa tre anni, dal 1926 in poi, e più o meno lo stesso periodo di tempo l´ho passato a Chicago. Ma le città migliori per me sono state senz´altro Budapest e Pechino. E´ lì che ho avuto le migliori conversazioni ed esperienze, fino alla fine. Quel che non posso dimenticare è una festa a cui ho partecipato da qualche parte nel Tirolo, verso la metà degli anni Venti. Partecipavo a una gita a piedi con altri ragazzini della mia età, quando il nostro tutore ci portò a mangiare in un´enorme birreria all´aperto.
Sedemmo su un lungo tavolo pieno di nazisti, che all´epoca erano solo uno sconosciuto gruppetto di svitati, e io ero accanto a un uomo molto magro, dalla personalità cupa e ottusa. Non mi fece nessuna particolare impressione, allora, ma anni dopo, quando vidi le sue fotografie, compresi di aver pranzato accanto a Adolf Hitler.
9 - LA COSA PIÙ TRISTE DELLA SINISTRA AMERICANA È CHE HA TRADITO PER PROTEGGERE LE SUE PISCINE
Nell´arte americana il problema, o meglio, uno dei problemi, è il tradimento della sinistra da parte della sinistra, un auto-tradimento. In un certo senso, per stupidità, per ortodossia e osservanza degli slogan; in un altro senso, per semplice tradimento. Siamo molto pochi nella mia generazione a non aver tradito la propria posizione, a non aver fatto i nomi di altra gente...
E´ una cosa terribile. Non potrà mai essere superata. Non so come si possa ricominciare dopo un simile tradimento; è qualcosa che differisce profondamente, per esempio, dal caso di un francese che abbia collaborato con la Gestapo per salvare la vita della moglie; è un altro genere di collaborazionismo. La cosa più triste della sinistra americana è che ha tradito per proteggere le sue piscine. Non c´era nessuna destra americana, nella mia generazione.
Dal punto di vista intellettuale non esisteva. C´erano solo persone di sinistra, e si sono reciprocamente tradite a vicenda. La sinistra non è stata distrutta da McCarthy: si è demolita da sola, cedendo a una nuova generazione di nichilisti. Ecco cosa è successo.
 |
| (Rita Hayworth) |
10 - LA RITA DI SHANGHAI
Credo che conosciate la storia della “Signora di Shanghai”. Stavo lavorando a una spettacolare idea teatrale per Il giro del mondo in ottanta giorni, che inizialmente doveva produrre Mike Todd. Ma da un momento all´altro Todd fece bancarotta, e io mi sono ritrovato a Boston il giorno della prima, impossibilitato a ritirare i costumi dalla stazione perché c´era un debito insoluto di cinquantamila dollari. Senza quei soldi non avremmo potuto andare in scena.
A quel tempo ero già separato da Rita; non ci parlavamo neanche più. Non avevo intenzione di fare un film con lei. Da Boston mi sono messo in contatto con Harry Cohn, il direttore della Columbia, che era a Hollywood, e gli ho detto: «Ho una storia straordinaria, se mi mandi cinquantamila dollari con un vaglia telegrafico entro un´ora, firmo un contratto per realizzarla». Cohn mi ha chiesto: «Che storia?». Io telefonavo dal botteghino del teatro; vicino c´era un banco con un´esposizione di libri tascabili, e io gli ho dato il titolo di uno di quelli: La signora di Shanghai. Gli ho detto: «Compra il romanzo, e io farò il film».
Un´ora dopo abbiamo ricevuto i soldi. In seguito ho letto il libro e l´ho trovato orribile, così mi sono messo al lavoro per scrivere una storia al massimo della velocità. Sono arrivato a Hollywood per girare il film con un budget molto ridotto e in sei settimane di riprese. Ma mi servivano altri soldi per il mio teatro.
Cohn mi ha chiesto perché non usavo Rita. Lei aveva detto che le avrebbe fatto molto piacere. Io le ho fatto capire che il personaggio non era simpatico, era una donna che aveva ucciso e questo poteva intaccare la sua immagine di star agli occhi del pubblico. Ma Rita era molto determinata a fare questo film, così invece di costare trecentocinquantamila dollari è diventato un film da due milioni di dollari. Rita ha avuto un atteggiamento di grande collaborazione. Chi è rimasto davvero orripilato dopo aver visto il film è stato Cohn.
 |
| (La splendida rossa) |
11 - BRECHT ANTI-SOVIET
Terribilmente simpatico. Aveva una mente straordinaria. Si vedeva perfettamente che era stato educato dai gesuiti. Aveva quel tipo di mente disciplinata caratteristica dell'educazione gesuitica. Istintivamente, era più anarchico che marxista, ma riteneva di essere un perfetto marxista.
Quando un giorno gli ho detto - stavamo parlando del Galileo - che aveva scritto un´opera perfettamente anticomunista, è diventato quasi aggressivo. Io gli ho risposto: «Ma la Chiesa che tu descrivi qui deve essere quella di Stalin, non quella del Papa, di questi tempi. Hai scritto una cosa decisamente antisovietica».
12 – PRENDERE PER IL CULO HEMINGWAY
Il mio rapporto con Hemingway è stato sempre molto divertente. La prima volta che ci siamo incontrati è stato quando mi hanno chiamato a leggere il commento narrato di un film che lui e Joris Ivens avevano fatto sulla guerra di Spagna; si chiamava “Spanish Earth” (Terra di Spagna). Appena arrivato mi sono imbattuto in Hemingway, che era tutto intento a tracannare una bottiglia di whisky; mi avevano dato una serie di battute troppo lunghe e vuote, che non avevano niente a che vedere con il suo stile, sempre così conciso e parsimonioso.
C´erano alcune parti pompose e complicate del tipo: «Ecco i volti degli uomini vicini alla morte», e la battuta doveva essere letta in un momento in cui sullo schermo si vedevano volti che erano molto più eloquenti. Io gli dissi: «Signor Hemingway, sarebbe meglio se si vedessero soltanto i volti, senza nessun commento».
La cosa non gli è piaciuta neanche un po´, e siccome poco tempo prima avevo fatto una regia per il Mercury Theatre, che era una specie di teatro di avanguardia, lui pensava che fossi una specie di finocchio, così mi ha detto: «Voialtri... ragazzini effeminati del teatro, che cosa volete saperne della guerra vera?».
Prendendo il toro per le corna ho cominciato a muovermi con gesti effeminati e gli ho detto: «Signor Hemingway, quanto è forte lei, quanto è grande!». La cosa lo ha mandato su tutte le furie, al punto che ha afferrato una sedia; io ne ho preso un´altra e lì, di fronte alle immagini della guerra civile spagnola che continuavano a scorrere sullo schermo, abbiamo iniziato una zuffa tremenda.
E´ stata una cosa meravigliosa: due tipi come noi di fronte a quelle immagini che rappresentavano gente nell´atto di combattere e morire... abbiamo finito col brindare insieme con la sua bottiglia di whisky. Nella nostra vita abbiamo passato lunghi periodi di amicizia e altri in cui a malapena ci parlavamo. Non sono mai riuscito a evitare di prenderlo garbatamente in giro, e questo nessuno lo aveva mai fatto; tutti lo trattavano con il massimo rispetto.
13 – IL TALENTO DI KUBRICK
Non ho visto niente della generazione più recente, a parte qualche esempio d´avanguardia. Tra quelli che potrei definire la «giovane generazione», Kubrick mi appare come un gigante. Non ho visto “Lolita”, ma credo che Kubrick possa fare qualsiasi cosa.
E´ un grande regista che non ha ancora fatto dei grandi film. Quel che vedo in lui è un talento che i registi della generazione precedente alla sua non possedevano, intendo dire Ray, Aldrich, e così via. Forse lo dico perché il suo temperamento si avvicina molto al mio.
 |
| (Michelangelo Antonioni) |
13 – GLI SFONDI VOGUE DI ANTONIONI
Secondo i giovani critici americani, una delle grandi scoperte della nostra epoca è il valore della noia come tema artistico. Se è così, Antonioni merita di essere annoverato tra i pionieri della tendenza come padre fondatore. I suoi film sono sfondi perfetti per mannequins di alta moda. Forse non ci sono sfondi così perfetti neanche in Vogue, anzi, è così che dovrebbero farli. Dovrebbero ingaggiare Antonioni per progettarli.
 |
| (Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg) |
14 – FELLINI, UN ARTISTA SUPERLATIVO CHE HA MOLTO POCO DA DIRE
E´ dotato, come tutti quelli che fanno cinema oggi. Il suo limite - che è anche la fonte del suo fascino - è di essere fondamentalmente molto provinciale. I suoi film sono il sogno della grande città da parte di un ragazzo di provincia. Le sue sofisticherie funzionano perché sono la creazione di qualcuno che non è sofisticato. Tuttavia mostra spesso segni pericolosi di essere un artista superlativo che ha molto poco da dire.
 |
| (Vittorio de Sica e Gina Lollobrigida) |
15 – VIVA DE SICA
Non vi piacerà quello che vi sto per dire, dato che le persone che ammiro non sono affatto stimate dagli intellettuali del cinema; il dramma è tutto qui. Il cineasta che preferisco è De Sica: so che vi fa star male. E John Ford. Ma il Ford di vent´anni fa, il De Sica di dodici anni fa. Ah! “Sciuscià”: è il miglior film che abbia mai visto. Dovreste vergognarvi di non amare De Sica: magari potessimo riparlarne fra duecento anni!
Da La Repubblica
Estratti dal libro “ It's All True. Interviste sull'arte del cinema ”, a cura Mark W. Estrin, con traduzione e postafazione di Serafino Murri, Minimum Fax.
da Dagospia del 15 Febbraio 2005
Neanche in catene, fossi stato Carlo Lizzani, avrei detto che il problema del giovane cinema italiano “è che manca una tendenza, la capacità di far gruppo”. Forse mancherà la capacità di fare gruppo, ma quella di fare gregge è eccellente. A volte sembra che le pellicole siano scritte da un solo sceneggiatore e girate da un solo regista. Basta vedere i trailer. Ci si accorge subito se un film è italiano: gli attori sono sguaiatamente allegri o irragionevolmente cupi, le trame, sempre elementari, da avanspettacolo o da oratorio.
Un tempo, dice Lizzani, “si poteva dire ‘vado a vedere un film italiano’. Ora quella categoria è scomparsa”. No, non sono scomparsi i film, ma il cinema italiano, nonostante una critica schierata che “fa gruppo” con inutile efficienza, sperperando elogi e predicendo ogni anno al film di turno l’oscar che non otterrà mai. Dagli spernacchiamenti di Benigni al moralismo catechistico di Moretti, il cinema italiano è quasi tutto intriso di un’indigeribile astuzia. Diceva Longanesi: non è la libertà, sono gli uomini liberi che mancano.
di Giuseppe Scaraffia per “Io Donna” del “Corriere della Sera”
Carmelo Bene nasce, o meglio viene abortito, a Campi Salentina in provincia di Lecce, nel 1937. Insieme a lui verrà alla luce il suo straordinario teatro, anzi, la totale reinvenzione che Bene ha fatto del teatro. Dopo i primi studi classici presso un collegio di gesuiti, si trasferisce a Roma dove si iscrive nel 1957 all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, un'esperienza che, a partire dal solo anno successivo, abbandona convinto della sua "inutilità". Bene aveva già tutto il necessario dentro di sè.
Leggi tutto: LA DEMOLIZIONE DELL'IMMAGINE nel CINEMA di CARMELO BENE
La prima domanda che sorge spontanea, dinanzi allo studio di quel complesso fenomeno che è il cinema, è la seguente: che cos’è il Cinema? Le risposte, neanche a dirlo, sarebbero molte, a seconda dei diversi punti di vista di chi osserva il fenomeno. Del cinema si possono dire moltissime cose: è tecnica, è un’industria, un’arte o uno spettacolo, ma anche – e forse soprattutto – divertimento e cultura. Ognuna di queste conclusioni è importante ed irrinunciabile; ma forse il cinema è – più propriamente – tutto questo insieme ed altro ancora. Saper vedere il cinema, invece, indica già qualcosa di più preciso: significa, infatti, imparare ad osservare un film prendendo da esso le debite distanze, in modo da poterne comprendere i meccanismi di funzionamento e di produzione del senso. Roland Barthes ha chiamato tutto questo distanza amorosa, indicando la relazione tra il piacere di vedere un film e la capacità di discernere, distinguere, scegliere e giudicare.
Il cinema, però, non è solo un’importante mezzo di comunicazione: esso, infatti, intrattiene anche stretti rapporti con la storia intesa come insieme di fatti storici e come disciplina che studia questi fatti. I rapporti tra cinema e storia possono essere i seguenti:
- la storia del cinema (di essa si occupa la storiografia cinematografica);
- la storia nel cinema (i film possono essere un documento storico);
- il cinema nella storia (i film possono avere un ruolo attivo nella propaganda politica, nella diffusione di un’ideologia, ecc.– si pensi all’importanza del cinema come strumento di propaganda all’epoca del fascismo, del nazismo o nell’America di Roosevelt).
Le diverse età del cinema
Il problema delle origini del cinema può essere affrontato da diversi punti di vista: quello tecnico e scientifico (per comprendere il funzionamento delle apparecchiature che poi hanno portato all’invenzione del Cinematografo dei fratelli Lumière), quello psicologico e sociologico (per comprendere come il cinema influenza l’immaginario collettivo), ed infine dal punto di vista estetico (per vedere come il cinema apporta delle innovazioni alle altre arti esistenti). Gli ultimi anni dell’Ottocento ed i primi del Novecento sono quelli in cui il cinema nasce e si afferma; quest’epoca venne ingiustamente definita la Belle Epoque, main realtà furono anni duri a causa dell’espansione dell’imperialismo coloniale, tanto che l’avvento del cinema passò in secondo piano. In verità, però, la “magia” del cinema condizionò diversi aspetti della vita quotidiana.
Il primo dibattito che nacque attorno alla nuova invenzione fu tra volontà di riprodurre il reale e la volontà di creare realtà simulate o ricostruite; tuttavia va sempre ricordato che il Cinematografo dei fratelli Lumière non inventa nulla di nuovo, poiché si tratto solamente dell’apparecchio che meglio raccoglieva in sé almeno cinquant’anni di sperimentazioni nel mondo della fotografia e della cronofotografia (si pensi a Talbot e Nièpce, Muybridge e Marey), e sul mondo della riproduzione del movimento (come gli spettacoli d’ombre di Robertson, il Teatro Ottico, La Lanterna Magica ecc.).
Comunque il cinema indicò fin da subito due vie solo apparentemente opposte: quella della realtà e quella della fantasia. Apparentemente perché, com’è oramai noto, non è possibile separare nettamente una tendenza “realistico-oggettiva” (incarnata dai film dei Lumière) ed una “fantastico-irreale” (che coincide con il nome di Méliès); infatti entrambe fanno parte di quell’unico processo che, già a partire dalla sfera del pre-cinema, porterà il cinema ad essere sempre qualcosa di “iperreale”, cioè qualcosa che è sempre e comunque “già riprodotto”.
Saper vedere e ascoltare il cinema muto
Oggi si dice che il cinema muto non sia “adatto alle abitudini audiovisive dei telespettatori”; quest’assurda offesa alle capacità intellettive di noi telespettatori ha determinato anche delle inaccettabili conseguenze sul piano della fruizione televisiva dei classici del cinema muto: si va dall’abolizione delle didascalie a favore dello “stop frame” (con annessi “balloons”), alle copie sonorizzate di film muti, dalle “voci fuori campo” alle inammissibili colorazioni computerizzate. Purtroppo si tratta di un fraintendimento di base: se si vuole amare il cinema muto, occorre innanzitutto rendersi conto che il suo linguaggio è ben diverso da quello del cinema sonoro. Quindi lo spettatore che si avvicina al cinema muto non può fruirlo come se fosse un film contemporaneo.
Certo non è facile oggi poter vedere il cinema muto: le difficoltà non sono solo soggettive, sono anche oggettive: il patrimonio di film rimasti non è facilmente accessibile ed i rari passaggi televisivi alterano fino all’inverosimile il ritmo del film (le cineprese giravano a 16 fps, mentre i moderni proiettori riproducono a 24 fps), per non parlare del fatto che, molto spesso, la proiezione del film era accompagnata da esecuzioni di orchestra a dir poco grandiose (si pensi alla prima di Cabiria). Tuttavia va ricordato che l’assenza del suono e, soprattutto, della parola fu raramente vista come una carenza della nuova arte; anzi, si può dire che i maggiori risultati del cinema muto furono ottenuti attraverso le infinite potenzialità della “scena muta”. L’avvento del sonoro – nel 1927 con il film Il cantante di jazz – modificò in modo sostanziale le abitudini del pubblico, trasformando di fatto i metodi di produzione e di fruizione del film.
Tutti gli storici e teorici del cinema sono grossomodo d’accordo nel definire la sfera del pre-cinema (ovvero l’età dei pionieri) come una fase di scoperta e di sperimentazione del nuovo mezzo, per scopi semplicemente riproduttivi e spettacolari, e non l’inizio di una nuova arte e di un nuovo linguaggio espressivo. Questo, quindi, vale per i fratelli Lumière, per Edison e Dickson, per Georges Méliès e per Edwin S. Porter; tuttavia Edgar Morin attribuisce già a Méliès il merito di aver segnato il passaggio dal cinematografo al cinema. Con il primo termine lo studioso francese si riferisce al semplice apparecchio di ripresa e proiezione di fotografie in successione, mentre con il secondo indica il dispositivo espressivo e spettacolare capace di articolare un proprio linguaggio autonomo.
Comunque è a partire da Nascita di una Nazione ed Intolerance – entrambi di D.W.Griffith – che il cinema acquisisce coscienza dei propri mezzi espressivi e del proprio linguaggio; il cinema diviene arte grazie al montaggio, che assume il ruolo di “produttore del senso”. Essendo il montaggio un elemento specifico del linguaggio cinematografico, la settima arte non ha più bisogno del sostegno di altre forme spettacolari che fino a quel momento lo avevano contaminato.
L’età dell’oro di Hollywood
La Hollywood classica era divisa in cinque Major (le cosiddette Big Five): MGM, WB, Paramount, RKO e 20th Century Fox; e tre Minor (Little Three): Universal, Columbia e United Artists. Il primo gruppo di studios possedeva una catena di sale cinematografiche, mentre il secondo gruppo ne era privo. Il periodo di situazione Oligopolistica del sistema produttivo dell’epoca classica va dal 1925 circa al 1955 circa, ma fu un fenomeno che mai riuscì ad eliminare la “concorrenza” dei cosiddetti Indipendenti, ovvero le case di produzione o i produttori non conformi al sistema (si pensi a Charlie Chaplin, Walt Disney, ma anche gli studi della cosiddetta “powerty row”, strada della povertà, come la Monogram o la Republic, specializzate in B-Movies). Inoltre c’erano alcuni produttori talmente potenti che diventano un caso a se stante, come Samuel Goldwin o David Selznick.
Il successo dell’impero classico hollywoodiano si basa su almeno tre fattori: lo studio system, lo star system ed i generi cinematografici:
- come detto, la forza dello studio system era il completo controllo, da parte delle Major, di tutti gli aspetti della produzione di un film, dal soggetti fino all’esercizio. Le Big Five possedevano solo il 17% dei cinema statunitensi, ma questa percentuale molto bassa costituiva il 70% delle sale di prima visione in 92 città; questo garantiva l’uscita dei film nelle migliori sale, per un periodo di volta in volta diverso (i film rimanevano in cartellone fino a quando i soldi spesi per la produzione non fossero rientrati per intero, e più...). Quindi il produttore aveva il completo controllo del film, e riusciva a preventivarne il successo ancor prima di iniziare la lavorazione;
- lo star system si basa sul divismo cinematografico che, nel cinema, si è diffuso piuttosto tardi. Certo, alcuni film di Griffith avviarono questo fenomeno, ma è solamente con la prima edizione degli Oscar, nel 1927, che questo fenomeno si afferma del tutto. Il divismo cinematografico è forse il più forte principio economico su cui si basa lo studio system, che tiene i suoi attori strapagati sotto contratto. Naturalmente lo scopo del divismo è quello di far crescere la notorietà delle star nel mondo e quello di far lievitare paurosamente i costi del cinema tramite ingaggi miliardari. Lo star system si basa sui seguenti criteri:
- il racconto, e la messinscena, deve adattarsi alle caratteristiche della star; si attuano precise strategie affinché l’attenzione dello spettatore rimanga concentrata sul divo o sulla diva. Insomma, tutto ruota attorno alla star;
- Il rapporto attore personaggio è molto più forte che a teatro: ha scritto Edgar Morin che l’attore beneficia di una “super personalità” conferitagli dai diversi ruoli interpretati e dalle costruzioni pubblicitarie dell’industria culturale. Come per i generi, anche i divi debbono variare i vari cliché affinché il pubblico possa sempre, e sempre di più, identificarsi con l’eroe;
- La star è sempre al centro del film, e bisogna mettere in atto una serie di strategie per far funzionare tutto al meglio: oltre a rimandarne l’entrata in scena, occorre anche curare il primo impatto della star con il pubblico. LO studio system ha messo a punto due strategie ben definite: innanzitutto l’entrata e l’uscita della star varia di genere in genere, in modo da stupire il pubblico senza tradirne le aspettative; in secondo luogo, l’effetto assenza costruisce l’attesa e l’attenzione del pubblico verso la star.
- I generi cinematografici costituiscono il terzo punto sul quale si basa lo studio system: Scorsese afferma che i generi cinematografici americani per eccellenza sono quelli autoctoni: il Western, innanzitutto, poi il Gangster Movie ed il Musical. Il genere si definisce tramite “l’obbligatorio ed il proibito”, ovvero una serie di regole non scritte che obbliga ad inserire alcuni elementi nel film (come il duello nei western) e che obbliga a non inserirne altri (la violenza nei Musical). Inoltre i generi funzionano grazie ad un processo di standardizzazione e di differenziazione secondo le regole fondamentali del marketing, che mirano a non sconvolgere mai lo spettatore, bensì a dargli – sempre sotto diverse spoglie – ciò che lui vuole e preferisce. Ciò ha portato non soli le star ed i registi a specializzarsi, ma anche le Major stesse (la MGM nei Musical, la WB nei Gangster movie, la RKO negli horror a basso budget).
Osserviamo ora le cause del declino dell’impero classico Hollywoodiano:
Come è noto, il tramonto del cinema classico hollywoodiano avviene soprattutto a causa di due fenomeni assolutamente fondamentali:
- Nel 1948, all’inizio della guerra fredda, il governo americano obbliga le Major a separare la produzione/distribuzione dall’esercizio. La detenzione di una catena di sale diventa allora illegale, e le Major sono costrette ad abbandonare uno dei punti forza del loro potere;
- Il secondo motivo è ancor più determinante: la concorrenza della TV. Il cinema, dopo aver impedito lo sviluppo della Tv per tutti gli anni Trenta (poiché si rischiava una concorrenza fra due mezzi diversi che mirano allo stesso obbiettivo), deve cedere al decreto della FCC che, nel 1946 abolisce ogni vincolo trasmissivo e gli apparecchi Tv entrano in produzione di massa: in due anni gli utenti diventano 10 milioni. La guerra fra Cinema e TV vede il cinema uscire sostanzialmente sconfitto, poiché la TV diviene sempre di più il mass media più diffuso. L’industria cinematografica capisce che per sopravvivere deve, da un lato, scendere a compromessi con la TV, dall’altro aumenta la propria spettacolarità ed irripetibilità delle proiezioni (tramite i formati panoramici e gli effetti speciali, il Monopack per il colore ecc.).
La “politica degli autori” e André Bazin
La rivista fondata da André Bazin e Jaques Doniol-Valcroze, i famosi Cahiers du Cinema, furono il trampolino di lancio di molti fra i maggiori esponenti della Nouvelle vague. La “politica degli autori” divenne un po’ la parola d’ordine del gruppo, che passò alla regia dopo anni di critica militante proprio sui Cahiers du Cinema.
André Bazin fu un po’ il padre spirituale di questo movimento, ed elaborò una teoria del linguaggio cinematografico non più basata sul montaggio (come invece fu dall’epoca del muto in poi), ma piuttosto su quegli elementi che permettevano un rapporto diretto con la realtà (Profondità di campo, Piano sequenza e Long Take). Attraverso lo studio dell’opera di W.Wyler, di O.Welles (specie Quarto potere) e di Rossellini, Bazin prese le distanze dal concetto di “montaggio sovrano” del cinema sovietico (Ejzenstejn e Pudovkin) ma anche da quello di découpage classico.
Ontologia del linguaggio è il titolo del primo saggio del suo volume, pubblicato postumo, Che cos’è il Cinema? Il tema centrale è proprio l’esaltazione del carattere di riproduzione meccanica della realtà che il cinema produce. Per questo motivo il cineasta deve rispettare la continuità dell’evento e la sua durata reale, senza alcuna interruzione da parte del montaggio. Ne deriva la teoria del “montaggio proibito”: quando l’azione richiede una soluzione di continuità, il montaggio è proibito. Ed in più i metodi di ripresa più congeniali a Bazin, e cioè la profondità di campo, il piano sequenza ed il long take, permettono allo spettatore – in modo soggettivo – di crearsi il proprio Découpage grazie al movimento degli occhi.
Il New American Cinema
La vera rivolta contro Hollywood, soprattutto contro il sistema spettacolare, nasce lontano dagli studi cinematografici delle grandi case di produzione; nasce nei piccoli circoli culturali, nelle università e fra gli artisti d’avanguardia: e si allarga a macchia d’olio lungo tutti gli anni ’60, coinvolgendo parzialmente la stessa produzione hollywoodiana ed il cinema europeo e mondiale.
E’ questo un cinema sotterraneo in duplice senso, che era sconosciuto alla maggior parte del pubblico e trattava temi inusuali; un cinema che, da sotterraneo, emerse negli anni Sessanta, ottenendo in certi casi – basti citare i film del pittore e cineasta Andy Warhol e quelli del suo allievo prediletto Paul Morrissey – un notevole successo, sia pure per lo scandalo che queste opere suscitarono.
Il cinema underground non nasce, in verità, nel 1959 (dalla definizione di Lewis Jacobs in un suo articolo sulla rivista “Film Culture”, che sarà la rivista ufficiale del movimento): ha origini più antiche e saldamente radicate nell’avanguardia storica, al movimento dadaista e surrealista degli anni Venti. A quel cinema gli artisti dell’underground attingeranno a piene mani.
L’immagine elettronica
Uno dei temi forti, nell’ambito del cinema degli ultimi anni, è sicuramente il passaggio dalle tecniche di riproduzione chimico-meccaniche a quelle elettroniche. Il rapporto tra le due si concretizza secondo queste modalità:
- Distribuzione di immagini cinematografiche mediante supporto elettronico (film in Tv, Videocassette, Laserdisc e Satelliti);
- Intervento diretto dell’istituzione televisiva nella produzione cinematografica, per un doppio sfruttamento;
- Integrazione fra tecnologia cinematografica tradizionale e tecnologia elettronica nella produzione di film;
- Sperimentazione di tecnologie esclusivamente elettroniche, con lo scopo di soppiantare quelle tradizionali (in parte avvenuto con le telecamere, che hanno soppiantato il Super8).
I punti 3 e 4 presentano problemi assai più evidenti rispetto ai punti 1 e 2: infatti l’intervento della Tv nella produzione di film a doppio sfruttamento può considerarsi cosa assai positiva, e lo stesso va detto per la diffusione tramite CD, Videotape o Satelliti (in quanto ci permette di vedere, e rivedere, film altrimenti dimenticati). L’integrazione fra tecnologie digitali e tecnologie tradizionali è, invece, un fenomeno più complesso. Ma andiamo con ordine:
- L’impiego del video in fase di ripresa può costituire un vantaggio enorme: il regista può controllare tutto facendosi già un’idea di come le riprese verranno sullo schermo (senza dover necessariamente attendere i giornalieri); nel caso di film in video, le cose si semplificano ulteriormente, ma attenzione alle differenze fra i due supporti (pellicola e video);
- In fase di montaggio, tramite le tecnologie digitali (AVID, Lightworks ecc.), è possibile lavorare in modo più rapido, preciso, funzionale ed economico (non servono le copie per il montaggio); in digitale è possibile avere un controllo immediato del risultato, e cambiare di continuo senza danni materiali al film (editing non lineare e non distruttivo);
- Le tecnologie digitali permettono la realizzazione di riprese altrimenti impossibili o complesse (tramite, ad esempio, il Movie Control). Il computer può programmare le riprese in modo che la cinepresa esegua ciò che il regista ha previsto a monte;
- Le tecnologie digitali permettono, infine, la realizzazione di un nuovo tipo di spettacolo cinematografico interamente realizzato al computer (Toy Story), non necessariamente con lo scopo di soppiantarle
.
1. Definire l’origine
Tracciare una storia dell’analisi filmica non è un’impresa semplice. Oltretutto c’è il rischio di smarrirsi nell’affascinante lettura dei molti esempi di analisi testuale del film, che a partire dalla metà degli anni Settanta hanno maturato un’attenta riflessione sulle categorie utilizzate. Nella maggior parte dei casi, infatti, non si è trattato solo di esercizi applicativi, ma di vere e proprie esplorazioni teoriche, come si può desumere dagli interventi di Roger Odin, il quale ha ripercorso in più occasioni la storia di queste analisi, illustrandone le direzioni, i metodi, gli obiettivi (Odin, 1988). Anche Aumont e Marie ne hanno dato una mappa, con particolare riguardo alle procedure di descrizione messe in opera e ai grandi temi trattati (Aumont - Marie, 1988). Infine Bellour, che di queste analisi è stato uno dei pionieri e uno degli animatori, ce ne ha presentato le vicende sotto forma di un’appassionata autobiografia (Bellour, 1979).In questa sede però risulta più opportuno interrogarsi sulle ragioni che hanno segnato la nascita e il diffondersi di questa pratica. Come mai le teorie del cinema hanno iniziato a piegarsi verso l’analisi testuale?
In primo luogo perché si è iniziato a pensare al cinema come a un fenomeno linguistico forte, in grado di possedere uno statuto analogo a quello della lingua verbale. Questa riflessione ha preso avvio a partire da un intervento di Christian Metz apparso nel 1964 sulla rivista francese Communications, nel quale l’autore si domandava da una parte se il cinema potesse rientrare in quei fenomeni di cui si occupava la semiotica; dall’altra se esso fosse una lingua, cioè un repertorio codificato di simboli, figure o formule, oppure un linguaggio, cioè un discorso in gran parte spontaneo e autoregolato. Optando per la seconda ipotesi, Metz concludeva affermando la necessità di "fare la semiologia del cinema". Il passo successivo, sempre compiuto da Metz (1971) in questa direzione, è stato quello di definire la Grande sintagmatica del cinema narrativo, ribadendo ancora la possibilità di rinvenire nei film strutture sintattiche simili a quelle della lingua, oltre che procedendo a una sistematizzazione dei codici del linguaggio cinematografico.
Inoltre, l’analisi filmica è nata dalla convinzione che per studiare il cinema sia necessario passare attraverso le singole realizzazioni filmiche. In questa direzione quindi l’interesse non viene più posto sulla definizione dei codici operanti all’interno del sistema linguistico del cinema, ma sul processo che tali codici mettono in atto in ogni singolo film. E da qui l’idea di film come testo, per comprendere il quale non è più sufficiente definire la sola struttura dell’opera, ma diventa necessario analizzare le pratiche significanti che lo attraversano e lo muovono, oltre che le dinamiche comunicative inscritte.
2. Che cosa significa analizzare un film
Come si analizza un film, quali sono le procedure e le tappe che l’analista deve compiere, quali raccomandazioni è bene che egli segua?2.1. La buona distanza
. Possiamo definire l’analisi come un insieme di operazioni compiute su un oggetto e consistenti in una sua scomposizione e in una sua successiva ricomposizione, al fine di individuarne meglio le componenti, l’architettura, le dinamiche. In sintesi, il principio di costruzione e di funzionamento.
Tali operazioni, compiute su un film, comportano necessariamente un distacco dalla situazione normale in cui esso viene percepito. È infatti una caratteristica del film quella di avere una realtà materiale pressoché inafferrabile, costituita com’è di luci e ombre sullo schermo. Questa fuggevolezza ha da sempre reso il film un oggetto difficilmente padroneggiabile. Certamente lo si poteva vedere più volte, cogliendo già una decisiva differenza fra la prima visione – sottomessa quasi interamente all’ordine narrativo e quindi incompleta – e le successive che, sfuggendo alla fascinazione della storia, si aprivano su dimensioni più complesse. Tuttavia è solo con l’affinarsi di processi analitici rigorosi e con la disponibilità di strumenti quali il videoregistratore con le funzioni di moviola che si è ridotto drasticamente il senso di impotenza dello spettatore di fronte al suo oggetto, rendendo possibile a tutti non solo ‘rivedere’ il film, ma ‘visionarlo’, spezzandolo, fermandolo, ripercorrendolo, dominandolo e sottomettendolo a un nuovo ordine.
Questo diverso modo di vedere il film non è naturale, esso si scontra con uno dei grandi tabù su cui si fonda la fascinazione filmica, che presuppone uno scorrimento continuo delle immagini; tuttavia un tale distacco resta la condizione indispensabile per penetrare nel testo e ripercorrerne i tratti costitutivi.
2.2. Gli snodi dell’analisi.
In primo luogo sull’analisi pesa la comprensione preliminare che si ha del testo: è su di essa che l’esercizio di lettura inevitabilmente si appoggia, per confermarla o contraddirla.
In secondo luogo sull’analisi pesa la presenza di un’ipotesi esplorativa. L’analista porta con sé una sorta di prefigurazione di quello che sarà, o meglio potrebbe essere, il risultato della ricognizione e imposta il suo lavoro sulla necessità di verificare, approfondire e, se è il caso, correggere questa sua intuizione di partenza.
C’è dunque nell’analisi una presenza non neutra dell’osservatore che si evidenzia anche nella scelta dell’oggetto, del metodo e degli aspetti da privilegiare: quale film, o quale gruppo di film, o ancora quale particolare sequenza analizzare; quindi ci si può avvalere, ad esempio, degli strumenti della sociologia, vedendo il film come una rappresentazione più o meno compiuta del sociale, oppure di quelli della psicoanalisi, analizzando i personaggi e le loro pulsioni profonde, oppure affrontando il film come una sorta di testo onirico, o ancora considerando il funzionamento metapsicologico del meccanismo filmico, capace di rappresentare e narrare in modo del tutto analogo a quanto fa l’inconscio. Infine c’è la scelta degli aspetti da privilegiare, del terreno concreto di osservazione. Si potranno allora analizzare elementi quali le componenti linguistiche, le modalità rappresentative, le dinamiche narrative e le strategie di comunicazione.
3. Il percorso dell’analisi
Analizzare significa dunque rompere un’unità in frammenti e riunire questi frammenti in un’unità nuova. Vediamo nei particolari le tappe di questo percorso.3.1. La scomposizione: segmentazione e stratificazione.
Di fronte a un oggetto quale un testo filmico si impongono subito all’analista due serie di domande. La prima esprime l’esigenza di distinguere nel continuum del testo delle porzioni precise per procedere con ordine e sistematicità. La seconda serie di domande pone l’esigenza di indagare trasversalmente l’unità di testo prescelto.
Queste due serie di quesiti segnano le due fasi della scomposizione di un film, rispettivamente la segmentazione della linearità e la stratificazione dello spessore.
3.1.1. Segmentazione.
Scomporre linearmente significa suddividere il testo nella sua lunghezza ed estensione in segmenti via via più brevi che rappresentano unità di contenuto sempre più piccole. La soluzione più semplice è quella di dividere il film in grandi unità di contenuto, in blocchi narrativi conclusi, e questi in altre unità più piccole. Si otterranno così segmenti di diversa grandezza e complessità.
a) Gli episodi. Anche nei film, come nei libri, ci sono dei segni che marcano la rottura della continuità. Segni che indicano la fine di una parte e l’inizio di un’altra; che segnano il confine di vere e proprie grandi unità autonome di contenuto. A indicare l’inizio degli episodi si possono trovare dei titoli in sovrimpressione (Rocco e i suoi fratelli, L. Visconti) oppure degli stacchi di montaggio bruschi, magari accompagnati da una voce fuori campo che sottolinea il cambiamento di scena (Paisà, R. Rossellini).
b) Le sequenze. Pochi sono i film a episodi. Più comunemente quando si parla di unità compiute di contenuto ci si riferisce alle sequenze. Queste sono più brevi, meno articolate e meno fortemente delimitate degli episodi, ma mantengono di questi ultimi il carattere autonomo e distintivo. Anche le sequenze ricorrono a segni di punteggiatura che ne marcano i confini. Operano in questo senso le dissolvenze incrociate (il contemporaneo svanire di un’immagine e l’emergere di un’altra); le dissolvenze su nero o dal nero (a seconda che l’immagine sfumi in nero o venga alla luce da esso); le tendine (linee divisorie tra due immagini che si muovono lateralmente o verticalmente riducendo l’immagine e lasciando il posto a un’altra); l’iris (un cerchio nero che si chiude progressivamente sull’immagine). Talvolta non si trovano però dei segni così forti ed espliciti, ma solo semplici stacchi. In realtà possono definirsi anche delle sottosequenze, cioè unità di contenuto che, pur essendo ben identificabili e delineabili, possono più correttamente essere lette come componenti di un’unità semantica superiore.
c) Le inquadrature. Proseguendo nella scomposizione della linearità si arriva fino all’inquadratura. Essa è l’unità di ripresa, vale a dire un segmento di pellicola girato in continuità, ovvero un pezzo di pellicola delimitato da due stacchi. A questa unità tecnica non corrisponde però sempre un’unitarietà percettiva o funzionale. Il campo/controcampo pur essendo l’accostamento di due inquadrature (l’una delle quali mostra un soggetto di fronte che conversa e il suo interlocutore di spalle, l’altra il secondo soggetto di fronte e il primo di spalle – l’una con il soggetto che guarda, l’altra con l’oggetto guardato), viene generalmente percepito come un blocco unico.
d) Le immagini. Infine le unità più piccole. Ogni volta che il movimento dell’azione muta, che la cornice dell’immagine si sposta a inquadrare porzioni nuove di spazio, che il punto di vista si modifica siamo di fronte a una nuova immagine. Essa dunque è una porzione di ripresa che si presenta come uniforme circa i modi di rappresentazione.
3.1.2. Stratificazione.
La seconda forma di scomposizione del testo filmico consiste nello spezzare la compattezza del film e nel cogliere i diversi strati che lo compongono. Una volta ripartito il film in episodi, sequenze, inquadrature e immagini, si passa a sezionare questi segmenti, individuandone le componenti interne (lo spazio, il tempo, l’azione, i valori figurativi, ecc.) che saranno analizzate una alla volta sia nel loro gioco reciproco all’interno di un segmento dato, sia nella diversità di forme e funzioni che vengono ad assumere lungo tutto il film. Vediamo operativamente come si procede alla stratificazione di un testo filmico.
a) Identificazione di una serie di elementi omogenei. Si identificano alcuni fattori che si segnalano per la loro uniformità che, in quanto tali, compongono una serie omogenea: elementi stilistici (toni di illuminazione), elementi tematici (il presentarsi di un certo luogo, situazione), elementi narrativi (il ripetersi di una certa azione). b) Articolazione della serie. Si va oltre l’omogeneità della serie per coglierne le peculiarità degli elementi. In questa direzione possono verificarsi: opposizioni di due o più realizzazioni (occorrenze contrarie di una figura stilistica: dissolvenza vs. stacco netto – di un nucleo tematico: notte vs. giorno – di uno snodo narrativo: essere buono vs. essere malvagio); oppure varianti di una stessa realizzazione (occorrenze diversificate di una medesima figura stilistica: dissolvenza incrociata vs. dissolvenza in nero – di un medesimo nucleo tematico: mattina vs. pomeriggio – di un medesimo snodo narrativo: leggere un libro vs. leggere un giornale).
Dopo la specificazione di tutti gli elementi che evidenziano un certo asse e l’individuazione di tutte le differenze che caratterizzano questi elementi, si dovranno accorpare le due serie di osservazioni e si dovrà ricostruire un disegno unitario del testo nella sua profondità.
3.2. La ricomposizione: enumerazione, ordinamento, ricompattamento, modellizzazione.
La fase della ricomposizione comporta una riaggregazione critica e creativa degli elementi individuati nella scomposizione. Le operazioni in sequenza logica sono essenzialmente quattro.
a) L’enumerazione. In questa fase si tiene conto di tutti gli elementi identificati durante la scomposizione. È il momento dell’elenco sistematico delle presenze nel film.
b) L’ordinamento. In questa seconda fase della ricomposizione si mette in evidenza il posto che ciascun elemento occupa nell’insieme del film, sia rispetto allo svolgimento lineare del testo, sia rispetto alla sua strutturazione in profondità.
Con queste due prime operazioni si identifica un vero e proprio sistema di relazioni. Costruita una tale trama, si può ritenere conclusa la fase di inventario e di organizzazione. Si passa ora a tirare le fila.
c) Il ricompattamento. In questa fase si ricostituisce l’articolazione generale del film: il suo andamento complessivo, il suo tema diffuso, le opposizioni reiterate. Si tratta di restituire in qualche modo un’immagine ristretta del testo, un promemoria.
L’ultima tappa, forse la più complessa, sarà passare dal promemoria a una rappresentazione capace non solo di sintetizzare il fenomeno, ma anche di spiegarlo.
d) La modellizzazione. Modellizzare significa individuare uno schema che, riassumendo il testo, ne espliciti al contempo il principio di funzionamento e di intellegibilità. Il modello è quindi una sorta di rappresentazione simbolica che mostra le connessioni reciproche tra i fenomeni, ne rivela la sistematicità e la regolarità altrimenti nascosta. Molti sono i modelli possibili, con caratteristiche formali differenti. Si possono enucleare modelli figurativi e modelli astratti: i primi rintracciabili in una cifra simbolica (contrasto libertà-necessità, amore-morte, la passione di Cristo, ecc.); i secondi in una formula espressa in un linguaggio, per così dire, logico-matematico (A opposto a B, A – A = 0, ecc.). Possono anche trovarsi modelli statici e modelli dinamici. I primi rendono ragione dei legami fra gli elementi del film, cogliendone le relazioni reciproche in una visione immobilizzata: il testo non è afferrato nel suo procedere, ma nel suo disporsi complessivo. I modelli dinamici, al contrario, ordinano gli elementi intorno a un asse temporale: lo schema prevede il movimento, l’evoluzione, il divenire.
Questa sistematizzazione dei vari tipi di modelli non è così rigida: si possono creare modelli combinati statico-figurativo, dinamico-figurativo, statico-astratto, dinamico-astratto.
3.3. Validità dell’analisi.
Nell’analisi il rigore della metodologia segna solo una strada: come percorrerla è un fatto di scelte personalissime. A questo punto ci si potrebbe chiedere quali criteri intervengano nella scelta di un modello, in nome di che cosa privilegiare una strada al posto di un’altra. Ora, i numerosi parametri di riferimento che si sono succeduti a guidare l’analisi testuale possono essere ricondotti a quattro criteri di base: la profondità, l’estensione, l’economicità e l’eleganza.
a) La profondità. In base a tale criterio, un’analisi per essere valida deve essere profonda: deve cioè essere in grado, scandagliando il testo, di cogliere il cuore nascosto, il nocciolo segreto che al tempo stesso riassume il testo e ne illumina il senso. Tale criterio presuppone, evidentemente, un’idea di testo come unità complessa strutturata su più livelli.
b) L’estensione. In base a questo criterio, l’analisi valida è quella che tiene conto del maggior numero di elementi. L’idea di testo che è sottesa a tale criterio è quella di una trama di fili che si estendono e si intrecciano secondo un disegno complesso, e che non può pertanto essere colta secondo un approccio in profondità, ma piuttosto grazie a una visione a largo orizzonte.
c) L’economicità. In base a questo criterio, l’analisi migliore viene a essere quella maggiormente sintetica. Il testo, infatti, è visto come dispositivo di conoscenze che può essere espanso o contratto a seconda delle differenti situazioni d’uso e che dunque ben si presta a sintesi funzionali.
d) L’eleganza. Alla base di quest’ultimo criterio c’è un’idea di testo, come una sorta di gioco che riposa sul piacere dell’espressività, e a cui lo spettatore e l’analista sono invitati a partecipare. In questo senso l’analisi è considerata come un impegno puramente personale, una sorta di continuazione della partita, legata totalmente all’intimo piacere dell’atto interpretativo e della creatività che esso esprime.
Ognuno di questi quattro criteri, che si sono succeduti nelle varie fasi storiche della pratica analitica del film, mette in gioco un elemento chiave dell’analisi: il criterio di profondità ne mette in gioco la verità; il criterio dell’estensione ne mette in gioco il raggio d’azione; il criterio di economia ne mette in gioca la funzionalità; mentre il criterio dell’eleganza mette in gioco il piacere della scrittura e della lettura del testo.
4. Una tipologia d’analisi
Esistono territori specifici su cui l’a.d.f. lavora: le componenti cinematografiche, la rappresentazione, la narrazione e la comunicazione. L’analista può privilegiare una di queste aree per intraprendere il proprio lavoro di scomposizione e ricomposizione. Vediamo dunque di esporre in brevi schede riassuntive l’articolazione dei quattro possibili campi sui quali è possibile operare in sede d’analisi.4.1. Analisi delle componenti cinematografiche.
Si è già visto in apertura come il dibattito intorno alla linguisticità del cinema sia stato determinante per l’avvio dell’analisi filmica. Ma definire il cinema un linguaggio significa anche rintracciarne i significanti e le aree espressive, cioè il materiale con il quale sono costituiti i suoi segni.
Si possono distinguere cinque ordini di significanti cinematografici: le immagini, le tracce scritte, le voci, i rumori e la musica. Ognuno di essi richiama inevitabilmente una specifica area espressiva, dal sistema della lingua naturale alla pittura, dalla fotografia all’articolazione di note, timbri e toni.
Questo perché il cinema è un linguaggio complesso che si avvale di diversi codici.
– Codici tecnologici di base: sensibilità e formato della pellicola; cadenza, direzione di marcia della pellicola; schermo come superficie riflettente vs. superficie trasparente, luminosità, ampiezza.
– Codici sintattici o del montaggio: associazione per identità (ritorno di una stessa immagine o di un identico elemento da immagine a immagine); per analogia e per contrasto; per prossimità (elementi contigui da un’immagine all’altra); per transitività (elemento di completamento o di prolungamento in un’immagine rispetto alla precedente); per accostamento (giustapposizione di due immagini).
– Codici della serie visiva: iconicità (codici della denominazione e del riconoscimento iconico; codici della trascrizione iconica; codici della composizione iconica; codici iconografici che regolano la costruzione di figure complesse, ma fortemente convenzionalizzate e con un significato fisso; codici stilistici); composizione fotografica (organizzazione prospettica, margini del quadro, modi della ripresa, forme di illuminazione, bianco e nero vs. colore); mobilità (tipi di movimento del profilmico, cioè della realtà rappresentata, tipi di movimento effettivo della macchina da presa e di movimento apparente come lo zoom).
– Codici grafici (forme dei titoli, delle didascalie, dei sottotitoli, delle scritte).
– Codici sonori (natura del suono: voci, rumori, suoni; collocazione del suono: in/off/over ).
4.2. Analisi della rappresentazione.
Il film oltre a essere il risultato del lavoro intrecciato dei codici, è anche una rappresentazione. Essa opera a tre livelli:
a) la messa in scena, che nasce da un lavoro di setting e che riguarda appunto i contenuti dell’immagine;
b) la messa in quadro, che nasce dalla ripresa fotografica e che riguarda appunto le modalità di assunzione e presentazione dei contenuti;
c) la messa in serie, che affonda le sue radici nel lavoro del montaggio e che riguarda appunto le relazioni e i nessi che ogni immagine intrattiene con quella che la precede e con quella che la segue.
In particolare l’immagine cinematografica rappresenta attraverso gli assi spazio-temporali, grazie ai quali organizza il mondo filmico.
Lo spazio può essere affrontato a livello di rappresentato (lo spazio della vita reale inscritto nel film) o a livello di rappresentazione (lo spazio cinematografico ovvero lo spazio del film).
4.3. Analisi della narrazione.
Un insieme di immagini e suoni assume anche una dimensione narrativa, cioè si presenta come un concatenarsi di situazioni, in cui si realizzano eventi e in cui operano personaggi calati in specifici ambienti. Questo sin dalle origini del mezzo, quando la natura fabulatoria prese il sopravvento sul dispositivo ottico e la voglia di documentare il mondo lasciò il posto al desiderio di raccontarlo. Ma il nuovo mezzo dispone delle stesse regole del gioco delle più antiche forme di racconto: qualcosa succede, succede a qualcuno o qualcuno la fa succedere, il succedere cambia via via la situazione (Narrazione; Narratologia; Attante).
4.4. Analisi della comunicazione.
Infine, il testo filmico è anche oggetto e terreno della comunicazione: qualcosa che viene trasferito da un destinatore a un destinatario e un luogo di partecipazione e di interazione tra queste figure. Analizzare il film come atto di comunicazione significa dunque tener presente che nel testo sono rinvenibili tracce della situazione comunicativa in cui esso intende collocarsi. In particolare il film prevede la presenza di figure esterne al testo, l’Emittente e il Recettore, e figure inscritte in esso, l’Autore e lo Spettatore implicito, il Narratore e il Narratario:
– l’Emittente, non è solo l’autore reale ma indica più in generale i modi di produzione del film;
– il Recettore, a sua volta, non è solo lo spettatore reale, ma sta anche a indicare le forme di consumo del film;
– l’Autore implicito o Autore modello (Eco, 1979) o Enunciatore (Bettetini, 1984) è la figura vicaria dell’emittente e si rende evidente nel testo in tutte quelle tracce (marche linguistiche, personaggi, oggetti, ecc.) che rappresentano la logica che informa il film, ovvero il progetto comunicativo;
– lo Spettatore implicito (o Spettatore modello o Enunciatario) è la figura vicaria del recettore e si rende evidente nel testo in tutte quelle tracce che rappresentano la chiave secondo cui il film va preso, ovvero le condizioni di lettura;
– il Narratore è l’esplicitarsi del progetto comunicativo in un elemento testuale;
– il Narratario è l’esplicitarsi delle condizioni di lettura in un elemento testuale.
Ma essere figura reale o vicaria della comunicazione comporta anche l’assunzione di un punto di vista: attraverso un punto di vista si identifica una porzione di realtà, si accede ad alcune informazioni, ci si mette in una certa prospettiva. Questa selezione mette però in rilievo ciò che si è scelto. Si parla in questo caso di focalizzazione, cioè questo doppio movimento di selezione e messa in rilievo, di restrizione e di valorizzazione. Inoltre il punto di vista, nella sua triplice natura, può essere attribuito con minore o maggiore forza alle figure analizzate in precedenza, creando non soltanto fenomeni di attribuzione, ma anche di ampiezza del punto di vista.
Oltre alla minore/maggior forza del punto di vista si può analizzare se esso sia conforme o difforme tra le diverse figure. Infatti può accadere che i punti di vista non risultino congrui fra loro, e in particolare che quelli specifici, attribuibili al Narratore e al Narratario, si discostino da quelli che li inglobano e li definiscono, ovvero quelli dell’Autore e dello Spettatore implicito.
Infine si possono analizzare i diversi atteggiamenti comunicativi, di natura strettamente cinematografica, che derivano dalle varie forme del punto di vista:
– oggettiva, l’immagine mostra una porzione di realtà in modo diretto e funzionale, cioè presentando le cose senza alcuna mediazione ed esponendo tutto ciò che in quel momento è necessario conoscere;
– oggettiva irreale, l’immagine mostra una porzione di realtà in modo anomalo o apparentemente ingiustificato, cioè va oltre alla semplice raffigurazione;
– interpellazione, l’immagine presenta un personaggio, un oggetto o una soluzione espressiva la cui funzione primaria è quella di rivolgersi allo spettatore (voce over, sguardo in macchina, didascalie, ecc.);
– soggettiva, l’immagine mostra la fonte di uno sguardo e l’oggetto guardato (il vedere, il sapere e il credere dello spettatore passano attraverso quelli del personaggio a cui è attribuibile la soggettiva).
Sono state date solo le coordinate, i concetti base, dei quattro grandi territori sui quali si può condurre l’analisi filmica: i codici espressivi, la rappresentazione, la narrazione e la comunicazione sono piste che possono essere seguite per applicare la metodologia dell’a.d.f.
A volte capita che, per la versione in video, i film vengano modificati: si tagliano scene di sesso, violenza, dialoghi eccessivamente offensivi.
Pensiamo alla versione TV de “Il silenzio degli Innocenti” (Jonathan Damme, 1991), contiene ad esempio scene diverse rispetto a quella distribuita al cinema.
Viene utilizzata la Compressione dei Tempi, che accelera impercettibilmente la velocità del film al fine di inserirvi al suo interno spot pubblicitari.
Alcune scene vengono ridoppiate…
Spesso anche film destinati al noleggio di videocassette vengono revisionati; le colonne sonore possono essere sostituite a causa dell’impossibilità di negoziarne i diritti.
Differenze notevoli si notano tuttavia nel formato d’immagine adattata allo schermo televisivo.
Solo in casi rari infatti la versione video rispetta il formato originale disponendo bande nere sopra e sotto l’immagine: si tagliano cioè porzioni dall’immagine originale, spesso sino al 50%.
E’ il tecnico che decide quali porzioni dell’immagine eliminare.
A volte decide di ricavare inquadrature distinte da quella che in origine era una inquadratura unica alterando così la versione originale del film.
Per questa ragione alcuni registi girano già in funzione del formato televisivo, concentrando l’azione importante nell’area che resterà intatta poi per la versione in video.
Ad esempio, James Cameron ha girato il “Titanic” (1997) tenendo conto della distribuzione in videocassetta in modo tale che le scene più intime soffrissero meno delle sequenze più spettacolari.
Da qualche tempo tuttavia, la diffusione dei DVD fornisce allo spettatore sempre più opzioni; e così all’interno dell’inquadratura è possibile visualizzare o meno le bande nere.
Diana Rodi
NON si è mai abbastanza sensibili al rapporto tra passato e futuro, in quest’epoca detta post-moderna dominata dall’ossessiva insistenza sul presente e solo su quello. Per questo merita attenzione il ”manifesto” che le Giornate degli Autori, rassegna indipendente operante nel quadro della Mostra del Cinema, lanceranno fra pochi giorni a Venezia. Aderendo a questo manifesto un gruppo di persone sensibili alla storia del nostro paese (il passato) e alle sue strutture educative (il futuro) e che considerano il cinema l’arte più rappresentativa del XX secolo – e io aggiungerei: insieme al jazz, alla fotografia, e forse al fumetto – chiede che lo Stato si faccia carico, come avviene in altri campi e arti, del passato del nostro cinema, del patrimonio artistico del cinema che sono, principalmente ed essenzialmente, i film.
Chi sono e cosa chiedono i firmatari di questo documento? Sono filosofi come Bodei e Vattimo, giornalisti come Zavoli, storici come Ginzburg, gente di spettacolo come la Nannini, la Marini, Fo, la Guzzanti, psichiatri come Cancrini, scrittori come La Capria e chiedono pochissimo nei fatti e moltissimo nella sostanza. Chiedono che lo Stato recuperi, per iniziare, cento film che degli esperti – speriamo affidabili – giudicano importanti per la comprensione del nostro passato, in particolare degli anni più creativi che il nostro cinema ha vissuto, quelli in cui è riuscito a esprimere una enorme sintonia con i sentimenti, i problemi e i sogni della maggior parte della popolazione.
Chiedono che esso si sostituisca ai privati almeno in parte, nella gestione di questo patrimonio, che subentri insomma ai privati che ne posseggono i diritti e che si muovono, nello sfruttamento dei “cento titoli”, secondo logiche solo commerciali e semmai rispondendo al flusso delle mode. Chiedono in definitiva che ogni scuola media del paese possa disporre dei dvd di questi film, fondamentali per spiegare agli scolari cosa sono stati l’Italia e gli italiani (e cos’è stato il loro cinema). Questi film possono aiutarli a scoprire e a indagare l’italica identità antropologica, storica, culturale, religiosa in tutta la sua vitalità così come in tutte le sue contraddizioni.
Cosa può costare allo Stato tutto questo? Ben poco, se si tiene conto di quel che lo Stato spende in conservazione del patrimonio artistico nazionale, e in manifestazioni e celebrazioni perlopiù inutili; se si tiene conto di quello che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni spendono oggi in cultura-spettacolo, in “eventi” e passerelle di immensa superficialità. Il cinema – certi film in particolare – ci ha saputo raccontare meglio di ogni altra forma espressiva, e merita il riconoscimento di dignità che hanno ottenuto da tempo le altre arti: se è vero che il cinema è “la parte fondamentale della nostra memoria collettiva”, come dice il manifesto di cui parliamo, si tratta dunque, né più né meno che di «salvare la Storia», nel suo lascito artistico e mediatico più collettivo. I film che ci hanno più rappresentato, da Roma città aperta a Un borghese piccolo piccolo , dalla Liberazione agli «anni di piombo» (poi, in quegli anni, il cinema ha perduto la sua centralità, e sono gli anni dell’esplosione televisiva, del fenomeno gaglioffo ed eccentrico delle tv private...) erano in qualche modo un prodotto di massa, l’espressione di sentimenti collettivi, e ci fanno capire cos’eravamo e come è potuto accadere che si sia diventati quali oggi siamo.
Gli «esperti» o «probi viri» che dovranno scegliere questi film dovranno mettere in conto, io penso, che esistono dei film importantissimi che sono stati l'espressione di una potente personalità artistica individuale, il regista-autore (facciamo degli esempi: L'avventura di Antonioni, Accattone di Pasolini, Nostra Signora dei turchi di Bene...), altri che sono stati espressione di una potente personalità artistica individuale che sapeva captare i sentimenti collettivi e restituirli a un pubblico di massa in una forma comprensibile a tutti, profonda sotto l’aspetto artistico ma altrettanto grande sotto l’aspetto della comunicazione di massa (degli esempi: La dolce vita di Fellini, Due soldi di speranza di Castellani, Senso di Visconti, La grande abbuffata di Ferreri...) e infine quelli che non dichiaravano ambizioni artistiche immediate ma che erano in qualche modo, si potrebbe dire, «commissionati» dal pubblico ad artisti che finivano per essere una sua diretta espressione (esempi: dozzine e dozzine, stavolta : i film di Totò, quelli di Raffaello Matarazzo, la commedia all’italiana quasi tutta, i film di Ercole e Maciste o i western all’italiana...). Ed è chiaro perché non cito in questo caso dei titoli bensì dei registi, degli attori, dei «generi».
Nel caso di questo cinema la critica ha oscillato tra il disprezzo più snobistico (e idiota) e l’esaltazione più sconsiderata (e idiota). E’ importante che la scelta dei cento film (o della prima tornata di cinquanta), se mai il manifesto di cui parliamo dovesse avere il successo che noi gli auguriamo, non venga affidata a questi due tipi di «esperti» e tantomeno agli attuali «rappresentati delle categorie dei cineasti», che di queste cose hanno smesso di capire e di discutere da tempo, stretti ai loro piccoli carri corporativi e/o clientelari. Il cinema italiano è stato un grande cinema proprio per la sapienza istintiva con la quale ha saputo proporre, confrontare, e spessissimo compenetrare tra loro queste tre modalità che hanno tutte e tre dignità e tutte e tre hanno saputo farne il fenomeno immenso che è stato. Se i nostri figli avranno la possibilità di confrontarsi con il meglio di questa grande esperienza, avranno molto da riflettere sul contesto in cui vivono, sui loro «avi» e genitori, ma anche su di sé. E avranno molto da divertirsi, aprendosi grazie ai film a nuove esplorazioni e scoperte.
«L’arma più forte» come la definirono Mussolini o Stalin, è stata in realtà lo strumento – non l’arma – più grande per l’accesso dei popoli alla democrazia, almeno in quello che si è soliti chiamare Occidente, nel Novecento. Non lo è più, il potere ne ha oggi paura, e ha trasformato la «cultura di massa» in manipolazione di massa, ha capito che si può governare grazie a consumo e consenso e che il consenso è molto più facile conquistarlo con la televisione e la pubblicità, lasciando al cinema una parte infima, di spettacolo robotico e castrato o di arte per pochi, anzi pochissimi. Vedere i film di ieri può anche aiutare le nuove generazioni, chissà, a «farsi un’idea», non solo sul cinema, e a farsi più accorti ed esigenti.
di GOFFREDO FOFI da il www.ilmessaggero.it
Le pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1940 e gli anni 2000. Uno spaccato dell'Italia attraverso il cinema. Ecco l'elenco i cento film italiani da salvare e, naturalmente, da conoscere.
Leggi tutto: 100 FILM DA SALVARE DEL CINEMA ITALIANO (anni 1940 - 2000)
Nel 1944 quattro gerarchi fascisti imprigionano in una villa di campagna, nei pressi di Salò, un gruppo di ragazzi e ragazze con il solo scopo di soddisfare le loro perversioni sessuali e psicopatologiche. L’ultimo film scritto e diretto dal sempre discusso Pier Paolo Pasolini, risalente al 1975 ed apertamente ispirato al romanzo del Marchese de Sade Le 120 giornate di Sodoma, procede seguendo una struttura dantesca in quattro parti: un Antinferno e tre Gironi.
Leggi tutto: SALO' O LE 120 GIORNATE DI SODOMA di Pier Paolo Pasolini
PSYCHO (1960)
Regia Alfred Hitchcock
sceneggiatura di Joseph Stefano (dal romanzo di Robert Bloch)
direttore della fotografia John L. Russell
di Alessandro Bernabucci
Chi è che guarda la città dall’alto fin dentro la stanza d’albergo, atterrando pindaricamente sul
cornicione della finestra di una camera d’albergo all’inizio del film? Un uccello?...
È Hitchcock stesso, naturalmente. Che con il suo sguardo ego-centro dell’azione, oscilla fra
voyerismo e feticismo spingendosi(ci) a curiosare nella vita altrui. Con questo ancoraggio
enunciativo Hitchcock ci accoglie nella sua identità visiva. La Macchina da Presa (MdP) è l’occhio
del regista, si sa; la sua (della MdP e del regista) realtà diventa la nostra realtà. Il pro-filmico
diventa filmico. Per traslato, possiamo dire che gli attanti di questo inizio siamo noi stessi, dunque.
Lo sguardo della MdP deve coincidere con quello dello spettatore; lo sguardo dello spettatore
collima con quello di Hitchcock. E’ uno shift eye da cosa si guarda a chi guarda. Ognuno di noi sta
spiando quei due amanti nella stanza d’albergo. «Mi fa guardare da quel buco di serratura
portatile?», dice Stella (Thelma Ritter), l’infermiera di “Rear window”, volendo guardare con la
macchina fotografica di Jeff (James Stewart). Alzi la mano chi non ha mai guardato dal buco di una
serratura?…e infatti: «Ma non siamo tutti dei voyeur?», rispondendo a Truffaut nel libro-intervista
“Il cinema secondo Hitchcock” (Pratiche Editrice, 1984).
Dunque: “Psycho” è senza dubbio il film più (o)scuro di Hitchcock. Il bianco/nero del film ha
toni crepuscolari. Il giorno è ombra e la notte è tenebra. Marion (Janet Leigh) da soggetto della
propria nevrosi diventa oggetto della psicosi di Norman (Antonhy Perkins), offrendosi a lui
mediante lo sdoppiamento dell’Io nel conflitto Es vs. SuperIo. La demarcazione segmentale è
visibile dal simbolico passaggio da biancheria intima bianca, indossata all’inizio, a biancheria
intima nera indossata quando Marion prepara la valigia per scappare. Marion–Norman: due nomi
speculari. Provate a leggerli da dx a sx; foneticamente si somiglieranno. E il processo
d’identificazione tra i due protagonisti scorre paludoso nel loro inconscio (quella palude dietro il
Motel dove scompare l’automobile). Anche Norman da oggetto della nevrosi della madre è
diventato soggetto della psicosi della Norman/Madre, cioè l’altro Norman. Marion non è che un
uccello da impagliare. Come la madre di Norman. L’uccello non è un feticcio della vita. Anzi. E’ la
rappresentazione simbolica della morte uccello-fallo (il gioco di parole esiste anche in inglese;
cock, come gallo, cock, come cazzo. Lascio a voi il dilettevole piacere di scoprire che viene fuori
traducendo hitch e cock…). E’ la morte di quella parte “malata” che Norman rifiuta di se stesso,
quasi fosse un omosessuale non dichiarato. Egli deve uccidere la sua parte virile e per farlo deve
uccidere la madre-donna, quel femminile che fatalmente ricorda alla dissociata mente di Norman
che lui è inevitabilmente un uomo.
Il vertiginoso sguardo di Hitchcock (l’acqua che mulinella nella doccia, le scale del campanile
in “Vertigo”) è dunque l’affermazione del processo di identificazione attraverso quello spostamento
dello sguardo che trasforma l’osservatore in osservato. Chi guarda, poi, è a sua volta guardato; un
concetto estremamente impressionista.
Questo shift eye – spostamento dello sguardo – è quello che qui chiameremo impropriamente la
soggettiva stilistica, perché ci rivela lo stato d’animo di Hitchcock (lo stato d’animo con cui
dobbiamo identificarci). Chiameremo dunque scena oggettiva la visione non filtrata da Hitchcock
e, invece, scena soggetiva stilistica (sogg.stil.) la scena vista attraverso lo sguardo interiore di
Hitchcock. Restano invariate le tassonomiche forme di inquadratura oggettiva, cioè la MdP che
assiste come un testimone fantasma senza mediare la realtà, e inquadratura soggettiva, cioè la MdP
che si sostituisce agli occhi del personaggio.
PSYCHO
(1960)
Regia Alfred Hitchcock
sceneggiatura di Joseph Stefano
direttore della fotografia John L. Russell
SCENA 1
sogg.stil.
Estate, giorno, primo pomeriggio, nell’ora più calda. Contrasto netto con l’atmosfera generale che si
respirerà durante tutto il film.
Appena entra nella stanza, lo sguardo di Hitchcock si posa su una coppia: Marion e Sam (John
Gavin). E’ evidente che sono due amanti e che da poco hanno fatto l’amore. Sam è tagliato
nell’inquadratura e non ne vediamo la testa. Appena Sam e Marion si sdraiano sul letto e
amoreggiano la Mdp avanza con decisione e si avvicina ai due. Eccitazione e maggior desiderio ci
portano a voler guardare da più vicino. È lo sguardo del voyeur che quasi vorrebbe toccare i due
che si baciano. Lei è in sottoveste e reggiseno bianchi (di nuovo il contrasto simbolico luce/buio
giorno/notte).
Lei si guarda allo specchio ma noi non la vediamo mai riflessa. Il personaggio di Marion lo
conosciamo da pochissimo; non sappiamo niente di lei. Non ci è ancora concesso conoscere il
sapere infradiegetico. Il suo conflitto è appena all’inizio, è a livello inconscio. Guardarsi allo
specchio significa mettersi in discussione con se stessi. Lo spettatore ancora non deve arrivare a
questa conclusione. E d’altronde neanche ad Hitchcock per adesso interessa.
Curiosità: ad un certo punto lui le dice che se si sposano lei dovrà leccare i francobolli nel
retrobottega. Non vedeva molto bene il matrimonio Hitchcock; d’altronde la stessa cosa la fa non
dire, ma fare a Joan Fontaine in “Rebecca”.
In questa scena ci sono in tutto 19 inq. e come teorizza Syd Field, che una sceneggiatura va divisa
in 3 atti, e ogni atto a sua volta diviso in 3 parti, questa scena, come del resto tutte le scene,
rispecchia visivamente questo modulo di costruzione narrativa; la prima parte lenta, di
presentazione; la seconda parte molto più veloce, serrata nel montaggio. Qui il discorso è più
ampio. Sam e Marion, amanti clandestini, consumano il loro rapporto fuori dai dettami sociali
(leggi matrimonio); la terza parte inizia lenta per concludersi in velocità quando Marion esce di
campo: il dovere la richiama alle convenzioni sociali.
SCENA 2
oggettiva
Marion arriva in ufficio (Hitchcock è fuori sul marciapiede con un cappellone texano in testa).
Arriva il milionario. Dialogo fra lui e Marion. Normale campo/controcampo. L’unico marcatore
della diegesi sono i 40.000 dollari (che serviranno solo come red herring). Il principale vuole che
lei li porti in banca. Sono una tentazione e l’occasione fa l’uomo (la donna) ladro(a).
SCENA 3
oggettiva
Marion entra nell’ufficio del principale. Gli dà i documenti e gli dice che ha mal di testa e vuole
andare a casa. Delle semplici aspirine non fanno andare via l’infelicità. Come i soldi del resto.
Nessun punto di vista particolare.
SCENA 4
sogg.stil.
Camera da letto di Marion. Sta preparando la valigia. Un marcatore evidentissimo. Lei è in
sottoveste e reggiseno. Questa volta, però, sono neri (ci viene in mente la Joan Crawford di “Johnny
Guitar” di N. Ray).
Hitchcock immediatamente ci conduce sott’acqua, ci fa scendere nell’io nascosto e buio,
nell’inconscio. Il film si sta spostando nell’(o)scuro. La MdP si avvicina ai soldi sul letto. La
focalizzazione sul denaro: significante polivalente del desiderio (sessuale e sociale) che serve per
aggirare il frammento di realtà che l’Io non accetta, per negarlo e ricostruirlo con le pulsioni
dell’Es. La MdP poi si sposta sulla valigia aperta che Marion sta preparando. Di nuovo lo sguardo
voyeristico di Hitchcock e, dunque, di noi spettatori. Vediamo per la prima in questa scena volta
l’immagine di Marion allo specchio. La dissociazione, lo sdoppiamento della personalità di Marion
è in atto; l’ego contro l’es, il conscio contro l’inconscio. Marion esce dalla camera. Il conflitto è
ufficialmente iniziato.
SCENA 5
sogg.stil.
Marion è in macchina. Visamente niente di particolare. Ma c’è un’interpellazione indiretta.
Sentiamo i suoi pensieri. Il mare dell’inconscio è sempre più agitato. La lotta es-ego si sta facendo
più dura. Improvvisamente c’è uno scarto; Hitchcock devia, la musica in tal senso ci porta ad aprire
gli occhi, mentre prima gurdavamo ad occhi chiusi (perché Marion è assorta nei suoi pensieri e per
noi spettatori sul suo primo piano non c'è niente da vedere, ma solo da ascoltare i suoi pensieri).
Marion vede il suo principale attraversare la strada. È la prima soggettiva del film: lo spettatore
vede con gli occhi di lei. Hitchcock ci ha condotto per mano dentro di lei. D’ora in poi vedremo il
mondo con gli occhi di lei, nel senso che il nostro stato d’animo è stato messo in contatto diretto
con il mondo interno di Marion. E ora che succederà? Si chiede Marion e ci chiediamo noi insieme
a lei (ricordiamoci però che tutto questo è una red herring. Come il Mac Guffin sono tutte mosse
diversive che distolgono l’attenzione dello spettatore da quella che sarà l’azione principale. Sono un
mazzo di chiavi false (come ben architettato in “Notorius”, nella sequenza del ricevimento quando
la MdP dall’alto carrella verso il basso fino a finire in dettaglio sulla mano di Elena che stringe la
chiave della cantina. Il Mac Guffin o la red herring sono «estremamente importanti per i personaggi
del film, ma di nessun interesse per me, il narratore»; da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit.).
Hitchcock ci sta portando volutamente fuori strada, perché a lui interessa un’altra storia e sta
preparando il terreno a quella sostituzione di personaggio, a quello shift eye che ci porterà a
spostarci da Marion a Norman, lo spostamento dello sguardo che denuncia la reversibilità, lo
sdoppiamento e il raddoppio dell’identità, facendo scivolare un racconto nell’altro; la rapina che
diventa assassinio, la nevrosi che diventa psicosi.
SCENA 6
sogg.stil.
Il film si sta avviando al crepuscolo. Come dice Raymond Bellour, entriamo nell’ “oscuro”, ci
caliamo nelle tenebre del nostro “io”, ci aggiriamo nei meandri dell’inconscio. Lei è in macchina.
Capiamo che sta scappando. Si sta facendo notte. Piove. Il commento musicale di B. Hermann è
memorabile. Questo primo viaggio sotto la superficie dura poco.
Stacco
SCENA 7
oggettiva
Esterno giorno. Una strada fuori città. Hitchcock ci fa respirare. La scena precedente è stata il primo
tuffo in apnea. Non dobbiamo stare troppo sott’acqua. Non siamo ancora pronti. L’inizio scena è
luminoso, idilliaco quasi, con quei fiori mossi dal vento. Non c’è dubbio però: l’esperienza
precedente ci ha segnati. Marion si è addormenta in auto sul ciglio della strada. Infatti, Marion
appena si sveglia ha l’istinto di scappare, tanto più che vede un poliziotto. Poliziotto che ci richiama
alla realtà, che funge da Super-Io dal quale non possiamo sfuggire. Il poliziotto si avvicina all’auto
e chiede se va tutto bene. Marion impaurita risponde frettolosamente. Mette in moto e va via.
SCENA 8
oggettiva – sogg.stil.
Automobile di Marion. Marion fugge senza meta. In una sorta di capovolgimento narrativo, il
poliziotto per assurdo è l’inconscio che ci segue e Marion controlla nello specchietto (di nuovo le
soggettive) se è seguita dalle sue colpe. Poi, però, il poliziotto cambia strada. Tregua del conflitto.
Dissolvenza e un po’ di respiro.
SCENA 9
oggettiva – sogg.stil.
Esterno giorno. In una qualunque cittadina. Lei compra il giornale. Di nuovo i sensi di colpa.
Controlla che sul giornale non ci sia qualche notizia che la riguardi, quel giornale che più avanti
tornerà utile nel racconto. Ora non c’è la notizia, ma poi ci saranno il soldi, che, su quel giornale,
stamperanno metaforicamente la colpa.
Il poliziotto è dall’altra parte della strada. Per adesso lo sappiamo solo noi, è extradiegetico,
(focalizzazione esterna). Marion non se ne è accorta. Marion è in un auto mercato all’aperto. Vuole
cambiare al sua automobile. Il venditore d’auto le dice: “Potete fare tutto quello che vi pare…e,
essendo donna, lo farete” (Hitchcock docet).
La scena diventa da oggettiva a soggettiva stilistica quando Marion vede il poliziotto. Qui il
racconto cinematografico segna un punto di demarcazione. C’è la prima soggettiva di Marion in
movimento. Il carrello indietro sul poliziotto mentre Marion va al bagno. La tensione sale, il
conflitto emerge sempre di più; l’inconscio sta approfittando della debolezza del conscio e vuole
venire a galla.
SCENA 10
sogg.stil.
Lei è nel bagno dell’auto mercato. L’inq. è dall’alto. Il destino impietoso la schiaccia. Di nuovo una
soggettiva di Marion che conta i soldi. Vuole pagare in contanti l’auto che ha scelto.
SCENA 11
oggettiva
Nell’auto mercato arriva il poliziotto. Marion esce dall’ufficio del venditore e si avvia verso la
nuova macchina. Ha fretta. Di nuovo sente il respiro delle colpe sul collo. Marion va via. Si ferma
perché il meccanico le dà la valigia che aveva lasciato nella vecchia auto. L’atuomobile esce di
campo. Dissolvenza
SCENA 12
sogg.stil.
Marion nell’automobile. Di nuovo un’interpellazione esterna. Vediamo Marion oggettivamente ma
la sentiamo soggettivamente. Off sentiamo di nuovo i pensieri che le affollano la mente. Di nuovo
comincia la discesa agli “inferi”.
SCENA 13
sogg.stil.
È sera. Buio, letteralmente. E quei fari delle auto contromano che ci abbagliano, non sono che una
luce che impedisce, per paradosso, di vedere meglio. Oltre a sentire i suoi sensi di colpa, le sue
paure, quelli che sentiamo e che sembrano essere i suoi pensieri sono, invece, un sapere
extradiegetico. O meglio: non sono quello che lei pensa, anche se chiaramente la sua mente è in
attività, ma noi spettatori stiamo sentendo quello che i personaggi si diranno lunedì quando Marion
non andrà a lavoro. La sequenza è costruita in maniera tale che ad ogni stacco sulla strada - la
soggettiva di Marion dal parabrezza - corrisponde poi un attacco su di lei sempre più vicino (il
close up è sempre più stretto) in un ritmo di montaggio sempre più serrato. Man mano che le voci
off. diventano più insistenti, Hitchcock si avvicina sempre di più al suo volto, fino ad arrivare ad un
P.P.P. La demarcazione segmentale della scena si chiude con un effetto, un deus ex machina, che
porterà Marion al motel di Norman: la pioggia.
SCENA 14
oggettiva – sogg.stil.
Reception del motel. Interno notte. Marion non trova nessuno nel motel. Guarda la casa dietro il
motel. Nella soggettiva del suo punto di vista, vediamo la casa e vediamo alla finestra una figura
femminile. Arriva Norman Beates (Anthony Perkins).
SCENA 15
oggettiva – sogg.stil.
Siamo nell’ufficio del motel. Il bancone separa nettamente le due figure. Di nuovo vediamo Marion
riflessa nello specchio. Il dialogo Marion-Norman si svolge in campo/controcampo: lei dal basso,
lui dall’alto. In verità Hitchcock qui è volontariamente scorretto. Infatti, essendo Marion più bassa
di Norman, noi dovremmo vedere Norman inquadrato dal basso e Marion dall’alto. Ma Hitchcock
capovolge la grammatica del punto di vista; di nuovo ci sta dicendo qualcosa. Ci sta dicendo che è
iniziato lo scarto del primo personaggio a favore del secondo. Marion si firma con un nome e
provenienza falsi. Soggettiva. Norman prende le chiavi della stanza 1. Qui siamo in pseudosoggettiva
per due motivi: 1) per presentarci Norman. Lo abbiamo visto per la prima volta da pochi
minuti e non sappiamo ancora niente sul suo conto. È troppo presto per vedere il mondo con i suoi
occhi; dunque nessuna soggettiva di Norman. Quel suo gesto esistante nel prendere le chiavi
qualcosa, però, ci dovrà pur dire; 2) Hitchcock ci permette di notare un dettaglio. Che la zona
occupata dalle chiavi 1 e 2 sul portachiavi è scrostata, mentre quello delle altre è intatto. È evidente
che Norman affitta sempre la stanza 1 o 2. Perché? Lo scopriremo tra poco.
SCENA 16
oggettiva
Norman prende la valigia in macchina.
SCENA 17
oggettiva – sogg.stil.
Entrano nella stanza 1. Norman apre la finestra. Perché? Dice che c’è odore di umidità, ma vedremo
più avanti che lo scopo è un altro. Prima obiettiva stranezza di Norman: non riesce a dire la parola
bagno. Di nuovo vediamo Marion riflessa nello specchio. Hitchcock non smette di ricordarci che il
conflitto, il confronto/scontro es-ego è sempre in atto. Norman esce. Lei sistema i soldi. Dove? Nel
giornale (ecco che raccoglie la semina). C’è la soggettiva di Marion che sistema il giornale sul
comò. Dalla finestra Marion sente Norman discutere con una donna: è la madre. Non vuole che il
figlio affitti la stanza ad una donna. Ecco perché Norman aveva aperto la finestra. Noi, insieme a
Marion, capiamo qualcosa in più di Norman. Sua madre è strana, bizzarra, quanto meno e,
conseguentemente, il rapporto di Norman con la madre è strano. Un’altra pennellata al ritratto
psicologico di Norman. La soggettiva di Marion che guarda la casa e, poi, Norman che esce di casa
con il vassoio per la cena. Norman entra nella stanza. E’ in imbarazzo: spiega che la madre non era
in sé. Sul vassoio il latte (Hitchcock è fissato con il latte, quello stesso latte de “Il sospetto” che
credevamo avvelenato – e quello stesso latte che troviamo anche ne “Il progioniero di Amsterdam”
che beve il vecchio corrispondente perché è a dieta), quel bianco latte che è presagio di morte,
perché il latte è contravveleno e se c’è il latte, allora, da qualche parte c’è anche il veleno.
Norman non vuole accettare l’invito di Marion di cenare nella stanza. È meglio andare in ufficio. È
la scena più lunga dall’inizio. Ed è chiaro, perché è la scena del loro incontro, è la scena che
sancisce il passaggio del testimone da Marion a Norman. È la scena che fa scivolare il primo
racconto (la red herring, la nevrosi diciamo noi) nel secondo racconto (la psicosi). Il soggetto
nevrotico diventa l’oggetto dello psicotico.
SCENA 18
sogg.stil.
È la scena chiave. Hitchcock mette in atto il processo di identificazione, quel transfert di identità
che rende uguali Marion e Norman e che porterà Norman ad assumere il ruolo di protagonista
(Hitchcock era affascinato dall’idea di far morire la star dopo solo 1/3 di film).
Vediamo nel dettaglio.
Entrano nel salottino. Marion guarda gli uccelli impagliati. Soggettiva sul gufo e sul corvo. Uccelli
notturni, uccelli della notte. Quegli stessi uccelli che nel film successivo a Psycho si ribelleranno
alla innaturale natura dell’uomo. Quando Norman parla del suo hobby, ci tiene a dire la tassidermia,
noi vediamo pochissimo Marion. Hitchcock è concentrato su Norman. Il suo sguardo stilistico è
tutto rivolto verso questo strano personaggio. Infatti nel gioco campo/controcampo le inquadrature
non sono corrispondenti e non sono girate con la stessa ottica. Marion è inqudrata dal basso in p.a. e
siamo abbastanza distanti da lei. Norman, invece, è sì inquadrato dal basso, ma siamo in mezza
figura molto più vicini. E, poi, inconfondibili segni connotativi, in alto nell’inquadratura
campeggiano a sinistra il gufo e a destra il corvo e Norman è collocato al centro fra i due uccelli
impagliati, quasi fosse il re della notte (dell’oscuro, dell’insondabile inconscio) con i suoi due fidi
scudieri. Hitchcock, con questa inq., infatti, esce allo scoperto. Il suo racconto, il suo sguardo, e,
dunque, il nostro di spettatori, è voyeuristicamente attratto da Norman.
Norman dice: “Il miglior amico è la propria madre”. Nettissimo segno connotativo; Norman è
decisamente strano. Questa è reversibilità. Se la madre non vuole che nessuna donna si avvicini al
figlio, perché solo lei è in grado di farlo entrare nel simbolico, anche il figlio, così assoggettato, può
provare nei confronti della madre un ossessivo desiderio di possessione. Nessun uomo può avere
sua madre (complesso di Edipo) e se qualcuno le si avvicina ecco che la nevrosi diventa psicosi; il
figlio può anche uccidere per impedire che un uomo possieda sua madre. Ed ecco Norman; la madre
è libera di concedersi ad un amante, mentre impedisce al figlio (la morbosa possessione) qualsiasi
rapporto con una donna. Norman non tollera, però, che la madre abbia un altro uomo all’infuori di
lui e così ucciderà sia l’uomo/amante ma, in un eccesso di psicosi, la madre, perché lo ha tradito
con un altro uomo. E, in un vertiginoso meccanismo di andata e ritorno, la madre si prenderà la sua
rivincita; Norman/Madre ucciderà tutte le donne che si avvicinano al figlio. È da notare in tutto ciò
come nei film di Hitchcock sia perennemente assente la figura paterna. Con una madre/moglie
siffatta accanto si è negato (o è scappato o è morto) e se ci fosse stato non sarebbe potuta essere
presente la figura materna. Non solo; senza la madre il figlio non avrebbe dovuto lottare con il
padre per emergere e per entrare nel simbolico, ma si sarebbe soltanto dovuto avvicendare in un
mondo già fatto. La madre, se le cose andassero così, non avrebbe nemmeno quel ruolo
destabilizzante che minaccia l’uomo nel suo processo di succesione da padre a figlio. Avendo,
invece, “educato” lei il proprio figlio, quel figlio entrerà nel simbolico come creatura materna e chi
prenderà il posto d’autorità nella società patriarcale sarà proprio la donna per interposto figlio.
Ma torniamo a Psycho. Il dialogo nel salottino fra Marion e Norman li pone sullo stesso piano.
Marion e Norman sono uguali; tutti e due hanno una vita vuota, sono senza identità, tutti e due sono
infelici. Sono speculari. L’uno si identifica nell’altra e viceversa. È uno sdoppiamento, ma anche un
raddoppiamento. Norman è lucido. È, potremmo dire, dissociato. Sta parlando di sé e la cosa, quasi,
non lo riguarda, freddo e distaccato come appare (sdoppiamento). Ma rafforza l’idea di sé
(raddoppiamento) dicendo che ognuno di noi “è stretto nella propria trappola”. È il
confronto/scontro fra due figure mitiche: la donna e l’uomo. Due figure legate da un doppio
vincolo. L’uomo che usa la donna per affermare il suo potere e la donna che pur di affermarsi
accetta questo ruolo di farsi amare-usare, immolandosi, proponendo un’immagine di sé che non sarà
mai la sua vera identità. Il sacrificio della donna serve all’uomo per affermare il proprio status quo.
Norman ci parla della madre che si è risposata dopo la morte del padre. Norman è Edipo che si è
accecato dopo aver scoperto le proprie colpe (“un figlio non si può sostituire ad un amante”).
Ed ecco, poi, un altro confronto /scontro: la madre e la donna. In Norman il confronto /scontro ha
sortito un effetto devastante, perché le due figure erano incarnate dalla stessa persona. Marion,
infatti, dice se non ha mai pensato di metterla in qualche posto, di farla curare. A questo punto c’è
uno scarto visivo nel racconto. Hitchcock sterza decisamente verso Norman. Ora Norman è in p.p.
Siamo quasi addosso a lui. Hitchcock ci mette in contatto con lo stato d’animo di Norman. Marion
si è spaventata per come ha reagito Norman alle sue parole ed anche Marion è inquadrata in p.p.
Norman, parlando della madre dice:
“Lei è innocua come uno di quegli uccelli impagliati”. Scopriremo, poi, che, effettivamente, è
proprio così. La MdP è fissa sul p.p di Norman. Non si muove mai. Noi siamo sempre lì ad
ascoltarlo, catturati da quello che sta dicendo. E infatti, non è la MdP che si allontana da lui, ma,
quando Norman si accorger di essere stato aggressivo, va indietro con il busto, è lui che si allontana
dalla MdP (da noi) e da Marion. E’ chiaro che Norman vive anche lui un conflitto di personalità. Le
parole di Norman sortiscono in Marion l’effetto del pentimento; rivelazione, turning point. “Perdere
al testa una sola volta può bastare”. Marion sta annunciando la sua uscita di scena. E Hitchcock la
farà uscire di scena con una sequenza memorabile. Marion si alza. Vuole andare. Dice (ci dice) che
è pentita di quello che ha fatto. “Domani devo tornare a Phoenix (non a Los Angeles, allora, come
aveva detto a Norman). Sono andata a ficcarmi in una brutta trappola. Devo tornare laggiù per
vedere se trovo il modo di uscirne prima che sia troppo tardi”. Ma in realtà non può nemmeno
immaginare in che trappola si è andata a ficcare. E che veramente ormai è troppo tardi. Di lì a poco
Norman/Madre la ucciderà.
Norman prima di congedarla vuole come avere una conferma del fatto che sono uguali, che anche
lei è senza identità come lui. Infatti le dice: “Buonanotte Miss…” “Crane”, risponde Marion
rivelando il suo vero cognome (crane in inglese vuol dire gru, un uccello appunto).
SCENA 19
sogg.stil.
È la scena che celebra il nuovo protagonista. L’asse del racconto si è decisamente spostato su
Norman. Norman guarda il registro delle firme. Scopriamo, attraverso la soggettiva, la falsa identità
di Marion quando si è firmata. Ed ecco che si rivela in tutta la sua stranezza il nuovo protagonista.
Anche lui, non come Marion, ma come Hitchcock (e per traslato, come tutti noi) è un voyeur.
Marion è solo la vittima dello “sguardo”. Norman stacca un quadro dal muro del salottino. Lì c’è un
buco fatto apposta per spiare nella stanza accanto, la stanza 1. Ed ecco spiegato il motivo che la
stanza 1 è la più affittata. Norman guarda Marion spogliarsi. Il soggetto della nevrosi femminile –
Marion – è diventato l’oggetto della psicosi maschile – Norman –. Quel tic di Norman quando il
suo occhio è inquadrato in dettaglio ci rivela che Marion è nuda. A noi non ci è permesso vedere
quello che Norman vede – lo sguardo impressionista - ma, forse. ancora con più efficacia e forza,
proprio nel non vedere ci arriva totalmente quello che Norman sta provando. Perché se noi
spettatori avessimo visto Marion nuda ci saremmo eccitati noi e nessuno di noi spettatori avrebbe
provato quel che sta provando Norman. L’avremmo potuto solo immaginare. Invece, nel non vedere
Marion, ma vedendo Norman che la guarda, siamo perfettamente al corrente di quello che lui sta
provando e possiamo (anzi, dobbiamo) solo immaginare come è Marion nuda. Norman mette a
posto il quadro. Ha uno scatto. Si rivolge fisicamente verso la casa. Quella donna nuda lo fa andare
dritto verso la madre. Perché? Per Norman UNA donna nuda è LA donna, e La Donna è sua Madre.
La madre, dunque, nella paranoia regressiva di Norman, è la figura topica del sesso femminile.
Norman esce dall’ufficio e si dirige verso la casa.
SCENA 20
oggettiva
Vediamo la casa di Norman da dentro. Lui entra. Sta per andare di sopra, ma ci ripensa. Va in
cucina e si siede. Guarda idelamente verso Marion, la quale…Stacco
SCENA 21
sogg.stil.
Marion è seduta. Di nuovo Hitchcock mette in atto il processo di identificazione. Scenicamente ci
rende uguali Norman e Marion: tutte e due seduti alle prese con le loro colpe. Soggettiva sui conti
che Marion sta facendo. Poi strappa i fogli e li getta nel water. Si toglie la vestaglia. Ora è nuda (in
tutti i sensi, letteralmente e metaforicamente). Si fa la doccia. Cerca di togliersi di dosso lo sporco,
la colpa. E per lei quell’acqua è una liberazione. Marion gode, letteralmente. L’insistenza di
Hitchcock va oltre la necessità diegetica. Qui si compie in pieno il suo sguardo stilistico. Se prima
della doccia la MdP era oggettiva, cioè si teneva a debita distanza dall’enunciazione, cioè da ciò che
riprende, ora, appena Marion tira la tenda, la MdP diventa soggettiva stilistica e il suo sguardo è
l’enunciato, la MdP stessa diventa filmico. I piani ravvicinati, il corpo nudo di Marion, il dettaglio
dell’acqua che zampilla a cui lei si concede totalmente, sorridendo e aprendo la bocca sono il
godimento che Marion non ha manifestato nella scena d’amore iniziale. La MdP senza pudore e
senza pietà ci mostra una donna priva di ogni difesa, nuda sotto la doccia. Ma qui non c’è esibizione
narcisistica; Marion non sta godendo per se stessa. Lo sguardo da voyeuristico è diventato
scopofilo, perché rappresenta il godimento maschile che si realizza in quel luogo mitico che è il
corpo della donna. La MdP si impossessa dello sguardo della donna per effetto di una pulsione
immaginaria. Si determina fra l’uomo e la donna un rapporto di specularità e di doppio. L’uomo è
talmente suggestionato dal proprio desiderio di possedere la donna che crede che sia la donna stessa
a mandargli questo messaggio, quasi che lei voglia essere posseduta. La possessione, come
manifestazione perversa, si attua con la distruzione di quell’immagine. E l’uomo, per
appropriarsene, sentendo la donna come minaccia di castrazione e dunque come minaccia del suo
status quo, del suo potere sociale, non può far altro che distruggerla (ucciderla) per ricostruirla a
proprio piacimento, per addomesticarla. Di qui la metafora dell’imbalsamazione. Questa
trasformazione, dalla nevrosi alla psicosi, si effettua tramite la donna che ne è il supporto, la forma
indispensabile.
Da quando Marion tira la tenda fino a quando il sangue scorre nello scarico della vasca ci son ben
49 inq. per neanche due minuti di film (questo è anche uno dei motivi per cui Hitchcock ha girato in
B/N; sarebbe stato troppo d’impatto il rosso del sangue che scorre nel bianco della vasca e il colore
avrebbe creato un effetto straniante che avrebbe distorto il racconto rendendolo iper reale. Il B/N
restituisce un look verosimile (curiosità: singolare l’inq. soggettiva sullo zampillo d’acqua:
l’obiettivo non si bagna. Che abbia ripreso uno specchio?).
L’ottava inq. di questa sequenza è sbilanciata. Marion in basso a destra e molta aria in alto. Ma ecco
che quello spazio vuoto si riempie: vediamo la porta del bagno aprirsi. Un’ombra si avvicina e la
MdP anche si avvicina. Va incontro all’assassino per arrivare puntuale all’appuntamento con il
delitto: l’assassino tira la tenda e noi siamo lì faccia a faccia con lui. Ma non capiamo bene: chi è? È
un uomo? Una donna? Non facciamo in tempo a decodificare perché il coltello vibra alto per dare
inizio alla memorabile sequenza della doccia con tutta la sua fascinazione e perversione.
Fotograficamente è la scena più luminosa del film; narrativamente, è chiaro, è la scena più buia.
Una serrata sequenza di inquadrature, montando sincopaticamente stretto/largo, che si concludono
sullo scarico della vasca (gli archi di Bernard Herrmann strillano e urlano alti e poi giù bassi
nell’oltretomba…è un coito/stupro vissuto da poco prima dell’orgasmo fina all’ultima violenta
penetrazione). Da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit.: “Naturalmente il coltello non tocca mai
il corpo, tutto è fatto con il montaggio. Non si vede mai una parte tabù del corpo della donna,
perché riprendevamo alcune inquadrature al rallentatore per evitare di avere i seni nell’immagine.
Le inquadrature riprese al rallentatore non sono poi state accelerate perché il loro inserimento nel
montaggio – durano pochissimi secondi, ndr – dà un’impressione di velocità normale”).
Dissolvenza e
SCENA 22
sogg.stil.
Dallo scarico della vasca la dissolvenza ci porta in dettaglio sull’occhio spalancato, vitreo di Marion
morta. Un movimento rotario per riprendere il vortice del sangue che si perdeva nella vasca e la
MdP diventa assoluta protagonista di questa scena. Come all’inizio, chi è adesso che si aggira per la
stanza? Lo sguardo stilistico di Hitchcock diventa enunciazione, l’espressione diventa contenuto. Il
pro-filmico diventa filmico. Siamo di nuovo noi spettatori i protagonisti di questa scena, è la nostra
smodata curiosità voyeuristica che ci fa rallentare in autostrada per vedere che cosa è successo se
c’è un incidente. Così adesso la MdP sospende per un attimo la narrazione diegetica. Ci aggiriamo
per la stanza fino ad arrivare sul giornale poggiato sul comò. Breve attimo di silenzio e riprende il
racconto diegetico vero e proprio. Sentiamo gridare off (dalla sceneggiatura originale, pag. 52
“MOTHER!…Oh God, what…BLOOD, blood…MOTHER!”) e la Mdp muove verso la finestra per
farci vedere la casa da dove provengono le grida di Norman.
SCENA 23
oggettiva.
Torniamo alla “realtà” del racconto. Norman arriva nella stanza. Vede il cadavere di Marion lì nel
bagno. Si spaventa e si tappa la bocca con una mano. Nell’emotività del gesto fa cadere un quadro
dalla parete: un uccello (!). La prima cosa che fa, poi, è chiudere la finestra. Ma nessun uccello
volerà via, ormai (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: «…quando Melanie – “Gli uccelli”,
ndr - si rifugia in una cabina telefonica a vetri, la mia intenzione è di mostrare che è come un
uccello in gabbia…si assiste al rovesciamento del vecchio conflitto fra gli uomini e gli uccelli e
questa volta gli uccelli sono fuori e l’umano è in gabbia».
SCENA 24
oggettiva
È la scena della pulizia. Norman mette a posto le cose. In questa scena non c’è nemmeno una
soggettiva. Eppure le cose che si potrebbero vedere con gli occhi di Norman sono tante. Ma
Hitchcock non vuole farcele vedere. D’altronde è giusto che sia così. Norman è dissociato. In
questo momento sta agendo freddamente. La sua reazione è lucida e determinata, quasi non lo
riguardasse ciò che sta facendo. E, dunque, non deve riguardare noi.
SCENA 25
oggettiva
Norman mette il cadavere di Marion nel portabagagli dell’auto con tutte le sue cose. Compreso il
giornale con i soldi.
SCENA 26
oggettiva
La macchina che cola a picco nella palude. Norman in piedi ad osservare. Lui e noi semplici
spettatori di questa scena. Il racconto è definitivamente colato a picco nel torbido, nel profondo
delle acque melmose, nel buio.
FINE I ATTO.
SCENA 27
oggettiva
Il bianco di una lettera. Siamo in soggettiva. È Sam che sta scrivendo a Marion. Siamo nel
retrobottega del suo negozio di ferramenta. La MdP arretra. Il carrello indietro si allontana da Sam
fino ad arrivare all’entrata del negozio. Il movimento di macchina, è evidente, sta a significare che
dobbiamo uscire dalla palude, quasi che la MdP ci stesse tirando su da quelle profondità dove
eravamo andati a finire. Il racconto visivamente deve darci una tregua. L’emozione fin qui è stata
troppo forte. Dobbiamo riprendere un po’ di fiato. Torniamo in superficie.
Off sentiamo la voce di una cliente. Nenache a farlo apposta però si parla di morte. La cliente sta
commentando gli effetti di un insetticida. Secondo la signora insetto o uomo che sia la morte
dovrebbe sempre essere indolore. Stacco. Nel negozio entra Lila, la sorella di Marion. Poche battute
con Sam e Hitchcock ci mostra un uomo alla porta che osserva i due. Hitchcock non si fa sfuggire
l’occasione. Il suo sguardo entra decisamente in gioco. L’uomo entra nel negozio accompagnato in
p.p. dalla MdP che arretra (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: Truffaut, dice: «La sua
tecnica è completamente subordinata all’efficacia drammatica, è in qualche modo una tecnica
d’accompagnamento dei personaggi.» A. Hitchcock «Proprio così. […] Nella maggior parte dei
film si ha questa successione: p.p dell’uno, p.p. dell’altro, p.p. dell’uno, p.p. dell’altro, p.p. dell’uno,
p.p. dell’altro e, tutt’a un tratto un campo totale per permettere a uno dei due personaggi di alzarsi.
Trovo che sia sbagliato fare così». F Truffaut «Lo credo anch’io perché in questo caso la tecnica
precede l’azione invece di accompagnarla e il pubblico riesce a capire che uno dei due personaggi
sta per alzarsi…In altri termini, non bisogna mai spostare la MdP pensando di favorire la
realizzazione di quello che sta per succedere…» A. Hitchcock «Esatto, perché allenta l’emozione
[…]. Se un personaggio si muove e si vuole conservare l’emozione sul suo volto, bisogna far
viaggiare il primo piano»). L’uomo che entra nel negozio guarda addirittura in MdP. È Arbogast
(Martin Balsam), l’investigatore. Farà una brutta fine? L’interpellazione non ci dice niente di buono
sul suo futuro. E poi è un tipo troppo sospettoso. Dubita di Lila e dubita, soprattutto, di Sam.
SCENA 28
oggettiva
Serie di inquadrature in dissolvenza che ci mostrano Arbogast che fa domande in giro.
SCENA 29
oggettiva–sogg.stil.
Arbogast arriva al motel di Norman. Questa è la scena del secondo atto che fa esordire il nuovo
protagonista: Norman. L’inizio è tranquillo, luminoso. I due entrano nell’ufficio. Arbogast fa
domande. È iniziata l’inchiesta, modello classico del sistema Hitchcockiano, che si eprime in due
forme reversibili e complementari. Una forma prevede che il protagonista, costretto dalla
drammatizzazione degli eventi, scopre una certa verità del suo desiderio. L’altra, invece, nega al
protagonista l’accesso alla verità dell’inchiesta.
Pian piano l’atmosfera cambia. Illuminazione e linguaggio cinematografico contribuiscono a
trasformare la diegesi. Sembra un interno notte ad un certo punto. Di nuovo precipitiamo
nell’oscuro. D’improvviso l’alternanza campo/controcampo è rotta dall’irruzione di un p.p. su
Norman che si china a guardare il registro (“bisogna soprattutto evitare che la MdP divenga
improvvisamente distante e obiettiva, altrimenti si distrugge l’emozione che è stata creata”; “Il
cinema secondo Hitchcock”, op. cit). Il p.p. è ripreso con una angolazione che distorce il volto di
Norman. È lo scarto visivo, il demarcatore segmentale che ci fa precipitare anche a noi spettatori
dentro l’agitato stato d’animo di Norman, un Norman che ha paura e che fa paura.
Il bancone separa nettamente i due, come separava Marion da Norman. Non bisogna superare quel
confine però, perché quel banco segna il confine tra la vita e la morte. Di qua i vivi, di là gli uccelli
impagliati. Ma proprio Norman è da quella parte. Allora, anche lui è un uccello impagliato. Sì.
Anzi, no. O meglio: una parte di lui è impagliata e chiaramente lo scopriremo alla fine. Le domande
di Arbogast mettono in difficoltà Norman. Arbogast ha scoperto che Marion è stata in quel motel.
Vorrebbe parlare con la madre di Norman. Le domande di Arbogast diventano più incalzanti.
“Avete passato la notte insieme?”, chiede Arbogast. Questa domanda sortisce il primo effetto
dell’inchiesta. Norman, scoperto, scopre la verità di un suo desiderio. In fondo, lui Marion l’ha
desiderata (come ha desiderato sua madre, la quale lo ha tradito con un altro uomo e per questo
Norman l’ha uccisa). Norman si irrigidisce. È infastidito da tutte quello domande. Invita Arbogats
ad andarsene.
SCENA 30
oggettiva
Arbogast ad una cabina telefonica. Parla con Lila. Le dice che tra meno di un’ora sarà di ritorno.
Prima deve parlare con la madre di Norman.
SCENA 31
oggettiva
Arbogast torna al motel. Si aggira per il portico. Si accerta che non ci sia nessuno Entra nell’ufficio.
Va di là nel salotto. Ha varcato il confine; è sull’altra riva dell’Acheronte. Anche lui è “colpito”
dagli uccelli imbalsamati. Soggettive sul gufo e sul corvo. Guarda la cassaforte. Poi decide di
andare verso la casa.
SCENA 32
oggettiva–sogg.stil.
Arbogast entra nella casa. Fin qui nessun demarcatore. Decide di andare di sopra. Appena inizia a
salire le scale Hitchcock irrompe con il suo sguardo. Invece di farci vedere il volto di Arbogast,
shift eye e ci mostra la scala dal basso e i piedi che iniziano a salire i gradini. Poi il campo totale
dall’alto (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: “C’era un’inquadratura della mano che scorre
sul corrimano e una carrellata attraverso la ringhiera della scala che fa vedere i piedi di Arbogast di
fianco.. Quando ho visto i giornalieri della scena, mi sono accorto che non andava bene. […].
Queste inquadrature sarebbero state adatte se si fosse trattato di un assassino che saliva la scala.
[…] Quindi, mi sono servito di una sola ripresa di Arbogast che sale la scala e, quando sta per
arrivare all’ultimo scalino, ho deliberatamente messo la MdP in alto per due ragioni: la prima per
poter filmare la madre verticalmente perché, se l’avessi mostrata di spalle, poteva sembrare che non
avessi voluto apposta far vedere il suo volto e il pubblico non si sarebbe fidato. Dall’angolo dove mi
ero messo invece non davo l’impressione di voler evitare di far vedere la madre. La seconda e più
importante ragione per salire così in alto con la MdP era di ottenere un forte contrasto tra il campo
totale della scala e il p.p. di Arbogast quando il coltello si abbatte su di lui. Era proprio della
musica, vede, la MdP in alto con i violini e, improvvisamente, la grossa testa con gli ottoni. Si
ricordi gli sforzi che abbiamo fatto per preparare il pubblico a questa scena; abbiamo stabilito che
c’era una donna misteriosa nella casa, abbiamo stabilito che questa donna misteriosa era uscita di
casa e aveva pugnalato una giovane donna sotto la doccia. Tutto ciò che poteva dare suspense a
questa scena era contenuto in questi elementi”). Arbogast è accoltellato e cade all’indietro sulla
scala. Un urlo e fade out.
FINE II ATTO.
SCENA 33
oggettiva
Sam e Lila. Arbogast doveva tornare da più di tre ore. Sam va al motel.
SCENA 34
oggettiva
Norman osserva la palude.
SCENA 35
oggettiva
Sam torna da Lila. Di Arbogast nessuna traccia. Tutto girato in oscurità. Decidono di rivolgersi allo
sceriffo in piena notte.
SCENA 36
oggettiva
Sam e Lila sono a casa dello sceriffo. È la scena deus ex machina dell’inchiesta. Sempre nello
schema classico dell’inchiesta Hitchcockiana ci si appoggia su un terzo personaggio. Veniamo a
sapere tutto quel che si sa di Norman. La madre dieci anni fa dopo aver ucciso l’amante che viveva
con lei si suicidò. Norman li trovò morti nel letto (chiaramente lascia intendere nudi e solo così ci
possiamo spiegare il disturbo psicologico di Norman). Ma l’inchiesta non risolve l’enigma. Ci
lascia una porta aperta. Sam e Lila dicono che c’è una donna nella casa di Norman. Lo sceriffo si
chiede allora se la donna in casa di Norman è la madre chi è sepolto nel cimitero? Tutto ciò sul
p.p.p. dello sceriffo. Partecipiamo con lui al suo dubbio.
SCENA 37
sogg.stil.
Norman va a casa. Sale su in stanza. Lo sentiamo parlare con la madre. La MdP in punta di piedi
sale anch’essa fino a piazzarsi alta sul pianerottolo, là dove s’era piazzata quando la madre pugnala
Arbogast. Vediamo Norman portare in braccio la madre giù in cantina, quel luogo mitico del
sottosuolo di dostojievskiana memoria, come è sempre la cantina in “Notorius” il luogo dove si
nascondono le malefatte (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: “Ho alzato la MdP appena
Perkins incomincia a salire la scala. Entra nella stanza e non lo vediamo più; ma lo sentiamo:
«Mamma, bisogni che ti porti in cantina perché verranno qui a fare delle indagini». Poi si vede
Perkins che porta la madre in cantina. Non potevo tagliare l’inquadratura perché il pubblico sarebbe
diventato sospettoso. […]. Così ho la MdP sospesa che segue Perkins quando sale la scala, entra
nella camera ed esce di campo, ma la MdP continua a salire senza interruzione e, quando siamo
sopra la porta la MdP gira su se stessa, e guarda di nuovo giù dalla scala: perché il pubblico non si
interroghi su questo movimento, lo distraiamo facendogli sentire un litigio fra madre e figlio. Il
pubblico fa talmente attenzione al dialogo che non pensa più a quello che fa la MdP”). Il
movimento di MdP qui è una red herring. Ci fa credere che la madre sia viva, che esiste. E il
dialogo lo conferma. E, poi, è la prima volta che vediamo insieme Norman e la madre. Non
possiamo più avere dubbi.
SCENA 38
oggettiva
Tregua. Usciamo dall’oscuro, dal buio del racconto. Luce, giorno, esterno.
Sam e Lila parlano con lo sceriffo fuori da una chiesa. Il tocco qui è leggero e ironico. Sam e Lila
decidono di andare al motel da soli.
SCENA 39
oggettiva
Sam e Lila sono in macchina. Si accordano sul da farsi.
SCENA 40
oggettiva – sogg.stil.
Arrivano al motel. È la prima volta che lo vediamo di giorno. Sono nell’ufficio. Di nuovo il
bancone che separa i vivi dai morti. Prendono una camera. Sul finire della scena Hitchcock monta
velocemente una serie di p.p. di Norman e di loro due. Anche noi dobbiamo sapere che Norman
sospetta di loro e che loro sospettano di Norman. Sdoppiamento e raddoppio.
SCENA 41
oggettiva
Lila e Sam sono in camera. Decidono che fare.
SCENA 42
oggettiva
Escono di nascosto e vanno a controllare la camera 1.
SCENA 43
oggettiva
Lila e Sam sono nella camera 1. Cercano, guardano. Lila trova nel bagno un pezzetto di carta con
dei numeri. Sono le cifre che Marion aveva scritto. Si decidono: lui parlerà con Norman per
intrattenerlo mentre lei andrà nella casa per parlare con la madre.
SCENA 44
oggettiva
Da questa scena in poi, più che le singole inquadrature è il montaggio a rendere tutto suspense. Sam
e Norman nell’ufficio.
SCENA 45
sogg.stil.
Lila si avvicina con timore alla casa. Hitchcock ci mostra la soggettiva di lei mentre si avvicina. Un
movimento di carrello lento e incerto, come lo stato d’animo di Lila. Oltre a farci vedere quello che
Lila vede, il movimento di MdP ci fa sentire quello che lei sta provando. Lila entra in casa. Noi non
entriamo con lei. Ci chiude la porta in faccia.
SCENA 46
oggettiva
Norman e Sam nell’ufficio. Uno di qua e l’altro al di là del bancone.
SCENA 47
sogg.stil.
Lila è in casa. È nella stanza del piano di sopra. Si aggira per la stanza. Una serie di soggettive ci
mettono in contatto con il mondo di Norman. Sentiamo anche noi, come Lila, di esserci intromessi
nella vita di un’altra persona. Lila è attratta da un soprammobile: due mani incrociate. È solo un
escamotage per farci fare un salto sulla poltrona. Infatti Lila si spaventa; ma è solo la sua immagine
riflessa nello specchio come in un loop infinito.
SCENA 48
oggettiva
Sempre Norman e Sam nell’ufficio. Le domande di Sam sono sempre più calzanti. Sempre uno di
qua e l’altro al di là del bancone.
SCENA 49
oggettiva
Lila in casa di Norman. Vede un letto di bambino e una bamboletta. Poi si avvicina al giradischi. È
“L’eroica” di Beethoven.
SCENA 50
oggettiva
Norman capisce che le domande sono un diversivo. Chiede dove sia Lila. Nella colluttazione Sam
ha la peggio. Norman corre verso la casa.
SCENA 51
oggettiva–sogg.stil.
Lila vede arrivare Norman. Si nasconde nel sottoscala. Norman va di sopra. Lila vede la porta della
cantina. Scende. Entra in cantina. È lì nel dostojevskiano sottosuolo che si nascondono le nostre più
recondite paure e colpe. Lila vede laggiù seduta in un angolo di spalle una donna. Qui la sequenza è
sempre più spezzata dall’alternanza soggettiva/oggettiva, dall’inq. su la vecchia di spalle e sul p.p.
di Lila che si avvicina. Eccola quasi la tocca, allunga un mano la sedia si gira e…la rivelazione: è
uno scheletro. La madre di Norman è una mummia, è un “uccello” impagliato. Alle sue spalle ecco
di nuovo quella figura femminile con un coltello in mano. Sta per sferzare il colpo ma Sam alle
spalle lo blocca. Nella colluttazione Norman perde la parrucca e il vestito da donna che indossa: la
madre di Norman è Norman.
Il tragitto è completato. Il processo di identificazione è arrivato al massimo della sua
trasformazione. Marion da soggetto della nevrosi era diventata l’oggetto della psicosi. Appena
Marion muore anche Norman subisce la trasformazione. Il processo è reversibile. A Norman il
processo di sdoppiamento della personalità, la dissociazione psichica – PSYCHO – lo ha portato ad
essere da soggetto della nevrosi di una metà a oggetto della psicosi dell’altra metà, la metà
Madre/Norman che ormai ha preso il sopravvento. Norman è vittima di se stesso.
SCENA 52
oggettiva
Lo “spiegone” finale. Lo psichiatra ci dice che Norman uccise sua madre e il suo amante. La madre
aveva tradito il figlio con un altro uomo. Di qui il dicotomico desiderio di amore/morte per le donne.
SCENA 53
oggettiva–sogg.stil.
La voce off della madre sul carrello che avanza fino ad arrivare a p.p. su Norman. “Una povera
vecchia che non farebbe male ad una mosca”. E il sorriso ghigno di Norman al quale si
sovrappongono in dissolvenza i denti del teschio. Dissolvenza e vediamo la macchina ripescata
nella palude che viene issata a terra. Tutto, prima o poi, viene a galla, anche le colpe più profonde.
FINE
di Alessandro Bernabucci
Surrealismo
“Psicanalisi: Sogno vs Realtà”
Il tema del sogno e dell’inconscio
La nascita della psicologia moderna, grazie a Freud, ha fornito molte suggestioni alla produzione artistica della prima metà del Novecento. Soprattutto nei paesi dell’Europa centro settentrionale, le correnti pre-espressionistiche e espressionistiche hanno ampiamente utilizzato il concetto di inconscio per far emergere alcune delle caratteristiche più profonde dell’animo umano, di solito mascherate dall’ipocrisia della società borghese del tempo.
Sempre da Freud, i pittori, che dettero vita al Surrealismo, presero un altro elemento che diede loro la possibilità di scandagliare e far emergere l’inconscio: il sogno.
Il sogno è quella produzione psichica che ha luogo durante il sonno ed è caratterizzata da immagini, percezioni, emozioni che si svolgono in maniera irreale o illogica. O, per meglio dire, possono essere svincolate dalla normale catena logica degli eventi reali, mostrando situazioni che, in genere, nella realtà sono impossibili a verificarsi. Il primo studio sistematico sull’argomento risale al 1900, quando Freud pubblicò : «L’interpretazione dei sogni».
Secondo lo studioso il sogno è la «via regia verso la scoperta dell’inconscio». Nel sonno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi liberamente emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico. La funzione interpretativa è necessaria per capire il messaggio che proviene dall’inconscio, in termini di desideri, pulsioni o malesseri e disagi.
Il sogno propone soprattutto immagini: si svolge, quindi, secondo un linguaggio analogico. Di qui, spesso, la sua difficoltà ad essere tradotto in parole, ossia in un linguaggio logico. La produzione figurativa può, dunque, risultare più immediata per la rappresentazione diretta ed immediata del sogno. E da qui, nacque la teoria del Surrealismo.
Il surrealismo diventa una vera è propria corrente del pensiero, arte come mobilitazione concettuale,non solo visione del reale o del rappresentativo, ma visione dell'irreale. Vi scaturiscono grandi geni nel campo artistico dalla pittura, citandone qualcuno: Dalì, Magritte, Mirò..., nella scultura, nel cinema.
Quest'ultimo rappresenta, e poi sarà motivo di critica, lo svolgersi di un vero è proprio movimento che spezzerà la linearità rappresentativa del cinema classico.
Il più importante esponente del cinema surrealista è Luis Bunuel, un regista che pone allo spettatore un quesito: “L'enigma del desiderio”
Luis Buñuel
 Luis Buñuel nasce nella provincia aragonese di Teruel ricca di insetti, a Calanda, nel 1900, da Leonardo (arricchitosi in America, proprietario terriero, vicino ai temi degli intellettuali riformatori) e da Maria Portes (diciottenne di straordinaria bellezza). La sua infanzia -è il primo di sette fratelli- e parte dell'adolescenza sono turbati dall'educazione religiosa ricevuta in un collegio di gesuiti. Completa gli studi a Saragozza, nel 1917 si reca a Madrid per iscriversi alla facoltà di agraria, quando avrebbe voluto applicarsi in composizione alla Schola Cantorum. Per niente attratto dalla "soluzione di equazioni", frequenta le lezioni di entomologia e nuovamente resta deluso perché si rende conto di essere più interessato alla letteratura sugli insetti che alla loro anatomia, fisiologia classificazione. Nel1924 si laurea in lettere.
Luis Buñuel nasce nella provincia aragonese di Teruel ricca di insetti, a Calanda, nel 1900, da Leonardo (arricchitosi in America, proprietario terriero, vicino ai temi degli intellettuali riformatori) e da Maria Portes (diciottenne di straordinaria bellezza). La sua infanzia -è il primo di sette fratelli- e parte dell'adolescenza sono turbati dall'educazione religiosa ricevuta in un collegio di gesuiti. Completa gli studi a Saragozza, nel 1917 si reca a Madrid per iscriversi alla facoltà di agraria, quando avrebbe voluto applicarsi in composizione alla Schola Cantorum. Per niente attratto dalla "soluzione di equazioni", frequenta le lezioni di entomologia e nuovamente resta deluso perché si rende conto di essere più interessato alla letteratura sugli insetti che alla loro anatomia, fisiologia classificazione. Nel1924 si laurea in lettere.
Il soggiorno madrileno si svolge in un'esaltazione frenetica di giovinezza. Quale che sia la stagione e il tempo, egli esce di buon mattino con la pertica, si esercita con il punching-ball, diventa un fighter di grandi risorse. Circondato da fraterni amici 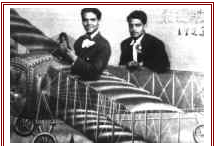 conosciuti alla Residencia de Estudiantes, Federico García Lorca, Moreno Villa, Salvador Dalí, Pepín Bello, Rafael Alberti e Ramòn Gòmez de la Serna, trascorre giorni interi nella parte vecchia della città, in conversazione nei caffè, in riunioni notturne quasi sempre destinate a letture di poesia. Anch'egli scrive e prende parte al diletto degli anaglifi, quattro versetti composti di tre sostantivi, il terzo dei quali deve essere la gallina. Allestisce rappresentazioni teatrali con Federico, fonda il primo cineclub di Spagna, non di rado terrorizza il personale del pensionato con sedute spiritiche. Con l'aiuto di Lorca e degli altri amici, un mondo fantastico e poetico si dischiude agli occhi del giovane Luis. Egli matura intellettualmente, gli occhi cominciano a vedere. Per i contorni precisi del materialismo, ateismo, anti-istituzionalismo di Buñuel sono decisive le letture di Freud, Feuerbach e Marx -senza dimenticare, per l'orientamento generale la forte impressione provocata dall'ipotesi della relatività di Einstein.
conosciuti alla Residencia de Estudiantes, Federico García Lorca, Moreno Villa, Salvador Dalí, Pepín Bello, Rafael Alberti e Ramòn Gòmez de la Serna, trascorre giorni interi nella parte vecchia della città, in conversazione nei caffè, in riunioni notturne quasi sempre destinate a letture di poesia. Anch'egli scrive e prende parte al diletto degli anaglifi, quattro versetti composti di tre sostantivi, il terzo dei quali deve essere la gallina. Allestisce rappresentazioni teatrali con Federico, fonda il primo cineclub di Spagna, non di rado terrorizza il personale del pensionato con sedute spiritiche. Con l'aiuto di Lorca e degli altri amici, un mondo fantastico e poetico si dischiude agli occhi del giovane Luis. Egli matura intellettualmente, gli occhi cominciano a vedere. Per i contorni precisi del materialismo, ateismo, anti-istituzionalismo di Buñuel sono decisive le letture di Freud, Feuerbach e Marx -senza dimenticare, per l'orientamento generale la forte impressione provocata dall'ipotesi della relatività di Einstein.
Nel 1925, il Manifesto di Breton e' pubblicato dalla "Rivista de Occidente". Lo stesso anno, il 18 aprile, per iniziativa del gruppo, Aragon parla a Madrid contro il lavoro, la civiltà e la scienza positiva. Buñuel e Dalí partono per Parigi portandovi "l'idea maturata alla Residencia, degli oggetti surrealisti" (Bodini).
Trascorsa poi l'esperienza di Amsterdam (dove Buñuel e' il regista di El retablo de Maese Pedro di Manuel de Falla) e l'apprendistato Parigino alla scuola di Jean Epstein,Buñuel continua a seguire a distanza le vicende dei surrealisti e, fallito un progetto di collaborazione con Ramon, ottiene dalla madre il denaro sufficiente per dirigere i diciassette minuti di Un chien andalou con il "divo" Pierre Batcheff.
Un Chain Andalou
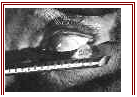 Pochi sono i film genuinamente surrealisti e Un chien andalou e' sicuramente uno di questi (insieme a L'âge d'or e a Las Hurdes) anzi e' il primo, vero film surrealista.
Pochi sono i film genuinamente surrealisti e Un chien andalou e' sicuramente uno di questi (insieme a L'âge d'or e a Las Hurdes) anzi e' il primo, vero film surrealista.
La sceneggiatura del film si deve oltre che a Buñuel, al suo amico pittore Salvador Dalí, destinato a diventare altrettanto famoso. Racconta lo stesso Buñuel: "Questo film nacque dall'incontro fra due sogni. Appena giunto a Figueras, da Dalí, invitato a passarci qualche giorno, gli raccontai che avevo sognato da poco un nuvola lunga e sottile che tagliava la luna e una lama di rasoio che spaccava un occhio. Lui mi raccontò che la notte prima aveva visto in sogno una mano piena di formiche. Aggiunse:-E se dai due sogni ricavassimo un film? ...La sceneggiatura fu scritta in meno di una settimana secondo una semplicissima regola adottata di comune accordo: non accettare alcuna idea alcuna immagine, alcuna immagine in grado di condurre a una spiegazione razionale, psicologica o culturale. Aprire le porte dell'irrazionale. Accogliere soltanto le immagini che ci colpivano, senza cercare di capire perché. "
 La logica delle immagini del film, dunque (se di logica si può parlare) non e' narrativa, ma obbedisce semmai alla tecnica surrealista del "cadavere squisito", un tipo di racconto discontinuo, portato avanti secondo la tecnica delle libere associazioni mentali: un'idea ne genera un'altra, a seconda di come ti salta in testa, secondo la suggestione offerta da un'immagine o da una parola.
La logica delle immagini del film, dunque (se di logica si può parlare) non e' narrativa, ma obbedisce semmai alla tecnica surrealista del "cadavere squisito", un tipo di racconto discontinuo, portato avanti secondo la tecnica delle libere associazioni mentali: un'idea ne genera un'altra, a seconda di come ti salta in testa, secondo la suggestione offerta da un'immagine o da una parola.
Il risultato, secondo i criteri del surrealismo, poteva essere bello "come l'incontro di un ombrello e di una macchina da cucire su un tavolo operatorio".
Sarebbe dunque vano cercare una storia coerente nel film o un significato nel suo titolo (non ci sono cani, tanto meno andalusi ). Ciò non significa che esso non contenga immagini fortissime e d' intensa suggestioni, prima tra tutte l'inquadratura famosa dell'occhio di donna (in realtà l'occhio di un vitello) tagliato da un rasoio, accostata all'immagine di una nuvola lunga e sottile che passa davanti al globo della luna (pensino al sogno di Buñuel). Oppure:la mano d'un uomo piena di formiche, presa nello stipite d'una porta (vedi il sogno di Dalí).
Se si può tentare un'interpretazione (comunque arbitraria) del film, si puo' forse dire che esso rispecchia gli ostacoli, esterni ed interni, che si frappongono alla piena realizzazione delle pulsioni erotiche, specialmente nell'ambito di una societa' ancora repressiva come quella spagnola degli anni venti; ma questi ostacoli sono soprattutto quelli frapposti dal Super-io, l'istanza censoria, che per Freud si affianca all'Inconscio e allenta i suoi freni, appunto, solo durante l'attività onirica (nei sogni).
 I protagonisti si cercano, si respingono, si desiderano, si odiano. L'uomo cerca di raggiungere la donna , ma ne e' impedito da una serie di pesi (morali, ideologici?) che e' costretto a trascinarsi dietro (un pianoferte a coda, un asino putrefatto, due preti... strano assemblaggio di oggetti surrealisti).
I protagonisti si cercano, si respingono, si desiderano, si odiano. L'uomo cerca di raggiungere la donna , ma ne e' impedito da una serie di pesi (morali, ideologici?) che e' costretto a trascinarsi dietro (un pianoferte a coda, un asino putrefatto, due preti... strano assemblaggio di oggetti surrealisti).
Salti temporali improvvisi: otto anni dopo ... sedici anni prima ... A un certo punto l'uomo si trova davanti al suo doppio, un altro se stesso, figura che ha sempre affascinato gli scrittori del fantastico come gli studiosi della psiche: doppio che l'uomo uccide puntandogli contro due libri che si trasformano in pistole.
Neppure la conclusione può dirsi rassicurante. I due amanti si allontanano lungo la riva del mare, ma l'ultima inquadratura li mostra sepolti fino al petto nella sabbia, immobili e sofferenti, come personaggi del teatro dell'assurdo.
L'occhio di Buñuel e' impetuoso fino alla fine - rifiuta come rifiuterà sempre, il cinema dei buoni sentimenti.
di GABRIELE MARTINA
PSYCHO (1960)
Regia Alfred Hitchcock
sceneggiatura di Joseph Stefano (dal romanzo di Robert Bloch)
direttore della fotografia John L. Russell
SHIFT EYE:
OGGETTIVA E SOGGETTIVA STILISTICA
di Alessandro Bernabucci
Chi è che guarda la città dall’alto fin dentro la stanza d’albergo, atterrando pindaricamente sul
cornicione della finestra di una camera d’albergo all’inizio del film? Un uccello?...
È Hitchcock stesso, naturalmente. Che con il suo sguardo ego-centro dell’azione, oscilla fra
voyerismo e feticismo spingendosi(ci) a curiosare nella vita altrui. Con questo ancoraggio
enunciativo Hitchcock ci accoglie nella sua identità visiva. La Macchina da Presa (MdP) è l’occhio
del regista, si sa; la sua (della MdP e del regista) realtà diventa la nostra realtà. Il pro-filmico
diventa filmico. Per traslato, possiamo dire che gli attanti di questo inizio siamo noi stessi, dunque.
Lo sguardo della MdP deve coincidere con quello dello spettatore; lo sguardo dello spettatore
collima con quello di Hitchcock. E’ uno shift eye da cosa si guarda a chi guarda. Ognuno di noi sta
spiando quei due amanti nella stanza d’albergo. «Mi fa guardare da quel buco di serratura
portatile?», dice Stella (Thelma Ritter), l’infermiera di “Rear window”, volendo guardare con la
macchina fotografica di Jeff (James Stewart). Alzi la mano chi non ha mai guardato dal buco di una
serratura?…e infatti: «Ma non siamo tutti dei voyeur?», rispondendo a Truffaut nel libro-intervista
“Il cinema secondo Hitchcock” (Pratiche Editrice, 1984).
Dunque: “Psycho” è senza dubbio il film più (o)scuro di Hitchcock. Il bianco/nero del film ha
toni crepuscolari. Il giorno è ombra e la notte è tenebra. Marion (Janet Leigh) da soggetto della
propria nevrosi diventa oggetto della psicosi di Norman (Antonhy Perkins), offrendosi a lui
mediante lo sdoppiamento dell’Io nel conflitto Es vs. SuperIo. La demarcazione segmentale è
visibile dal simbolico passaggio da biancheria intima bianca, indossata all’inizio, a biancheria
intima nera indossata quando Marion prepara la valigia per scappare. Marion–Norman: due nomi
speculari. Provate a leggerli da dx a sx; foneticamente si somiglieranno. E il processo
d’identificazione tra i due protagonisti scorre paludoso nel loro inconscio (quella palude dietro il
Motel dove scompare l’automobile). Anche Norman da oggetto della nevrosi della madre è
diventato soggetto della psicosi della Norman/Madre, cioè l’altro Norman. Marion non è che un
uccello da impagliare. Come la madre di Norman. L’uccello non è un feticcio della vita. Anzi. E’ la
rappresentazione simbolica della morte uccello-fallo (il gioco di parole esiste anche in inglese;
cock, come gallo, cock, come cazzo. Lascio a voi il dilettevole piacere di scoprire che viene fuori
traducendo hitch e cock…). E’ la morte di quella parte “malata” che Norman rifiuta di se stesso,
quasi fosse un omosessuale non dichiarato. Egli deve uccidere la sua parte virile e per farlo deve
uccidere la madre-donna, quel femminile che fatalmente ricorda alla dissociata mente di Norman
che lui è inevitabilmente un uomo.
Il vertiginoso sguardo di Hitchcock (l’acqua che mulinella nella doccia, le scale del campanile
in “Vertigo”) è dunque l’affermazione del processo di identificazione attraverso quello spostamento
dello sguardo che trasforma l’osservatore in osservato. Chi guarda, poi, è a sua volta guardato; un
concetto estremamente impressionista.
Questo shift eye – spostamento dello sguardo – è quello che qui chiameremo impropriamente la
soggettiva stilistica, perché ci rivela lo stato d’animo di Hitchcock (lo stato d’animo con cui
dobbiamo identificarci). Chiameremo dunque scena oggettiva la visione non filtrata da Hitchcock
e, invece, scena soggetiva stilistica (sogg.stil.) la scena vista attraverso lo sguardo interiore di
Hitchcock. Restano invariate le tassonomiche forme di inquadratura oggettiva, cioè la MdP che
assiste come un testimone fantasma senza mediare la realtà, e inquadratura soggettiva, cioè la MdP
che si sostituisce agli occhi del personaggio.
PSYCHO
(1960)
Regia Alfred Hitchcock
sceneggiatura di Joseph Stefano
direttore della fotografia John L. Russell
SCENA 1
sogg.stil.
Estate, giorno, primo pomeriggio, nell’ora più calda. Contrasto netto con l’atmosfera generale che si
respirerà durante tutto il film.
Appena entra nella stanza, lo sguardo di Hitchcock si posa su una coppia: Marion e Sam (John
Gavin). E’ evidente che sono due amanti e che da poco hanno fatto l’amore. Sam è tagliato
nell’inquadratura e non ne vediamo la testa. Appena Sam e Marion si sdraiano sul letto e
amoreggiano la Mdp avanza con decisione e si avvicina ai due. Eccitazione e maggior desiderio ci
portano a voler guardare da più vicino. È lo sguardo del voyeur che quasi vorrebbe toccare i due
che si baciano. Lei è in sottoveste e reggiseno bianchi (di nuovo il contrasto simbolico luce/buio
giorno/notte).
Lei si guarda allo specchio ma noi non la vediamo mai riflessa. Il personaggio di Marion lo
conosciamo da pochissimo; non sappiamo niente di lei. Non ci è ancora concesso conoscere il
sapere infradiegetico. Il suo conflitto è appena all’inizio, è a livello inconscio. Guardarsi allo
specchio significa mettersi in discussione con se stessi. Lo spettatore ancora non deve arrivare a
questa conclusione. E d’altronde neanche ad Hitchcock per adesso interessa.
Curiosità: ad un certo punto lui le dice che se si sposano lei dovrà leccare i francobolli nel
retrobottega. Non vedeva molto bene il matrimonio Hitchcock; d’altronde la stessa cosa la fa non
dire, ma fare a Joan Fontaine in “Rebecca”.
In questa scena ci sono in tutto 19 inq. e come teorizza Syd Field, che una sceneggiatura va divisa
in 3 atti, e ogni atto a sua volta diviso in 3 parti, questa scena, come del resto tutte le scene,
rispecchia visivamente questo modulo di costruzione narrativa; la prima parte lenta, di
presentazione; la seconda parte molto più veloce, serrata nel montaggio. Qui il discorso è più
ampio. Sam e Marion, amanti clandestini, consumano il loro rapporto fuori dai dettami sociali
(leggi matrimonio); la terza parte inizia lenta per concludersi in velocità quando Marion esce di
campo: il dovere la richiama alle convenzioni sociali.
SCENA 2
oggettiva
Marion arriva in ufficio (Hitchcock è fuori sul marciapiede con un cappellone texano in testa).
Arriva il milionario. Dialogo fra lui e Marion. Normale campo/controcampo. L’unico marcatore
della diegesi sono i 40.000 dollari (che serviranno solo come red herring). Il principale vuole che
lei li porti in banca. Sono una tentazione e l’occasione fa l’uomo (la donna) ladro(a).
SCENA 3
oggettiva
Marion entra nell’ufficio del principale. Gli dà i documenti e gli dice che ha mal di testa e vuole
andare a casa. Delle semplici aspirine non fanno andare via l’infelicità. Come i soldi del resto.
Nessun punto di vista particolare.
SCENA 4
sogg.stil.
Camera da letto di Marion. Sta preparando la valigia. Un marcatore evidentissimo. Lei è in
sottoveste e reggiseno. Questa volta, però, sono neri (ci viene in mente la Joan Crawford di “Johnny
Guitar” di N. Ray).
Hitchcock immediatamente ci conduce sott’acqua, ci fa scendere nell’io nascosto e buio,
nell’inconscio. Il film si sta spostando nell’(o)scuro. La MdP si avvicina ai soldi sul letto. La
focalizzazione sul denaro: significante polivalente del desiderio (sessuale e sociale) che serve per
aggirare il frammento di realtà che l’Io non accetta, per negarlo e ricostruirlo con le pulsioni
dell’Es. La MdP poi si sposta sulla valigia aperta che Marion sta preparando. Di nuovo lo sguardo
voyeristico di Hitchcock e, dunque, di noi spettatori. Vediamo per la prima in questa scena volta
l’immagine di Marion allo specchio. La dissociazione, lo sdoppiamento della personalità di Marion
è in atto; l’ego contro l’es, il conscio contro l’inconscio. Marion esce dalla camera. Il conflitto è
ufficialmente iniziato.
SCENA 5
sogg.stil.
Marion è in macchina. Visamente niente di particolare. Ma c’è un’interpellazione indiretta.
Sentiamo i suoi pensieri. Il mare dell’inconscio è sempre più agitato. La lotta es-ego si sta facendo
più dura. Improvvisamente c’è uno scarto; Hitchcock devia, la musica in tal senso ci porta ad aprire
gli occhi, mentre prima gurdavamo ad occhi chiusi (perché Marion è assorta nei suoi pensieri e per
noi spettatori sul suo primo piano non c'è niente da vedere, ma solo da ascoltare i suoi pensieri).
Marion vede il suo principale attraversare la strada. È la prima soggettiva del film: lo spettatore
vede con gli occhi di lei. Hitchcock ci ha condotto per mano dentro di lei. D’ora in poi vedremo il
mondo con gli occhi di lei, nel senso che il nostro stato d’animo è stato messo in contatto diretto
con il mondo interno di Marion. E ora che succederà? Si chiede Marion e ci chiediamo noi insieme
a lei (ricordiamoci però che tutto questo è una red herring. Come il Mac Guffin sono tutte mosse
diversive che distolgono l’attenzione dello spettatore da quella che sarà l’azione principale. Sono un
mazzo di chiavi false (come ben architettato in “Notorius”, nella sequenza del ricevimento quando
la MdP dall’alto carrella verso il basso fino a finire in dettaglio sulla mano di Elena che stringe la
chiave della cantina. Il Mac Guffin o la red herring sono «estremamente importanti per i personaggi
del film, ma di nessun interesse per me, il narratore»; da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit.).
Hitchcock ci sta portando volutamente fuori strada, perché a lui interessa un’altra storia e sta
preparando il terreno a quella sostituzione di personaggio, a quello shift eye che ci porterà a
spostarci da Marion a Norman, lo spostamento dello sguardo che denuncia la reversibilità, lo
sdoppiamento e il raddoppio dell’identità, facendo scivolare un racconto nell’altro; la rapina che
diventa assassinio, la nevrosi che diventa psicosi.
SCENA 6
sogg.stil.
Il film si sta avviando al crepuscolo. Come dice Raymond Bellour, entriamo nell’ “oscuro”, ci
caliamo nelle tenebre del nostro “io”, ci aggiriamo nei meandri dell’inconscio. Lei è in macchina.
Capiamo che sta scappando. Si sta facendo notte. Piove. Il commento musicale di B. Hermann è
memorabile. Questo primo viaggio sotto la superficie dura poco.
Stacco
SCENA 7
oggettiva
Esterno giorno. Una strada fuori città. Hitchcock ci fa respirare. La scena precedente è stata il primo
tuffo in apnea. Non dobbiamo stare troppo sott’acqua. Non siamo ancora pronti. L’inizio scena è
luminoso, idilliaco quasi, con quei fiori mossi dal vento. Non c’è dubbio però: l’esperienza
precedente ci ha segnati. Marion si è addormenta in auto sul ciglio della strada. Infatti, Marion
appena si sveglia ha l’istinto di scappare, tanto più che vede un poliziotto. Poliziotto che ci richiama
alla realtà, che funge da Super-Io dal quale non possiamo sfuggire. Il poliziotto si avvicina all’auto
e chiede se va tutto bene. Marion impaurita risponde frettolosamente. Mette in moto e va via.
SCENA 8
oggettiva – sogg.stil.
Automobile di Marion. Marion fugge senza meta. In una sorta di capovolgimento narrativo, il
poliziotto per assurdo è l’inconscio che ci segue e Marion controlla nello specchietto (di nuovo le
soggettive) se è seguita dalle sue colpe. Poi, però, il poliziotto cambia strada. Tregua del conflitto.
Dissolvenza e un po’ di respiro.
SCENA 9
oggettiva – sogg.stil.
Esterno giorno. In una qualunque cittadina. Lei compra il giornale. Di nuovo i sensi di colpa.
Controlla che sul giornale non ci sia qualche notizia che la riguardi, quel giornale che più avanti
tornerà utile nel racconto. Ora non c’è la notizia, ma poi ci saranno il soldi, che, su quel giornale,
stamperanno metaforicamente la colpa.
Il poliziotto è dall’altra parte della strada. Per adesso lo sappiamo solo noi, è extradiegetico,
(focalizzazione esterna). Marion non se ne è accorta. Marion è in un auto mercato all’aperto. Vuole
cambiare al sua automobile. Il venditore d’auto le dice: “Potete fare tutto quello che vi pare…e,
essendo donna, lo farete” (Hitchcock docet).
La scena diventa da oggettiva a soggettiva stilistica quando Marion vede il poliziotto. Qui il
racconto cinematografico segna un punto di demarcazione. C’è la prima soggettiva di Marion in
movimento. Il carrello indietro sul poliziotto mentre Marion va al bagno. La tensione sale, il
conflitto emerge sempre di più; l’inconscio sta approfittando della debolezza del conscio e vuole
venire a galla.
SCENA 10
sogg.stil.
Lei è nel bagno dell’auto mercato. L’inq. è dall’alto. Il destino impietoso la schiaccia. Di nuovo una
soggettiva di Marion che conta i soldi. Vuole pagare in contanti l’auto che ha scelto.
SCENA 11
oggettiva
Nell’auto mercato arriva il poliziotto. Marion esce dall’ufficio del venditore e si avvia verso la
nuova macchina. Ha fretta. Di nuovo sente il respiro delle colpe sul collo. Marion va via. Si ferma
perché il meccanico le dà la valigia che aveva lasciato nella vecchia auto. L’atuomobile esce di
campo. Dissolvenza
SCENA 12
sogg.stil.
Marion nell’automobile. Di nuovo un’interpellazione esterna. Vediamo Marion oggettivamente ma
la sentiamo soggettivamente. Off sentiamo di nuovo i pensieri che le affollano la mente. Di nuovo
comincia la discesa agli “inferi”.
SCENA 13
sogg.stil.
È sera. Buio, letteralmente. E quei fari delle auto contromano che ci abbagliano, non sono che una
luce che impedisce, per paradosso, di vedere meglio. Oltre a sentire i suoi sensi di colpa, le sue
paure, quelli che sentiamo e che sembrano essere i suoi pensieri sono, invece, un sapere
extradiegetico. O meglio: non sono quello che lei pensa, anche se chiaramente la sua mente è in
attività, ma noi spettatori stiamo sentendo quello che i personaggi si diranno lunedì quando Marion
non andrà a lavoro. La sequenza è costruita in maniera tale che ad ogni stacco sulla strada - la
soggettiva di Marion dal parabrezza - corrisponde poi un attacco su di lei sempre più vicino (il
close up è sempre più stretto) in un ritmo di montaggio sempre più serrato. Man mano che le voci
off. diventano più insistenti, Hitchcock si avvicina sempre di più al suo volto, fino ad arrivare ad un
P.P.P. La demarcazione segmentale della scena si chiude con un effetto, un deus ex machina, che
porterà Marion al motel di Norman: la pioggia.
SCENA 14
oggettiva – sogg.stil.
Reception del motel. Interno notte. Marion non trova nessuno nel motel. Guarda la casa dietro il
motel. Nella soggettiva del suo punto di vista, vediamo la casa e vediamo alla finestra una figura
femminile. Arriva Norman Beates (Anthony Perkins).
SCENA 15
oggettiva – sogg.stil.
Siamo nell’ufficio del motel. Il bancone separa nettamente le due figure. Di nuovo vediamo Marion
riflessa nello specchio. Il dialogo Marion-Norman si svolge in campo/controcampo: lei dal basso,
lui dall’alto. In verità Hitchcock qui è volontariamente scorretto. Infatti, essendo Marion più bassa
di Norman, noi dovremmo vedere Norman inquadrato dal basso e Marion dall’alto. Ma Hitchcock
capovolge la grammatica del punto di vista; di nuovo ci sta dicendo qualcosa. Ci sta dicendo che è
iniziato lo scarto del primo personaggio a favore del secondo. Marion si firma con un nome e
provenienza falsi. Soggettiva. Norman prende le chiavi della stanza 1. Qui siamo in pseudosoggettiva
per due motivi: 1) per presentarci Norman. Lo abbiamo visto per la prima volta da pochi
minuti e non sappiamo ancora niente sul suo conto. È troppo presto per vedere il mondo con i suoi
occhi; dunque nessuna soggettiva di Norman. Quel suo gesto esistante nel prendere le chiavi
qualcosa, però, ci dovrà pur dire; 2) Hitchcock ci permette di notare un dettaglio. Che la zona
occupata dalle chiavi 1 e 2 sul portachiavi è scrostata, mentre quello delle altre è intatto. È evidente
che Norman affitta sempre la stanza 1 o 2. Perché? Lo scopriremo tra poco.
SCENA 16
oggettiva
Norman prende la valigia in macchina.
SCENA 17
oggettiva – sogg.stil.
Entrano nella stanza 1. Norman apre la finestra. Perché? Dice che c’è odore di umidità, ma vedremo
più avanti che lo scopo è un altro. Prima obiettiva stranezza di Norman: non riesce a dire la parola
bagno. Di nuovo vediamo Marion riflessa nello specchio. Hitchcock non smette di ricordarci che il
conflitto, il confronto/scontro es-ego è sempre in atto. Norman esce. Lei sistema i soldi. Dove? Nel
giornale (ecco che raccoglie la semina). C’è la soggettiva di Marion che sistema il giornale sul
comò. Dalla finestra Marion sente Norman discutere con una donna: è la madre. Non vuole che il
figlio affitti la stanza ad una donna. Ecco perché Norman aveva aperto la finestra. Noi, insieme a
Marion, capiamo qualcosa in più di Norman. Sua madre è strana, bizzarra, quanto meno e,
conseguentemente, il rapporto di Norman con la madre è strano. Un’altra pennellata al ritratto
psicologico di Norman. La soggettiva di Marion che guarda la casa e, poi, Norman che esce di casa
con il vassoio per la cena. Norman entra nella stanza. E’ in imbarazzo: spiega che la madre non era
in sé. Sul vassoio il latte (Hitchcock è fissato con il latte, quello stesso latte de “Il sospetto” che
credevamo avvelenato – e quello stesso latte che troviamo anche ne “Il progioniero di Amsterdam”
che beve il vecchio corrispondente perché è a dieta), quel bianco latte che è presagio di morte,
perché il latte è contravveleno e se c’è il latte, allora, da qualche parte c’è anche il veleno.
Norman non vuole accettare l’invito di Marion di cenare nella stanza. È meglio andare in ufficio. È
la scena più lunga dall’inizio. Ed è chiaro, perché è la scena del loro incontro, è la scena che
sancisce il passaggio del testimone da Marion a Norman. È la scena che fa scivolare il primo
racconto (la red herring, la nevrosi diciamo noi) nel secondo racconto (la psicosi). Il soggetto
nevrotico diventa l’oggetto dello psicotico.
SCENA 18
sogg.stil.
È la scena chiave. Hitchcock mette in atto il processo di identificazione, quel transfert di identità
che rende uguali Marion e Norman e che porterà Norman ad assumere il ruolo di protagonista
(Hitchcock era affascinato dall’idea di far morire la star dopo solo 1/3 di film).
Vediamo nel dettaglio.
Entrano nel salottino. Marion guarda gli uccelli impagliati. Soggettiva sul gufo e sul corvo. Uccelli
notturni, uccelli della notte. Quegli stessi uccelli che nel film successivo a Psycho si ribelleranno
alla innaturale natura dell’uomo. Quando Norman parla del suo hobby, ci tiene a dire la tassidermia,
noi vediamo pochissimo Marion. Hitchcock è concentrato su Norman. Il suo sguardo stilistico è
tutto rivolto verso questo strano personaggio. Infatti nel gioco campo/controcampo le inquadrature
non sono corrispondenti e non sono girate con la stessa ottica. Marion è inqudrata dal basso in p.a. e
siamo abbastanza distanti da lei. Norman, invece, è sì inquadrato dal basso, ma siamo in mezza
figura molto più vicini. E, poi, inconfondibili segni connotativi, in alto nell’inquadratura
campeggiano a sinistra il gufo e a destra il corvo e Norman è collocato al centro fra i due uccelli
impagliati, quasi fosse il re della notte (dell’oscuro, dell’insondabile inconscio) con i suoi due fidi
scudieri. Hitchcock, con questa inq., infatti, esce allo scoperto. Il suo racconto, il suo sguardo, e,
dunque, il nostro di spettatori, è voyeuristicamente attratto da Norman.
Norman dice: “Il miglior amico è la propria madre”. Nettissimo segno connotativo; Norman è
decisamente strano. Questa è reversibilità. Se la madre non vuole che nessuna donna si avvicini al
figlio, perché solo lei è in grado di farlo entrare nel simbolico, anche il figlio, così assoggettato, può
provare nei confronti della madre un ossessivo desiderio di possessione. Nessun uomo può avere
sua madre (complesso di Edipo) e se qualcuno le si avvicina ecco che la nevrosi diventa psicosi; il
figlio può anche uccidere per impedire che un uomo possieda sua madre. Ed ecco Norman; la madre
è libera di concedersi ad un amante, mentre impedisce al figlio (la morbosa possessione) qualsiasi
rapporto con una donna. Norman non tollera, però, che la madre abbia un altro uomo all’infuori di
lui e così ucciderà sia l’uomo/amante ma, in un eccesso di psicosi, la madre, perché lo ha tradito
con un altro uomo. E, in un vertiginoso meccanismo di andata e ritorno, la madre si prenderà la sua
rivincita; Norman/Madre ucciderà tutte le donne che si avvicinano al figlio. È da notare in tutto ciò
come nei film di Hitchcock sia perennemente assente la figura paterna. Con una madre/moglie
siffatta accanto si è negato (o è scappato o è morto) e se ci fosse stato non sarebbe potuta essere
presente la figura materna. Non solo; senza la madre il figlio non avrebbe dovuto lottare con il
padre per emergere e per entrare nel simbolico, ma si sarebbe soltanto dovuto avvicendare in un
mondo già fatto. La madre, se le cose andassero così, non avrebbe nemmeno quel ruolo
destabilizzante che minaccia l’uomo nel suo processo di succesione da padre a figlio. Avendo,
invece, “educato” lei il proprio figlio, quel figlio entrerà nel simbolico come creatura materna e chi
prenderà il posto d’autorità nella società patriarcale sarà proprio la donna per interposto figlio.
Ma torniamo a Psycho. Il dialogo nel salottino fra Marion e Norman li pone sullo stesso piano.
Marion e Norman sono uguali; tutti e due hanno una vita vuota, sono senza identità, tutti e due sono
infelici. Sono speculari. L’uno si identifica nell’altra e viceversa. È uno sdoppiamento, ma anche un
raddoppiamento. Norman è lucido. È, potremmo dire, dissociato. Sta parlando di sé e la cosa, quasi,
non lo riguarda, freddo e distaccato come appare (sdoppiamento). Ma rafforza l’idea di sé
(raddoppiamento) dicendo che ognuno di noi “è stretto nella propria trappola”. È il
confronto/scontro fra due figure mitiche: la donna e l’uomo. Due figure legate da un doppio
vincolo. L’uomo che usa la donna per affermare il suo potere e la donna che pur di affermarsi
accetta questo ruolo di farsi amare-usare, immolandosi, proponendo un’immagine di sé che non sarà
mai la sua vera identità. Il sacrificio della donna serve all’uomo per affermare il proprio status quo.
Norman ci parla della madre che si è risposata dopo la morte del padre. Norman è Edipo che si è
accecato dopo aver scoperto le proprie colpe (“un figlio non si può sostituire ad un amante”).
Ed ecco, poi, un altro confronto /scontro: la madre e la donna. In Norman il confronto /scontro ha
sortito un effetto devastante, perché le due figure erano incarnate dalla stessa persona. Marion,
infatti, dice se non ha mai pensato di metterla in qualche posto, di farla curare. A questo punto c’è
uno scarto visivo nel racconto. Hitchcock sterza decisamente verso Norman. Ora Norman è in p.p.
Siamo quasi addosso a lui. Hitchcock ci mette in contatto con lo stato d’animo di Norman. Marion
si è spaventata per come ha reagito Norman alle sue parole ed anche Marion è inquadrata in p.p.
Norman, parlando della madre dice:
“Lei è innocua come uno di quegli uccelli impagliati”. Scopriremo, poi, che, effettivamente, è
proprio così. La MdP è fissa sul p.p di Norman. Non si muove mai. Noi siamo sempre lì ad
ascoltarlo, catturati da quello che sta dicendo. E infatti, non è la MdP che si allontana da lui, ma,
quando Norman si accorger di essere stato aggressivo, va indietro con il busto, è lui che si allontana
dalla MdP (da noi) e da Marion. E’ chiaro che Norman vive anche lui un conflitto di personalità. Le
parole di Norman sortiscono in Marion l’effetto del pentimento; rivelazione, turning point. “Perdere
al testa una sola volta può bastare”. Marion sta annunciando la sua uscita di scena. E Hitchcock la
farà uscire di scena con una sequenza memorabile. Marion si alza. Vuole andare. Dice (ci dice) che
è pentita di quello che ha fatto. “Domani devo tornare a Phoenix (non a Los Angeles, allora, come
aveva detto a Norman). Sono andata a ficcarmi in una brutta trappola. Devo tornare laggiù per
vedere se trovo il modo di uscirne prima che sia troppo tardi”. Ma in realtà non può nemmeno
immaginare in che trappola si è andata a ficcare. E che veramente ormai è troppo tardi. Di lì a poco
Norman/Madre la ucciderà.
Norman prima di congedarla vuole come avere una conferma del fatto che sono uguali, che anche
lei è senza identità come lui. Infatti le dice: “Buonanotte Miss…” “Crane”, risponde Marion
rivelando il suo vero cognome (crane in inglese vuol dire gru, un uccello appunto).
SCENA 19
sogg.stil.
È la scena che celebra il nuovo protagonista. L’asse del racconto si è decisamente spostato su
Norman. Norman guarda il registro delle firme. Scopriamo, attraverso la soggettiva, la falsa identità
di Marion quando si è firmata. Ed ecco che si rivela in tutta la sua stranezza il nuovo protagonista.
Anche lui, non come Marion, ma come Hitchcock (e per traslato, come tutti noi) è un voyeur.
Marion è solo la vittima dello “sguardo”. Norman stacca un quadro dal muro del salottino. Lì c’è un
buco fatto apposta per spiare nella stanza accanto, la stanza 1. Ed ecco spiegato il motivo che la
stanza 1 è la più affittata. Norman guarda Marion spogliarsi. Il soggetto della nevrosi femminile –
Marion – è diventato l’oggetto della psicosi maschile – Norman –. Quel tic di Norman quando il
suo occhio è inquadrato in dettaglio ci rivela che Marion è nuda. A noi non ci è permesso vedere
quello che Norman vede – lo sguardo impressionista - ma, forse. ancora con più efficacia e forza,
proprio nel non vedere ci arriva totalmente quello che Norman sta provando. Perché se noi
spettatori avessimo visto Marion nuda ci saremmo eccitati noi e nessuno di noi spettatori avrebbe
provato quel che sta provando Norman. L’avremmo potuto solo immaginare. Invece, nel non vedere
Marion, ma vedendo Norman che la guarda, siamo perfettamente al corrente di quello che lui sta
provando e possiamo (anzi, dobbiamo) solo immaginare come è Marion nuda. Norman mette a
posto il quadro. Ha uno scatto. Si rivolge fisicamente verso la casa. Quella donna nuda lo fa andare
dritto verso la madre. Perché? Per Norman UNA donna nuda è LA donna, e La Donna è sua Madre.
La madre, dunque, nella paranoia regressiva di Norman, è la figura topica del sesso femminile.
Norman esce dall’ufficio e si dirige verso la casa.
SCENA 20
oggettiva
Vediamo la casa di Norman da dentro. Lui entra. Sta per andare di sopra, ma ci ripensa. Va in
cucina e si siede. Guarda idelamente verso Marion, la quale…Stacco
SCENA 21
sogg.stil.
Marion è seduta. Di nuovo Hitchcock mette in atto il processo di identificazione. Scenicamente ci
rende uguali Norman e Marion: tutte e due seduti alle prese con le loro colpe. Soggettiva sui conti
che Marion sta facendo. Poi strappa i fogli e li getta nel water. Si toglie la vestaglia. Ora è nuda (in
tutti i sensi, letteralmente e metaforicamente). Si fa la doccia. Cerca di togliersi di dosso lo sporco,
la colpa. E per lei quell’acqua è una liberazione. Marion gode, letteralmente. L’insistenza di
Hitchcock va oltre la necessità diegetica. Qui si compie in pieno il suo sguardo stilistico. Se prima
della doccia la MdP era oggettiva, cioè si teneva a debita distanza dall’enunciazione, cioè da ciò che
riprende, ora, appena Marion tira la tenda, la MdP diventa soggettiva stilistica e il suo sguardo è
l’enunciato, la MdP stessa diventa filmico. I piani ravvicinati, il corpo nudo di Marion, il dettaglio
dell’acqua che zampilla a cui lei si concede totalmente, sorridendo e aprendo la bocca sono il
godimento che Marion non ha manifestato nella scena d’amore iniziale. La MdP senza pudore e
senza pietà ci mostra una donna priva di ogni difesa, nuda sotto la doccia. Ma qui non c’è esibizione
narcisistica; Marion non sta godendo per se stessa. Lo sguardo da voyeuristico è diventato
scopofilo, perché rappresenta il godimento maschile che si realizza in quel luogo mitico che è il
corpo della donna. La MdP si impossessa dello sguardo della donna per effetto di una pulsione
immaginaria. Si determina fra l’uomo e la donna un rapporto di specularità e di doppio. L’uomo è
talmente suggestionato dal proprio desiderio di possedere la donna che crede che sia la donna stessa
a mandargli questo messaggio, quasi che lei voglia essere posseduta. La possessione, come
manifestazione perversa, si attua con la distruzione di quell’immagine. E l’uomo, per
appropriarsene, sentendo la donna come minaccia di castrazione e dunque come minaccia del suo
status quo, del suo potere sociale, non può far altro che distruggerla (ucciderla) per ricostruirla a
proprio piacimento, per addomesticarla. Di qui la metafora dell’imbalsamazione. Questa
trasformazione, dalla nevrosi alla psicosi, si effettua tramite la donna che ne è il supporto, la forma
indispensabile.
Da quando Marion tira la tenda fino a quando il sangue scorre nello scarico della vasca ci son ben
49 inq. per neanche due minuti di film (questo è anche uno dei motivi per cui Hitchcock ha girato in
B/N; sarebbe stato troppo d’impatto il rosso del sangue che scorre nel bianco della vasca e il colore
avrebbe creato un effetto straniante che avrebbe distorto il racconto rendendolo iper reale. Il B/N
restituisce un look verosimile (curiosità: singolare l’inq. soggettiva sullo zampillo d’acqua:
l’obiettivo non si bagna. Che abbia ripreso uno specchio?).
L’ottava inq. di questa sequenza è sbilanciata. Marion in basso a destra e molta aria in alto. Ma ecco
che quello spazio vuoto si riempie: vediamo la porta del bagno aprirsi. Un’ombra si avvicina e la
MdP anche si avvicina. Va incontro all’assassino per arrivare puntuale all’appuntamento con il
delitto: l’assassino tira la tenda e noi siamo lì faccia a faccia con lui. Ma non capiamo bene: chi è? È
un uomo? Una donna? Non facciamo in tempo a decodificare perché il coltello vibra alto per dare
inizio alla memorabile sequenza della doccia con tutta la sua fascinazione e perversione.
Fotograficamente è la scena più luminosa del film; narrativamente, è chiaro, è la scena più buia.
Una serrata sequenza di inquadrature, montando sincopaticamente stretto/largo, che si concludono
sullo scarico della vasca (gli archi di Bernard Herrmann strillano e urlano alti e poi giù bassi
nell’oltretomba…è un coito/stupro vissuto da poco prima dell’orgasmo fina all’ultima violenta
penetrazione). Da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit.: “Naturalmente il coltello non tocca mai
il corpo, tutto è fatto con il montaggio. Non si vede mai una parte tabù del corpo della donna,
perché riprendevamo alcune inquadrature al rallentatore per evitare di avere i seni nell’immagine.
Le inquadrature riprese al rallentatore non sono poi state accelerate perché il loro inserimento nel
montaggio – durano pochissimi secondi, ndr – dà un’impressione di velocità normale”).
Dissolvenza e
SCENA 22
sogg.stil.
Dallo scarico della vasca la dissolvenza ci porta in dettaglio sull’occhio spalancato, vitreo di Marion
morta. Un movimento rotario per riprendere il vortice del sangue che si perdeva nella vasca e la
MdP diventa assoluta protagonista di questa scena. Come all’inizio, chi è adesso che si aggira per la
stanza? Lo sguardo stilistico di Hitchcock diventa enunciazione, l’espressione diventa contenuto. Il
pro-filmico diventa filmico. Siamo di nuovo noi spettatori i protagonisti di questa scena, è la nostra
smodata curiosità voyeuristica che ci fa rallentare in autostrada per vedere che cosa è successo se
c’è un incidente. Così adesso la MdP sospende per un attimo la narrazione diegetica. Ci aggiriamo
per la stanza fino ad arrivare sul giornale poggiato sul comò. Breve attimo di silenzio e riprende il
racconto diegetico vero e proprio. Sentiamo gridare off (dalla sceneggiatura originale, pag. 52
“MOTHER!…Oh God, what…BLOOD, blood…MOTHER!”) e la Mdp muove verso la finestra per
farci vedere la casa da dove provengono le grida di Norman.
SCENA 23
oggettiva.
Torniamo alla “realtà” del racconto. Norman arriva nella stanza. Vede il cadavere di Marion lì nel
bagno. Si spaventa e si tappa la bocca con una mano. Nell’emotività del gesto fa cadere un quadro
dalla parete: un uccello (!). La prima cosa che fa, poi, è chiudere la finestra. Ma nessun uccello
volerà via, ormai (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: «…quando Melanie – “Gli uccelli”,
ndr - si rifugia in una cabina telefonica a vetri, la mia intenzione è di mostrare che è come un
uccello in gabbia…si assiste al rovesciamento del vecchio conflitto fra gli uomini e gli uccelli e
questa volta gli uccelli sono fuori e l’umano è in gabbia».
SCENA 24
oggettiva
È la scena della pulizia. Norman mette a posto le cose. In questa scena non c’è nemmeno una
soggettiva. Eppure le cose che si potrebbero vedere con gli occhi di Norman sono tante. Ma
Hitchcock non vuole farcele vedere. D’altronde è giusto che sia così. Norman è dissociato. In
questo momento sta agendo freddamente. La sua reazione è lucida e determinata, quasi non lo
riguardasse ciò che sta facendo. E, dunque, non deve riguardare noi.
SCENA 25
oggettiva
Norman mette il cadavere di Marion nel portabagagli dell’auto con tutte le sue cose. Compreso il
giornale con i soldi.
SCENA 26
oggettiva
La macchina che cola a picco nella palude. Norman in piedi ad osservare. Lui e noi semplici
spettatori di questa scena. Il racconto è definitivamente colato a picco nel torbido, nel profondo
delle acque melmose, nel buio.
FINE I ATTO.
SCENA 27
oggettiva
Il bianco di una lettera. Siamo in soggettiva. È Sam che sta scrivendo a Marion. Siamo nel
retrobottega del suo negozio di ferramenta. La MdP arretra. Il carrello indietro si allontana da Sam
fino ad arrivare all’entrata del negozio. Il movimento di macchina, è evidente, sta a significare che
dobbiamo uscire dalla palude, quasi che la MdP ci stesse tirando su da quelle profondità dove
eravamo andati a finire. Il racconto visivamente deve darci una tregua. L’emozione fin qui è stata
troppo forte. Dobbiamo riprendere un po’ di fiato. Torniamo in superficie.
Off sentiamo la voce di una cliente. Nenache a farlo apposta però si parla di morte. La cliente sta
commentando gli effetti di un insetticida. Secondo la signora insetto o uomo che sia la morte
dovrebbe sempre essere indolore. Stacco. Nel negozio entra Lila, la sorella di Marion. Poche battute
con Sam e Hitchcock ci mostra un uomo alla porta che osserva i due. Hitchcock non si fa sfuggire
l’occasione. Il suo sguardo entra decisamente in gioco. L’uomo entra nel negozio accompagnato in
p.p. dalla MdP che arretra (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: Truffaut, dice: «La sua
tecnica è completamente subordinata all’efficacia drammatica, è in qualche modo una tecnica
d’accompagnamento dei personaggi.» A. Hitchcock «Proprio così. […] Nella maggior parte dei
film si ha questa successione: p.p dell’uno, p.p. dell’altro, p.p. dell’uno, p.p. dell’altro, p.p. dell’uno,
p.p. dell’altro e, tutt’a un tratto un campo totale per permettere a uno dei due personaggi di alzarsi.
Trovo che sia sbagliato fare così». F Truffaut «Lo credo anch’io perché in questo caso la tecnica
precede l’azione invece di accompagnarla e il pubblico riesce a capire che uno dei due personaggi
sta per alzarsi…In altri termini, non bisogna mai spostare la MdP pensando di favorire la
realizzazione di quello che sta per succedere…» A. Hitchcock «Esatto, perché allenta l’emozione
[…]. Se un personaggio si muove e si vuole conservare l’emozione sul suo volto, bisogna far
viaggiare il primo piano»). L’uomo che entra nel negozio guarda addirittura in MdP. È Arbogast
(Martin Balsam), l’investigatore. Farà una brutta fine? L’interpellazione non ci dice niente di buono
sul suo futuro. E poi è un tipo troppo sospettoso. Dubita di Lila e dubita, soprattutto, di Sam.
SCENA 28
oggettiva
Serie di inquadrature in dissolvenza che ci mostrano Arbogast che fa domande in giro.
SCENA 29
oggettiva–sogg.stil.
Arbogast arriva al motel di Norman. Questa è la scena del secondo atto che fa esordire il nuovo
protagonista: Norman. L’inizio è tranquillo, luminoso. I due entrano nell’ufficio. Arbogast fa
domande. È iniziata l’inchiesta, modello classico del sistema Hitchcockiano, che si eprime in due
forme reversibili e complementari. Una forma prevede che il protagonista, costretto dalla
drammatizzazione degli eventi, scopre una certa verità del suo desiderio. L’altra, invece, nega al
protagonista l’accesso alla verità dell’inchiesta.
Pian piano l’atmosfera cambia. Illuminazione e linguaggio cinematografico contribuiscono a
trasformare la diegesi. Sembra un interno notte ad un certo punto. Di nuovo precipitiamo
nell’oscuro. D’improvviso l’alternanza campo/controcampo è rotta dall’irruzione di un p.p. su
Norman che si china a guardare il registro (“bisogna soprattutto evitare che la MdP divenga
improvvisamente distante e obiettiva, altrimenti si distrugge l’emozione che è stata creata”; “Il
cinema secondo Hitchcock”, op. cit). Il p.p. è ripreso con una angolazione che distorce il volto di
Norman. È lo scarto visivo, il demarcatore segmentale che ci fa precipitare anche a noi spettatori
dentro l’agitato stato d’animo di Norman, un Norman che ha paura e che fa paura.
Il bancone separa nettamente i due, come separava Marion da Norman. Non bisogna superare quel
confine però, perché quel banco segna il confine tra la vita e la morte. Di qua i vivi, di là gli uccelli
impagliati. Ma proprio Norman è da quella parte. Allora, anche lui è un uccello impagliato. Sì.
Anzi, no. O meglio: una parte di lui è impagliata e chiaramente lo scopriremo alla fine. Le domande
di Arbogast mettono in difficoltà Norman. Arbogast ha scoperto che Marion è stata in quel motel.
Vorrebbe parlare con la madre di Norman. Le domande di Arbogast diventano più incalzanti.
“Avete passato la notte insieme?”, chiede Arbogast. Questa domanda sortisce il primo effetto
dell’inchiesta. Norman, scoperto, scopre la verità di un suo desiderio. In fondo, lui Marion l’ha
desiderata (come ha desiderato sua madre, la quale lo ha tradito con un altro uomo e per questo
Norman l’ha uccisa). Norman si irrigidisce. È infastidito da tutte quello domande. Invita Arbogats
ad andarsene.
SCENA 30
oggettiva
Arbogast ad una cabina telefonica. Parla con Lila. Le dice che tra meno di un’ora sarà di ritorno.
Prima deve parlare con la madre di Norman.
SCENA 31
oggettiva
Arbogast torna al motel. Si aggira per il portico. Si accerta che non ci sia nessuno Entra nell’ufficio.
Va di là nel salotto. Ha varcato il confine; è sull’altra riva dell’Acheronte. Anche lui è “colpito”
dagli uccelli imbalsamati. Soggettive sul gufo e sul corvo. Guarda la cassaforte. Poi decide di
andare verso la casa.
SCENA 32
oggettiva–sogg.stil.
Arbogast entra nella casa. Fin qui nessun demarcatore. Decide di andare di sopra. Appena inizia a
salire le scale Hitchcock irrompe con il suo sguardo. Invece di farci vedere il volto di Arbogast,
shift eye e ci mostra la scala dal basso e i piedi che iniziano a salire i gradini. Poi il campo totale
dall’alto (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: “C’era un’inquadratura della mano che scorre
sul corrimano e una carrellata attraverso la ringhiera della scala che fa vedere i piedi di Arbogast di
fianco.. Quando ho visto i giornalieri della scena, mi sono accorto che non andava bene. […].
Queste inquadrature sarebbero state adatte se si fosse trattato di un assassino che saliva la scala.
[…] Quindi, mi sono servito di una sola ripresa di Arbogast che sale la scala e, quando sta per
arrivare all’ultimo scalino, ho deliberatamente messo la MdP in alto per due ragioni: la prima per
poter filmare la madre verticalmente perché, se l’avessi mostrata di spalle, poteva sembrare che non
avessi voluto apposta far vedere il suo volto e il pubblico non si sarebbe fidato. Dall’angolo dove mi
ero messo invece non davo l’impressione di voler evitare di far vedere la madre. La seconda e più
importante ragione per salire così in alto con la MdP era di ottenere un forte contrasto tra il campo
totale della scala e il p.p. di Arbogast quando il coltello si abbatte su di lui. Era proprio della
musica, vede, la MdP in alto con i violini e, improvvisamente, la grossa testa con gli ottoni. Si
ricordi gli sforzi che abbiamo fatto per preparare il pubblico a questa scena; abbiamo stabilito che
c’era una donna misteriosa nella casa, abbiamo stabilito che questa donna misteriosa era uscita di
casa e aveva pugnalato una giovane donna sotto la doccia. Tutto ciò che poteva dare suspense a
questa scena era contenuto in questi elementi”). Arbogast è accoltellato e cade all’indietro sulla
scala. Un urlo e fade out.
FINE II ATTO.
SCENA 33
oggettiva
Sam e Lila. Arbogast doveva tornare da più di tre ore. Sam va al motel.
SCENA 34
oggettiva
Norman osserva la palude.
SCENA 35
oggettiva
Sam torna da Lila. Di Arbogast nessuna traccia. Tutto girato in oscurità. Decidono di rivolgersi allo
sceriffo in piena notte.
SCENA 36
oggettiva
Sam e Lila sono a casa dello sceriffo. È la scena deus ex machina dell’inchiesta. Sempre nello
schema classico dell’inchiesta Hitchcockiana ci si appoggia su un terzo personaggio. Veniamo a
sapere tutto quel che si sa di Norman. La madre dieci anni fa dopo aver ucciso l’amante che viveva
con lei si suicidò. Norman li trovò morti nel letto (chiaramente lascia intendere nudi e solo così ci
possiamo spiegare il disturbo psicologico di Norman). Ma l’inchiesta non risolve l’enigma. Ci
lascia una porta aperta. Sam e Lila dicono che c’è una donna nella casa di Norman. Lo sceriffo si
chiede allora se la donna in casa di Norman è la madre chi è sepolto nel cimitero? Tutto ciò sul
p.p.p. dello sceriffo. Partecipiamo con lui al suo dubbio.
SCENA 37
sogg.stil.
Norman va a casa. Sale su in stanza. Lo sentiamo parlare con la madre. La MdP in punta di piedi
sale anch’essa fino a piazzarsi alta sul pianerottolo, là dove s’era piazzata quando la madre pugnala
Arbogast. Vediamo Norman portare in braccio la madre giù in cantina, quel luogo mitico del
sottosuolo di dostojievskiana memoria, come è sempre la cantina in “Notorius” il luogo dove si
nascondono le malefatte (da “Il cinema secondo Hitchcock”, op. cit: “Ho alzato la MdP appena
Perkins incomincia a salire la scala. Entra nella stanza e non lo vediamo più; ma lo sentiamo:
«Mamma, bisogni che ti porti in cantina perché verranno qui a fare delle indagini». Poi si vede
Perkins che porta la madre in cantina. Non potevo tagliare l’inquadratura perché il pubblico sarebbe
diventato sospettoso. […]. Così ho la MdP sospesa che segue Perkins quando sale la scala, entra
nella camera ed esce di campo, ma la MdP continua a salire senza interruzione e, quando siamo
sopra la porta la MdP gira su se stessa, e guarda di nuovo giù dalla scala: perché il pubblico non si
interroghi su questo movimento, lo distraiamo facendogli sentire un litigio fra madre e figlio. Il
pubblico fa talmente attenzione al dialogo che non pensa più a quello che fa la MdP”). Il
movimento di MdP qui è una red herring. Ci fa credere che la madre sia viva, che esiste. E il
dialogo lo conferma. E, poi, è la prima volta che vediamo insieme Norman e la madre. Non
possiamo più avere dubbi.
SCENA 38
oggettiva
Tregua. Usciamo dall’oscuro, dal buio del racconto. Luce, giorno, esterno.
Sam e Lila parlano con lo sceriffo fuori da una chiesa. Il tocco qui è leggero e ironico. Sam e Lila
decidono di andare al motel da soli.
SCENA 39
oggettiva
Sam e Lila sono in macchina. Si accordano sul da farsi.
SCENA 40
oggettiva – sogg.stil.
Arrivano al motel. È la prima volta che lo vediamo di giorno. Sono nell’ufficio. Di nuovo il
bancone che separa i vivi dai morti. Prendono una camera. Sul finire della scena Hitchcock monta
velocemente una serie di p.p. di Norman e di loro due. Anche noi dobbiamo sapere che Norman
sospetta di loro e che loro sospettano di Norman. Sdoppiamento e raddoppio.
SCENA 41
oggettiva
Lila e Sam sono in camera. Decidono che fare.
SCENA 42
oggettiva
Escono di nascosto e vanno a controllare la camera 1.
SCENA 43
oggettiva
Lila e Sam sono nella camera 1. Cercano, guardano. Lila trova nel bagno un pezzetto di carta con
dei numeri. Sono le cifre che Marion aveva scritto. Si decidono: lui parlerà con Norman per
intrattenerlo mentre lei andrà nella casa per parlare con la madre.
SCENA 44
oggettiva
Da questa scena in poi, più che le singole inquadrature è il montaggio a rendere tutto suspense. Sam
e Norman nell’ufficio.
SCENA 45
sogg.stil.
Lila si avvicina con timore alla casa. Hitchcock ci mostra la soggettiva di lei mentre si avvicina. Un
movimento di carrello lento e incerto, come lo stato d’animo di Lila. Oltre a farci vedere quello che
Lila vede, il movimento di MdP ci fa sentire quello che lei sta provando. Lila entra in casa. Noi non
entriamo con lei. Ci chiude la porta in faccia.
SCENA 46
oggettiva
Norman e Sam nell’ufficio. Uno di qua e l’altro al di là del bancone.
SCENA 47
sogg.stil.
Lila è in casa. È nella stanza del piano di sopra. Si aggira per la stanza. Una serie di soggettive ci
mettono in contatto con il mondo di Norman. Sentiamo anche noi, come Lila, di esserci intromessi
nella vita di un’altra persona. Lila è attratta da un soprammobile: due mani incrociate. È solo un
escamotage per farci fare un salto sulla poltrona. Infatti Lila si spaventa; ma è solo la sua immagine
riflessa nello specchio come in un loop infinito.
SCENA 48
oggettiva
Sempre Norman e Sam nell’ufficio. Le domande di Sam sono sempre più calzanti. Sempre uno di
qua e l’altro al di là del bancone.
SCENA 49
oggettiva
Lila in casa di Norman. Vede un letto di bambino e una bamboletta. Poi si avvicina al giradischi. È
“L’eroica” di Beethoven.
SCENA 50
oggettiva
Norman capisce che le domande sono un diversivo. Chiede dove sia Lila. Nella colluttazione Sam
ha la peggio. Norman corre verso la casa.
SCENA 51
oggettiva–sogg.stil.
Lila vede arrivare Norman. Si nasconde nel sottoscala. Norman va di sopra. Lila vede la porta della
cantina. Scende. Entra in cantina. È lì nel dostojevskiano sottosuolo che si nascondono le nostre più
recondite paure e colpe. Lila vede laggiù seduta in un angolo di spalle una donna. Qui la sequenza è
sempre più spezzata dall’alternanza soggettiva/oggettiva, dall’inq. su la vecchia di spalle e sul p.p.
di Lila che si avvicina. Eccola quasi la tocca, allunga un mano la sedia si gira e…la rivelazione: è
uno scheletro. La madre di Norman è una mummia, è un “uccello” impagliato. Alle sue spalle ecco
di nuovo quella figura femminile con un coltello in mano. Sta per sferzare il colpo ma Sam alle
spalle lo blocca. Nella colluttazione Norman perde la parrucca e il vestito da donna che indossa: la
madre di Norman è Norman.
Il tragitto è completato. Il processo di identificazione è arrivato al massimo della sua
trasformazione. Marion da soggetto della nevrosi era diventata l’oggetto della psicosi. Appena
Marion muore anche Norman subisce la trasformazione. Il processo è reversibile. A Norman il
processo di sdoppiamento della personalità, la dissociazione psichica – PSYCHO – lo ha portato ad
essere da soggetto della nevrosi di una metà a oggetto della psicosi dell’altra metà, la metà
Madre/Norman che ormai ha preso il sopravvento. Norman è vittima di se stesso.
SCENA 52
oggettiva
Lo “spiegone” finale. Lo psichiatra ci dice che Norman uccise sua madre e il suo amante. La madre
aveva tradito il figlio con un altro uomo. Di qui il dicotomico desiderio di amore/morte per le donne.
SCENA 53
oggettiva–sogg.stil.
La voce off della madre sul carrello che avanza fino ad arrivare a p.p. su Norman. “Una povera
vecchia che non farebbe male ad una mosca”. E il sorriso ghigno di Norman al quale si
sovrappongono in dissolvenza i denti del teschio. Dissolvenza e vediamo la macchina ripescata
nella palude che viene issata a terra. Tutto, prima o poi, viene a galla, anche le colpe più profonde.
FINE
di Alessandro Bernabucci
Innanzitutto dimenticare il libro per poter vedere il film, meglio poi dimenticare il film ricordando il libro.  Umberto Eco infatti non ha sbagliato, non rendendosi né complice né giudice del film liberamente tratto dal palinsesto del suo libro, ha implicitamente segnalato il confine invalicabile tra queste due operazioni, letteraria e cinematografica. Inutile dunque una perizia critica comparativa, essendo differenti gli intenti: l'uno soprattutto culturale, l'altro decisamente commerciale; differenti le specificità: romanzo filosofico il primo, racconto di suspense il secondo (tale carattere può attribuirsi anche al libro, mentre risulta falso il viceversa); differenti poi le finalità: il primo intende "trasformare" il proprio lettore, il secondo si accontenta di "appagarlo". Se c'è un parallelo possibile tra i "Nomi della rosa" bisogna cercarlo in astratto e comunque a livelli di complessità non paragonabili, riguarda infatti una questione più generale che investe la recente produzione creativa nei campi della letteratura, del cinema, dell'arte: la mediazione metalinguistica e metacomunicativa, nel nostro caso metanarrativa. La maturità di un linguaggio si identifica con la nascita di un metalinguaggio che è come la sua coscienza, intesa quale sua trasformazione e ripensamento, ma nel momento in cui la coscienza critica, la conoscenza degli strumenti e delle strutture della comunicazione, provocano un aumento eccessivo delle variabili di controllo sull'espressione, quest'ultima rischia il "congelamento" simbolico, l'iperdeterminazione progettuale. Come se l'opera fosse ipotecata dai debiti prima ancora di nascere, e quando l'opera si realizza l'autore paga questi debiti ricorrendo alla citazione parziale o totale (il remake), oppure, più semplicemente, adottando lo schema riconoscibile di un genere, magari riciclato parodicamente e contaminato da altri prestiti eterogenei. L'autore, tanto nella produzione di consumo, quanto nella produzione colta, inibito dalla sua stessa autocoscienza e dall'eredità ricevuta, reagisce in due modi diversi: o vive felicemente di rendita, oppure diventa timido, più non s'azzarda. Allora che fare per riuscire a scrivere, fare cinema, dipingere? Ci rispondono le illuminanti e divertenti Postille al Nome della rosa: indossare una maschera, due, tre, quattro: «Io dico che Vallet diceva che Mabillon ha detto che Adso disse...» La prima persona diventa ultima, perché "si vergogna di raccontare" o teme di sbagliare, ma se la sua volontà è ostinata, una volta indossate le maschere, potrà progettare la sua opera nei minimi dettagli, costruire con pazienza e abilità "certosina", con "astuzia" diabolica, un congegno perfetto che prenderà inesorabilmente in trappola, proprio come il più complesso dei labirinti, ogni suo visitatore. Confidando oltretutto nell'ambiguità polisemica del linguaggio artistico che maschera a sua volta e apre "rizomaticamente" i circuiti del congegno medesimo. Peccato di modestia o d'orgoglio non sta a noi inquisire, ma può accadere che quando uno scrittore apparentemente
Umberto Eco infatti non ha sbagliato, non rendendosi né complice né giudice del film liberamente tratto dal palinsesto del suo libro, ha implicitamente segnalato il confine invalicabile tra queste due operazioni, letteraria e cinematografica. Inutile dunque una perizia critica comparativa, essendo differenti gli intenti: l'uno soprattutto culturale, l'altro decisamente commerciale; differenti le specificità: romanzo filosofico il primo, racconto di suspense il secondo (tale carattere può attribuirsi anche al libro, mentre risulta falso il viceversa); differenti poi le finalità: il primo intende "trasformare" il proprio lettore, il secondo si accontenta di "appagarlo". Se c'è un parallelo possibile tra i "Nomi della rosa" bisogna cercarlo in astratto e comunque a livelli di complessità non paragonabili, riguarda infatti una questione più generale che investe la recente produzione creativa nei campi della letteratura, del cinema, dell'arte: la mediazione metalinguistica e metacomunicativa, nel nostro caso metanarrativa. La maturità di un linguaggio si identifica con la nascita di un metalinguaggio che è come la sua coscienza, intesa quale sua trasformazione e ripensamento, ma nel momento in cui la coscienza critica, la conoscenza degli strumenti e delle strutture della comunicazione, provocano un aumento eccessivo delle variabili di controllo sull'espressione, quest'ultima rischia il "congelamento" simbolico, l'iperdeterminazione progettuale. Come se l'opera fosse ipotecata dai debiti prima ancora di nascere, e quando l'opera si realizza l'autore paga questi debiti ricorrendo alla citazione parziale o totale (il remake), oppure, più semplicemente, adottando lo schema riconoscibile di un genere, magari riciclato parodicamente e contaminato da altri prestiti eterogenei. L'autore, tanto nella produzione di consumo, quanto nella produzione colta, inibito dalla sua stessa autocoscienza e dall'eredità ricevuta, reagisce in due modi diversi: o vive felicemente di rendita, oppure diventa timido, più non s'azzarda. Allora che fare per riuscire a scrivere, fare cinema, dipingere? Ci rispondono le illuminanti e divertenti Postille al Nome della rosa: indossare una maschera, due, tre, quattro: «Io dico che Vallet diceva che Mabillon ha detto che Adso disse...» La prima persona diventa ultima, perché "si vergogna di raccontare" o teme di sbagliare, ma se la sua volontà è ostinata, una volta indossate le maschere, potrà progettare la sua opera nei minimi dettagli, costruire con pazienza e abilità "certosina", con "astuzia" diabolica, un congegno perfetto che prenderà inesorabilmente in trappola, proprio come il più complesso dei labirinti, ogni suo visitatore. Confidando oltretutto nell'ambiguità polisemica del linguaggio artistico che maschera a sua volta e apre "rizomaticamente" i circuiti del congegno medesimo. Peccato di modestia o d'orgoglio non sta a noi inquisire, ma può accadere che quando uno scrittore apparentemente  timorato dal dio della letteratura cede i propri diritti cinematografici a un giovane regista rampante, il congegno d'eccezione — e in grado perciò di veicolare e stimolare un'autentica riflessione sui valori, nonché sui meccanismi stessi della macchina narrativa — si trasformi in una ricetta. Dato un best-seller internazionale di cultura europea, ambientato in un'epoca nei confronti della quale si registra una rinnovata sensibilità del grande pubblico, si prenda un protagonista anglosassone di chiara fama, si sfruttino le linee generali dell'originale trama, per mutarne gli equilibri togliendo di qua aggiungendo di là secondo gli sperimentati canoni del cinema di suspense, si tralasci la filosofia dell'opera per estrarne la pillola morale, si porti in primo piano una scabrosa storia d'amore, quindi si condisca il tutto con gli effetti ordinari del grottesco e del lugubre, si faccia infine morire il cattivo e si salvi l'innocente; a questo punto si serva il piatto in tavola, tanto i biglietti sono già esauriti in prevendita: come tutte le confezioni regalo si compra a scatola chiusa. Per i produttori non c'è bisogno d'altro. E a chi ne parla rimane poco da dire, se non segnalare anche qui brillanti citazioni: del Piranesi per il labirinto della biblioteca, la sapiente fotografia "metafisica" di Delli Colli, la scenografia esplicitamente teatrale e il gusto "Grand Guignol"; tutti elementi che comunque suggerivano una chiave possibile di messa in scena
timorato dal dio della letteratura cede i propri diritti cinematografici a un giovane regista rampante, il congegno d'eccezione — e in grado perciò di veicolare e stimolare un'autentica riflessione sui valori, nonché sui meccanismi stessi della macchina narrativa — si trasformi in una ricetta. Dato un best-seller internazionale di cultura europea, ambientato in un'epoca nei confronti della quale si registra una rinnovata sensibilità del grande pubblico, si prenda un protagonista anglosassone di chiara fama, si sfruttino le linee generali dell'originale trama, per mutarne gli equilibri togliendo di qua aggiungendo di là secondo gli sperimentati canoni del cinema di suspense, si tralasci la filosofia dell'opera per estrarne la pillola morale, si porti in primo piano una scabrosa storia d'amore, quindi si condisca il tutto con gli effetti ordinari del grottesco e del lugubre, si faccia infine morire il cattivo e si salvi l'innocente; a questo punto si serva il piatto in tavola, tanto i biglietti sono già esauriti in prevendita: come tutte le confezioni regalo si compra a scatola chiusa. Per i produttori non c'è bisogno d'altro. E a chi ne parla rimane poco da dire, se non segnalare anche qui brillanti citazioni: del Piranesi per il labirinto della biblioteca, la sapiente fotografia "metafisica" di Delli Colli, la scenografia esplicitamente teatrale e il gusto "Grand Guignol"; tutti elementi che comunque suggerivano una chiave possibile di messa in scena  cinematografica: il gioco del falso. Già d'altronde anticipato da Eco: «Tu (lettore) credi di voler sesso e trame criminali in cui alla fine si scopre il colpevole, e molta azione, ma al tempo stesso ti vergogneresti di accettare una venerabile paccottiglia fatta di mani della morta e fabbri del convento. Ebbene io ti darò latino, e poche donne, e teologia a bizzeffe e sangue a litri come nel Grand Guignol in modo che tu dica "ma è falso, non ci sto!" E a questo punto dovrai essere mio, e provare il brivido della infinita onnipotenza di Dio, che vanifica l'ordine del mondo. E poi se sarai bravo, accorgerti del modo in cui ti ho tratto in trappola, perché infine te lo dicevo ad ogni passo, ti avvertivo bene che ti stavo traendo a dannazione, ma il bello dei patti col diavolo è che li si firma ben sapendo con chi si tratta». Ma siccome Annaud non se l'è sentita o non è stato in grado di "dichiarare il falso" fino in fondo, tramite i giochi d'artificio della narrazione cinematografica, preferendo mediare tra falso e verosimile, tra parodico e patetico, tra dissacratorio e moralistico, dando insomma un colpo al cerchio e uno alla botte, lo spettatore alla fine si ritrova con la moglie sobria e la botte vuota... Scusate se mi interrompo un attimo, la citazione è contagiosa, ci si casca facilmente per il divertimento di mescolare le vecchie carte leggendovi un futuro nuovo, e qui penso alla grande occasione rappresentata dal personaggio di
cinematografica: il gioco del falso. Già d'altronde anticipato da Eco: «Tu (lettore) credi di voler sesso e trame criminali in cui alla fine si scopre il colpevole, e molta azione, ma al tempo stesso ti vergogneresti di accettare una venerabile paccottiglia fatta di mani della morta e fabbri del convento. Ebbene io ti darò latino, e poche donne, e teologia a bizzeffe e sangue a litri come nel Grand Guignol in modo che tu dica "ma è falso, non ci sto!" E a questo punto dovrai essere mio, e provare il brivido della infinita onnipotenza di Dio, che vanifica l'ordine del mondo. E poi se sarai bravo, accorgerti del modo in cui ti ho tratto in trappola, perché infine te lo dicevo ad ogni passo, ti avvertivo bene che ti stavo traendo a dannazione, ma il bello dei patti col diavolo è che li si firma ben sapendo con chi si tratta». Ma siccome Annaud non se l'è sentita o non è stato in grado di "dichiarare il falso" fino in fondo, tramite i giochi d'artificio della narrazione cinematografica, preferendo mediare tra falso e verosimile, tra parodico e patetico, tra dissacratorio e moralistico, dando insomma un colpo al cerchio e uno alla botte, lo spettatore alla fine si ritrova con la moglie sobria e la botte vuota... Scusate se mi interrompo un attimo, la citazione è contagiosa, ci si casca facilmente per il divertimento di mescolare le vecchie carte leggendovi un futuro nuovo, e qui penso alla grande occasione rappresentata dal personaggio di  Salvatore (bravo anche l'attore), geniale babele in carne ed ossa, quasi il doppio negativo di Guglielmo, laddove questi dipana le trame del caso, Salvatore confonde i riferimenti, miscela appunto le citazioni, nomade del senso e della lingua, rimane imprendibile per ogni inquisizione. La sua ambiguità ineffabile poteva indicare un'altra chiave registica: invece di predeterminare lombrosianamente i caratteri dei personaggi, sospenderli su un terreno viscido, dove qualsiasi direzione era buona per scivolare. Se il lettore di Eco veniva catturato da un congegno che pure gli rivelava come si possono simulare dei mondi possibili scam-biandoli per necessari, lo spettatore di Annaud viene ospitato in un mondo necessario, quello della confezione, che gli è stato venduto come possibile. Ormai esausti per i pellegrinaggi nei labirinti autentici e in quelli fasulli, seguiamo per un'ultima volta la lanterna di Guglielmo da Baskerville: «quando lo scrittore pianifica il nuovo, e progetta un lettore diverso, non vuole essere un analista di mercato che fa la lista delle richieste espresse, bensí un filosofo, che intuisce le trame dello Zeitgeist. Egli vuole rivelare al proprio pubblico ciò che esso dovrebbe volere, anche se non lo sa. Egli vuole rivelare il lettore a se stesso». Tutto fila e tanti auguri per ogni tentativo, ma se un lettore vendicativo, magari posseduto dalla buonanima di Jorge Luis, il vero bibliotecario cieco fatto poi suicida nel rogo dei propri tesori, riuscisse a prendere l'autore alla sprovvista ed attirarlo fuori dal suo studiolo, nel piú terribile dei labirinti: il deserto, della pagina bianca, della pellicola vergine, forse allora l'autore nudo, esposto ai raggi del sole e ai miraggi del senso, costretto a rischiare di nuovo per riuscire a cavarsela, potrebbe rivelarsi a se stesso. Forse, l'autore che davvero rivela il fruitore a se stesso, lo fa accidentalmente, rivelandosi per primo, rischiando per primo; e forse ancora, come dice Massimo Mila a proposito della funzione della critica (ne siamo direttamente coinvolti e concordi), «non si scrive per informare e per orientare il pubblico; si scrive perché si ha qualcosa da dire. Scrivere un articolo di critica è lo stesso che scrivere una poesia. A che serve una poesia? A niente. Cosí la critica».
Salvatore (bravo anche l'attore), geniale babele in carne ed ossa, quasi il doppio negativo di Guglielmo, laddove questi dipana le trame del caso, Salvatore confonde i riferimenti, miscela appunto le citazioni, nomade del senso e della lingua, rimane imprendibile per ogni inquisizione. La sua ambiguità ineffabile poteva indicare un'altra chiave registica: invece di predeterminare lombrosianamente i caratteri dei personaggi, sospenderli su un terreno viscido, dove qualsiasi direzione era buona per scivolare. Se il lettore di Eco veniva catturato da un congegno che pure gli rivelava come si possono simulare dei mondi possibili scam-biandoli per necessari, lo spettatore di Annaud viene ospitato in un mondo necessario, quello della confezione, che gli è stato venduto come possibile. Ormai esausti per i pellegrinaggi nei labirinti autentici e in quelli fasulli, seguiamo per un'ultima volta la lanterna di Guglielmo da Baskerville: «quando lo scrittore pianifica il nuovo, e progetta un lettore diverso, non vuole essere un analista di mercato che fa la lista delle richieste espresse, bensí un filosofo, che intuisce le trame dello Zeitgeist. Egli vuole rivelare al proprio pubblico ciò che esso dovrebbe volere, anche se non lo sa. Egli vuole rivelare il lettore a se stesso». Tutto fila e tanti auguri per ogni tentativo, ma se un lettore vendicativo, magari posseduto dalla buonanima di Jorge Luis, il vero bibliotecario cieco fatto poi suicida nel rogo dei propri tesori, riuscisse a prendere l'autore alla sprovvista ed attirarlo fuori dal suo studiolo, nel piú terribile dei labirinti: il deserto, della pagina bianca, della pellicola vergine, forse allora l'autore nudo, esposto ai raggi del sole e ai miraggi del senso, costretto a rischiare di nuovo per riuscire a cavarsela, potrebbe rivelarsi a se stesso. Forse, l'autore che davvero rivela il fruitore a se stesso, lo fa accidentalmente, rivelandosi per primo, rischiando per primo; e forse ancora, come dice Massimo Mila a proposito della funzione della critica (ne siamo direttamente coinvolti e concordi), «non si scrive per informare e per orientare il pubblico; si scrive perché si ha qualcosa da dire. Scrivere un articolo di critica è lo stesso che scrivere una poesia. A che serve una poesia? A niente. Cosí la critica».
Il nome della rosa
Regia: Jean-Jacques Annaud; sceneggiatura: Gérard Brach, Alain Godard, Andrew Birkin, Howard Franklin, dal romanzo di Umberto Eco; fotografia: Tonino Delli Colli; scenografia: Dante Ferretti; musica: James Horner; suono: Frank Jahn; montaggio: Jane Seitz; interpreti: Sean Connery (Guglielmo da Baskerville), Christian Slater (Adso di Melk), Helmut Qualtinger (Remigio di Varagine), Elya Baskin (Severino), Michael Lonsdale (l'abate), Volker Prechtel (Malachia), Fedor Chaliapin jr. (Jorge da Burgos), William Hickey (Ubertino da Casale), Michael Habeck (Berengario), Urs Althaus (Venanzio), Leopoldo Trieste (Michele da Cesena); produttore: Franco Cristaldi e Bernd Eichinger (Italia-Francia, 1986); distribuzione: Columbia Pictures Italia.
di a. b. PAG. 42 - CINEMA NUOVO - GENNAIO-FEBBRAIO 1987
"Once upon a time, forty years ago..." No, non è l'incipit di una fiaba inglese. Anche se, in un certo senso, potrebbe trattarsi di una favola per adulti. "Once upon a time, forty years ago." ovvero "C'era una volta, quarant'anni fa..." si riferisce infatti al western all'italiana, esploso nel 1964 col film Per un pugno di dollari di Sergio Leone, il tutt'altro che prolifico regista il quale considerava il suo cinema una favola per adulti. Non a caso, Leone usò esplicitamente "C'era una volta", in italiano, inglese o francese, per alcuni titoli dei suoi pochi film: C'era una volta il West (Once upon a time in the West, Il était une fois dans l'Ouest); Il était une fois. la révolution (ovvero Giù la testa); C'era una volta in America.
A quarant'anni dal boom del western all'italiana, e a un secolo da quello che è convenzionalmente considerato il primo film western della storia del cinema (The Great Train Robbery, 1903, di Edwin S. Porter), il cinema western sta vivendo una nuova stagione. Nel 2003 sono stati realizzati ben quattro western americani quali Open Rang. Terra di confine di Kevin Costner, Hidalgo. Oceano di fuoco di Joe Johnston, Cold Mountain. Ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghella e The Missing di Ron Howard; uno australiano, Ned Kelly di Gregor Jordan; e due produzioni francesi tratte da fumetti di culto, The Daltons di Philippe Haim (da Lucky Luke di Morris & Goscinny) e Blueberry (creato da Moebius) di Jan Kounen.
Proprio in Francia, poi, nel novembre scorso, è stato realizzato a Strasburgo un omaggio al western all'italiana con proiezioni di film, tavole rotonde, un concerto e una mostra di foto di scena, manifesti e locandine.
Per tutto il mese di marzo 2004, invece, su Studio Universal, canale satellitare di Sky, è andato in onda Spaghetti Western. Western made in Italy, una programmazione di 14 film, curiosità e lo special Western all'italiana. Il tutto (come recitava il lancio del programma) presentato dal grande e inimitabile Tex Willer, l'eroe del fumetto western creato da Gianluigi Bonelli nel 1948 che ha fatto breccia nel cuore di milioni di lettori, in Italia e in ben dodici paesi esteri, e tutt'oggi seguito con immutato interesse. Proprio a Tex Willer, sempre nella primavera del 2004, è stata dedicata una mostra a Vicenza.
È appena il caso di aggiungere che nell'estate 2005 Enzo G. Castellari dirigerà Franco Nero in Gli implacabili, western-omaggio a Sergio Leone. Proprio ai film western di Sergio Leone, infine, sarà dedicata una mostra internazionale che si terrà nell'estate 2005 a Los Angeles.
Tutto questo fa da background a una riflessione: ci sono le premesse e le condizioni favorevoli per un nuovo libro sul western all'italiana. Un libro che, corredato da uno sfizioso apparato iconografico, e aggiungendo qualcosa di originale e inedito a quanto già pubblicato sull'argomento, ripercorra cronologicamente le tappe di quel fenomeno popolare che è stato il cosiddetto "spaghetti western", a quarant'anni di distanza dalla sua esplosione: la decadenza del western americano nascita dei western tedeschi (serie "Winnetou") i primi western italo-spagnoli l'inaspettato e incredibile successo di Per un pugno di dollari (3 miliardi di lire d'incasso nel 1965!), uscito come "filmetto" che doveva raggranellare giusto qualche soldo in Italia nei cinema di provincia lo sviluppo selvaggio del filone e la sua decadenza la trasformazione nel cosiddetto "fagioli western" col film Lo chiamavano Trinità e il successo del "western commedia" la morte ufficiale del western all'italiana nel 1978 col film Sella d'argento.
Il volume sarà organizzato in ordine cronologico "per titolo": di ogni film verranno fornite le immagini del variegato materiale pubblicitario che ha accompagnato l'uscita della pellicola (locandine, manifsti, fotobuste, ecc.), una scheda tecnica e una ricchissima serie di fotografie di scena e di backstage. Si tratta della prima pubblicazione sull'argomento che, a differenza di altri volumi già usciti sull'argomento, presenta uno straordinario apparato iconografico, composto anche da materiale inedito.
Western all'italiana, una produzione incredibile di film tra il 1962 e il 1978: da 400 a 600, in base alle stime e alla considerazione di ciò che può rientrare a ragione nel "genere".
La pubblicazione, arricchita da testimonianze di prima mano raccolte per l'occasione e da brevi notazioni sociologiche (il quindicennio 1964-1978 è stato alquanto significativo per l'Italia, e non solo), potrebbe essere presentato nell'estate del 2005 a Los Angeles, nell'ambito della citata mostra mondiale dedicata a Sergio Leone e ai suoi western.
Alberto Castagna
Nasce a Isca sullo Ionio (CZ) il 16 dicembre 1948. Diplomato al liceo classico "Lucrezio Caro" di Roma, giovanissimo comincia a curare pubblicazioni di cinema e spettacolo. Una particolare attenzione riserva alla letteratura classica e a quella di genere divenendo esperto di fantascienza e fumetti oltre che naturalmente di cinema. A 24 anni si laurea in giurisprudenza e si specializza successivamente in scienze amministrative.
Nello stesso anno (1974) apre la ormai storica libreria di via Giolitti a Roma, a due passi dalla Stazione Termini, che diviene subito luogo di incontro per appassionati e amanti dei libri rari e diversi e delle immagini disegnate e fotografate.
La libreria si riempie negli anni di foto originali d'epoca, locandine, manifesti e quant'altro, sino a diventare tappa obbligata per scenografi e operatori delle diverse arti legate al cinema. Organizza mostre in tutta Italia e nel mondo, pubblica per Archivio Immagini Cinema la serie dei miniposter ormai diventata un classico. Collabora stabilmente con Cinecittà Holding e Cinecittà Studios ai lavori per la costruzione a Roma di uno spazio museale dedicato al cinema. Crea con altri nomi famosi del cinema la Fondazione Archivi del Novecento.
Maurizio Cesare Graziosi
Autore, pubblicista e regista, nasce a Mar del Plata (Argentina). Nel 1982 si laurea al DAMS presso l'Università di Bologna. Dal 1987 al 1998 è regista RAI con contratti a tempo determinato.
Nel 1998 è curatore di Massimo Troisi. Cuore d'Artista, pubblicazione ufficiale dell'omonima mostra in omaggio a Massimo Troisi. Nel 2000-2003 è collaboratore dell'Associazione "Sergio Leone" di Torella dei Lombardi (AV) per il Premio "Sergio Leone" e la Rassegna "Cinema a Mezzogiorno" come: direttore artistico e collaboratore redazionale del catalogo (2000); direttore artistico e curatore del catalogo (2001); collaboratore artistico del nuovo direttore Gianni Minà per il Premio "Sergio Leone" (2002 e 2003). Dopo avere seguito studi musicali privati a Roma con vari maestri (teoria e solfeggio, percussioni, chitarra, pianoforte) è ammesso nel 2004 al Master Internazionale di Musica per Film (direzione artistica Luis Bacalov) organizzato a Roma dalla Scuola Nazionale di Cinema - Centro Sperimentale di Cinematografia.
Nel 2004 è coinvolto in veste di Italian researcher alla mostra "Sergio Leone and the Italian Western" che si terrà all'Autry Museum of Western Heritage di Los Angeles nel luglio 2005.
Il libro è edito da Federico Motta Editore, ha 384 pagine, 230 illustrazioni e costa € 19,90.
I film più commoventi della Storia:
1) Ghost 2) Bambi 3) ET 4) Titanic 5) Spiagge 6) Voglia di Tenerezza 7) Ufficiale e Gentiluomo 8) Love Story 9) Fiori d'acciaio
I film più commoventi secondo gli uomini:
1) Schindler's List 2) Salvate il soldato Ryan 3) Braveheart 4) Forrest Gump 5) Et 6) Momenti di gloria 7) Il miglio verde 9) Il Gladiatore 10) L'uomo dei sogni
I film più commoventi secondo le donne:
1) Ghost 2) Bambi 3) ET 4) Titanic 5) Spiagge 6) Voglia di Tenerezza 7) Ufficiale e Gentiluomo 8) Love Story 9) Fiori d'acciaio 10) Armageddon
La ricerca è stata fatta dal sito Tesco.com E' Ghost il film più commovente della storia Lo stabilisce un sondaggio condotto su 8.000 uomini e donne. Ma tra i due generi esistono sostanziali differenze di giudizio
LOS ANGELES - Lacrime e celluloide sono un binomio che esiste dagli albori del cinema e forse sulla Terra non c'è essere umano, neppure tra i critici più bacchettoni, che non si sia mai commosso davanti ad una pellicola strappalacrime.
SONDAGGIO - Il sito T esco.com che affitta e vende Dvd ha effettuato negli Usa una interessante classifica sui film più commoventi della storia, condotta su 8000 tra uomini e donne. Il film che fa piangere di più di tutta la storia del cinema è «Ghost» la storia d'amore tristemente interrotta tra una Demi Moore prima maniera e Patrik Swayze (vedi foto) , un tempo noto per i suoi balli provocanti in «Dirty Dancing». Al secondo posto si classifica Bambi , il film-cartoon del piccolo cerbiatto di Dysney, mentre al terzo posto si attesta la favola fantascientifica di Spielberg « ET ».
CLASSIFICA - Al quarto posto il campione d'incassi e vincitore di ben 11 premi Oscar « Titanic », quindi segue l'amicizia tra Barbara Hershey e Bette Midler in « Spiaggie », « Voglia di Tenerezza », Ufficiale e Gentiluomo , il classico « Love Story » e al nono posto « Fiori d'acciao », la storia di sei donne del profondo sud americano che intrecciano le loro vite nel salone di una parrucchiera. DIFFERENZE - Ciò che più colpisce in questa classifica è la diversa percezione della commozione tra uomini e donne. Infatti le classifiche per genere sono molto diverse: per le donne i film più commoventi sono appunto Ghost , Bambi e Et che nella classifica degli uomini non compaiono nei primi dieci posti. Il sesso forte trova invece più commoventi i film di Spielberg Schindler's List e Salvate il Soldato Ryan , mentre al terzo posto attestano la storia di Braveheart con Mel Gibson. Ma non mancano gli uomini che hanno dichiarato di aver versato numerose lacrime nel rivedere per l'ennesima volta cartoon come Bambi e La Collina dei Conigli .
18 settembre 2005
da: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2005/09_Settembre/18/cinema.shtml
APPARVE nel lontano 1936 sulla rivista «Cinema» un articolo dal titolo «Biblioteche specializzate». Venivano indicati ai cineamatori universitari, cioè quelli iscritti ai cine-club denominati Cine-Guf, i pochi libri, non più di cinque o sei, che non dovevano sfuggire alla loro attenzione ed anzi li indirizzavano verso una autentica cultura cinematografica, di cui non era ancora ben visibile l’esistenza, anche se lo scrittore pugliese emigrato a Parigi, Ricciotto Canudo, soprannominato da Apollinaire "le barisien" aveva chiamato la cinematografia «settima arte», e Jean Cocteau l’aveva definita "la decima musa". L’articolo di «Cinema» era firmato dallo stesso autore del libro, ora in uscita, «Maestri del cinema» di Mario Verdone (Andromeda Editrice, Teramo 2004).
Negli anni Trenta e Quaranta si citavano, a sostegno dell’arte del film i pareri positivi espressi da Benedetto Croce e Giovanni Gentile ed era, questo, un notevole passo avanti per far guadagnare ulteriore prestigio e credibilità al nuovo linguaggio entrato nel dominio della creazione artistica. Quanto alla storia ed ai progressi estetici del cinema, non si poteva fare ricorso, in Italia, che ai libri di Francesco Pasinetti, Ettore G. Margadonna, Luigi Chiarini e Umberto Barbaro. Ma già nascevano riviste specialmente come appunto, «Cinema», e «Bianco e Nero», e venivano tradotti gli stranieri Béla Balàzs («Lo spirito del film»), e Vsevolod Pudovkin («Film e fonofilm»).
Oggi non è più così. Le biblioteche dello spettacolo contano centinaia, forse migliaia, di pubblicazioni di argomento cinematografico. Spesso se ne occupano con competenza e lucidità critici attenti e autentici scrittori. Forse se il libro di Mario Soldati apparso nel 1935, «Ventiquattro ore in uno studio cinematografico», fosse uscito qualche decennio dopo, non avrebbe avuto come firma il prudente pseudonimo di Franco Pallavera.
«Maestri del cinema» appartiene alla ormai copiosa letteratura sui registi, di cui si conoscono eccellenti monografie, e vi sono presentati quelli le cui firme sono le più celebrate. V’è però una scelta personale fatta dall’autore, che poi si riflette negli "incontri", che fanno quasi sempre seguito ai "profili". Uno dei più curiosi è quello avvenuto nel 1952 a Torino con Giovanni Pastrone, che nel 1913 aveva diretto il film kolossal «Cabiria», cui aveva collaborato, ma soltanto per le didascalie, Gabriele D’Annunzio. Ma è l’epoca in cui Pastrone aveva da tempo abbandonato la macchina da presa: ora, preso da altre fantasie, a lui interessavano le ricerche medico-scientifiche e addirittura, abbastanza utopisticamente, liberare l’essere umano da ogni male!
I trenta saggi che compongono il libro riguardano, fra l’altro, Orson Welles, Fritz Lang, Marcel Carné, Laurence Olivier, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Ernst Lubitsch, gli italiani Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, il giapponese Akira Kurosawa, l’iraniano Abbas Kiarostami, l’armeno Sergej Paradjanov, i russi Grigori Kosincev e Sergej M. Ejsenstein. Di Charles Chaplin l’autore non ripercorre soltanto la carriera, ma ne rievoca anche la presenza a Roma allorché venne a presentare il suo «Luci della ribalta». E c’è anche l’episodio della proiezione privata di «Umberto D.» cui lo invitò Vittorio De Sica, e che provocò la sua commozione tanto che rimase solo, nella sala di proiezione, ad asciugarsi gli occhi col bianco fazzoletto.
La affettuosa prefazione del volume è fimata da Manoel de Oliveira, il regista portoghese più volte premiato nei Festival di Cannes e di Venezia, e che Verdone ha conosciuto allorché realizzava i primi documentari. Ai profili dei registi, tra cui sono anche Federico Fellini, Alessandro Blasetti, Franco Zeffirelli, Marcel L’Herbier, sono aggiunti anche dei "medaglioni" che riguardano Jean Gabin, Marlene Dietrich, Buster Keaton, Greta Garbo, Totò.
Tra le curiosità che gli incontri dell’autore con i rimanenti cineasti registrano, c’è la reazione che orson Welles ha di fronte alle riprese con lente "cinemascope", che gli sembra la "decadenza del cinema"; l’indifferenza di Buñuel per il film a colori; quando la gente, dopo la sconfitta del nazismo, cercava furiosamente di distrarsi nei locali notturni di divertimento, ed era come se Berlino «danzasse con la morte».
Buñuel «allergico» al colore e Lang triste sulle rovine di Berlino SAGGI DI MARIO VERDONE
di ALDO COSTA ( da IL TEMPO.it di mercoledì 26 gennaio 2005 )
L’American Film Institute ha compilato la lista delle 100 battute che hanno fatto la storia del cinema Usa. Scelte per l’impatto che hanno avuto sul lessico nazionale e per la capacità di lasciare un segno nel tempo, molte di queste battute sono passate in proverbio non solo in America ma ovunque nel mondo. Qui di seguito alcune delle più celebri.
«Francamente, mia cara, me ne infischio» ( Clark Gable in Via col vento ).
«Sto per fargli un’offerta che non può rifiutare» ( Marlon Brando in Il Padrino ).
«Non capisci! Avrei potuto essere rispettato, avrei potuto essere un lottatore. Avrei potuto essere qualcuno invece di essere il buono a nulla che sono!» ( Marlon Brando in Fronte del porto ).
«Adoro l’odore del napalm alla mattina» ( Robert Duvall in Apocalypse Now ).
«Suonala ancora, Sam» ( Ingrid Bergman in Casablanca )
«Telefono...casa...» ( E.T. in E.T. )
«Che la Forza sia con te» ( Harrison Ford in Guerre stellari ).
«Louis, penso che questo sia l’inizio di una magnifica amicizia» ( Humphrey Bogart in Casablanca ).
«Domani è un altro giorno» ( Vivien Leigh in Via col vento ).
"Un binomio nato al momento stesso della nascita della settima arte, il 28 dicembre 1895, in occasione della prima proiezione cinematografica publica, i fratelli Lumiere vollero inserire, accanto a L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, anche La colazione del bimbo.
Un connubio che in questi 110 anni si è via via consolidato in tante opere di successo, per una ragione tanto semplice quanto profonda: qualsiasi forma di narrazione della vita non può prescindere da un elemento indispensabile alla vita stessa, quale appunto il cibo.
Sia il Cinema che la cucina, inoltre, sono veicoli di comunicazione previlegiata per le tradizioni più autentiche di un popolo, forme di arte nelle quali l'identità culturale prende vita.
Il nostro cinema e la nostra cultura sono, pertanto, espressione di quel made in Italy conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Produzioni da tutelare, valorizzare, promuovere."
dalla presentazione di Andrea Mondello (presidente Camera di Commercio di Roma)


Tratto dal volume Roma in Tavola ediz. 2005
Così il grande cineasta descriveva la sua vita e il suo lavoro. Le donne che ha conosciuto, i film che ha girato e quelli che ha interpretato. A volte ne parlava con crudeltà, altre con ironia. Le confessioni di un uomo che ha fatto della provocazione un´arte e del talento una forma estrema di dissipazione.
| (Orson Welles fa scherzi alla radio) |
1 – VIZIARE L'ORSON
Ero una di quelle abominevoli creaturine impettite, non so se ha presente, con la bacchetta da direttore, suonavo il violino e il pianoforte, e non c´è niente di più odioso sulla faccia della terra. Ero uno di loro. Mia madre, che di professione era musicista, morì quando avevo nove anni, e smisi immediatamente di suonare. Fu una specie di trauma, uno shock dovuto alla sua morte, mescolato, credo, a una pigrizia di fondo... e al piacere di non dover continuare a esercitarmi sulle scale armoniche. Così abbandonai la mia carriera musicale, perché era a questo che ero stato destinato inizialmente.
Sì, da bambino sono stato viziato in modo molto strano. Perché tutti, dal giorno in cui sono stato in grado di comprendere, mi hanno detto che ero assolutamente meraviglioso. Non ho mai sentito una parola scoraggiante per anni. Non avevo idea di cosa mi aspettava. Dipingevo, e mi dicevano che non si erano mai visti dipinti simili; suonavo, e nessuno aveva mai suonato così. E a me sembrava proprio che non ci fossero limiti alle mie possibilità.
2 - UN DUE PER CENTO DEL MIO TEMPO L´HO IMPIEGATO A FARE FILM, E UN NOVANTOTTO PER CENTO A SBATTERMI QUI E LÀ PER POTERLI FARE
Essenzialmente, credo di aver commesso un errore a restare nel mondo del cinema, ma è un errore di cui non posso rimproverarmi, perché sarebbe come dire che non avrei dovuto restare sposato con una certa donna, ma che l´ho fatto perché la amavo. Avrei avuto molto più successo se non avessi sposato proprio lei. Avrei avuto molto più successo se avessi lasciato immediatamente il cinema, se fossi rimasto nel teatro, o se fossi entrato in politica, se avessi fatto lo scrittore o qualsiasi altra cosa.
Ho gettato via gran parte della mia vita nello sforzo di cercare denaro e di cavarmela in qualche modo, per poter fare il mio lavoro usando questa scatola di colori estremamente costosa che è un film. E ho sprecato fin troppa energia dietro a cose che non hanno nulla a che vedere con il fare un film. Diciamo che un due per cento del mio tempo l´ho impiegato a fare film, e un novantotto per cento a sbattermi qui e là per poterli fare.
Continuerò a essere fedele alla mia ragazza. La amo. Mi innamoro così tanto del fare un film che il teatro per me ha perso tutto quel che aveva, davvero. Amo soltanto fare film. Non sono un appassionato del cinema. Non vado spesso a vedere film. Credo sia perfino dannoso per un regista vedere altri film, perché si finisce sempre o per imitarli, o per preoccuparsi di non imitarli affatto. Invece bisogna fare il film con innocenza. Nello stesso modo in cui Adamo diede un nome agli animali il primo giorno nel paradiso terrestre.
E io ho perso la mia innocenza. Ogni volta che vedo un film perdo qualcosa, non ne guadagno niente. Non capisco cosa vogliano dire i registi quando si complimentano con me, i giovani registi, quando dicono di aver imparato dai miei film. Perché io non credo affatto di poter imparare qualcosa da un film altrui. Credo che bisogna imparare solo dalla propria visione interiore delle cose e scoprire, come ho detto, con innocenza, come se non fossero mai esistiti né David Wark Griffith, né Ejsenstejn, o Ford o Renoir o chiunque altro.
 |
| (L'occhio del grande cineasta) |
3 – LA REGIA E' IL MONTAGGIO
Per me, quasi tutto ciò che viene battezzato come mise en scène è un enorme bluff. Nel mondo dei film, sono davvero poche le persone che si possono considerare veramente dei registi, e tra di essi sono ancora meno quelli a cui viene davvero data l´opportunità di dirigere un film. L´unico momento di vera regia ha luogo durante il montaggio. Mi ci sono voluti nove mesi per montare “Quarto potere”, lavorando sei giorni a settimana.
Certo, ho diretto io “L´orgoglio degli Amberson”, malgrado alcune scene non fossero mie: ma il mio montaggio è stato modificato. Il montaggio basilare è mio, e quando nel film c´è una scena che funziona, è perché l´ho montata io. In altre parole, è come se uno stesse dipingendo un quadro. Lo finisce, e poi arriva qualcuno e lo ritocca, ma chiaramente non può aggiungere altra pittura sull´intera superficie della tela.
Non posso fare a meno di pensare che il montaggio sia la cosa essenziale per un regista, l´unico momento in cui controlla completamente la forma del suo film. Quando sto filmando, il sole è il fattore determinante di qualcosa contro cui c´è poco da combattere; gli attori portano in gioco qualcosa a cui devo adattarmi; e così anche la storia. Io mi limito a predisporre le cose in modo da dominare tutto quel che posso. L´unico posto in cui il mio controllo è assoluto, però, è lo studio di montaggio. di conseguenza, è quello il momento in cui il regista è, in potenza, un vero artista, perché a mio avviso un film è buono nella misura in cui il regista è riuscito a controllare i diversi materiali e non si è accontentato semplicemente di mantenerli intatti.
4 - NON MI INTERESSA IL LAVORO ARTISTICO, LA POSTERITÀ, LA FAMA, MA SOLO IL PIACERE DELLA SPERIMENTAZIONE IN SE STESSA
Io cerco sempre la sintesi. E´ un lavoro che mi affascina perché devo essere sincero riguardo a me stesso, e io sono un puro sperimentatore. Il mio unico valore ai miei occhi è che non detto leggi, ma sono uno sperimentatore. Sperimentare è l´unica cosa che mi entusiasma. Non mi interessa il lavoro artistico, capite, la posterità, la fama, ma solo il piacere della sperimentazione in se stessa.
E´ l´unico ambito in cui posso sentire di essere onesto e sincero. Io non mi consacro a quel che faccio. Davvero, non ha alcun valore ai miei occhi. Sono profondamente cinico riguardo al mio lavoro e alla maggior parte delle opere che vedo nel mondo. Ma non sono cinico riguardo al lavoro sui materiali. E´ una cosa difficile da spiegare. Noi sperimentatori di professione abbiamo ereditato un´antica tradizione. Alcuni di noi sono stati tra i maggiori artisti, ma le nostre muse non sono mai diventate le nostre amanti.
Per esempio, Leonardo si considerava uno scienziato che dipingeva piuttosto che un pittore che faceva lo scienziato. Non voglio certo paragonarmi a Leonardo; sto solo cercando di spiegare che c´è una lunga linea ininterrotta di persone che giudicano il proprio lavoro secondo una diversa gerarchia di valori, che sono quasi valori morali.
 |
| (Barba e sguardo feroce) |
Quindi non cado in estasi quando sono di fronte a un´opera d´arte. Sono in estasi quando mi trovo di fronte alla funzione umana, che è sottesa a tutto ciò che facciamo con le nostre mani, con i nostri sensi, eccetera. Il nostro lavoro, una volta finito, non ha l´importanza che la gran parte degli esteti gli attribuiscono. E´ l´atto che mi interessa, non il risultato, e io vengo preso dal risultato solo quando questo sa di sudore dell´uomo, o di pensiero espresso.
Sto pensando seriamente di smettere il mio lavoro nel cinema o nel teatro, smetterla una volta per tutte, dico, perché sono rimasto troppo deluso. Ci ho investito troppo lavoro, troppo impegno rispetto a quel che ho avuto in cambio... non in termini di denaro, ma di soddisfazione. Quindi sto pensando seriamente di abbandonare cinema e teatro, perché in un certo senso loro mi hanno già abbandonato.
5 - LA RESPONSABILITÀ È DELLA MIA PERSONALITÀ, NON DELLE MIE INTENZIONI
Più o meno di mia volontà, lo sapete, ho fatto molte volte la parte del cattivo. Odio Harry Lime, quel mascalzoncello del mercato nero, tutti i personaggi orribili che ho interpretato e che tuttavia non sono «piccoli», perché io sono un attore per grandi personaggi. Come sapete, nel vecchio teatro classico francese, c´erano sempre attori che interpretavano il re e attori che non lo interpretavano: io sono di quelli che fanno il re.
Con la mia personalità, è necessario. Perciò recito naturalmente sempre parti di capi, di persone che hanno una dimensione straordinaria: devo sempre essere bigger than life, più grande della natura. E´ un difetto della mia indole. Dunque non bisogna pensare che ci sia qualcosa di ambiguo nelle mie interpretazioni. La responsabilità è della mia personalità, non delle mie intenzioni.
6 - IL PUBBLICO INCONCEPIBILE
Si possono orientare le cose quanto si vuole, ma cosa ne penserà poi il pubblico americano? Io non ne avevo la più pallida idea. Non si tratta di disprezzo per il pubblico, è solo che il pubblico di un film davvero non è concepibile. Il sessanta per cento del pubblico non sentirà mai le parole che diciamo, perché il film sarà doppiato. Forse dieci milioni di persone lo vedranno soltanto in seguito, quando saremo tutti morti. Sono poveri, sono ricchi, sono grandi, sono piccoli. Non sappiamo chi sia il pubblico di un film, perciò non possiamo far altro che qualcosa in cui crediamo.
7 – SOGNATE I VOSTRI FILM
Non ho mai messo piede in una scuola di cinema. E non avevo mai messo piede su un set prima di girare “Quarto potere”. Senza dubbio sono stato toccato dalla grazia di una totale ignoranza. Ho imparato tutto quel c´era da sapere in tre ore, non perché sia particolarmente intelligente, ma perché il cinema è semplice! Voi di certo avrete passato troppo tempo a guardare film. Non chiudetevi troppo nell´universo cinematografico, come fosse una scatola d´aringhe.
Sognate i vostri film, piuttosto. E prestate attenzione all´incanto delle muse più perverse... la decadenza del cinema è il risultato della glorificazione del regista. Ma l´attore è più importante. Oggi il regista è l´artista più sopravvalutato del mondo. Pensate ai grandi momenti del cinema: sono tutti in bianco e nero. Più avanza il progresso tecnico, più lo spirito creativo va in declino. E io temo che l´elettronica finirà per aiutare solo i film di terza scelta.
8 – A COLAZIONE CON HITLER
Sono stato a Berlino per circa tre anni, dal 1926 in poi, e più o meno lo stesso periodo di tempo l´ho passato a Chicago. Ma le città migliori per me sono state senz´altro Budapest e Pechino. E´ lì che ho avuto le migliori conversazioni ed esperienze, fino alla fine. Quel che non posso dimenticare è una festa a cui ho partecipato da qualche parte nel Tirolo, verso la metà degli anni Venti. Partecipavo a una gita a piedi con altri ragazzini della mia età, quando il nostro tutore ci portò a mangiare in un´enorme birreria all´aperto.
Sedemmo su un lungo tavolo pieno di nazisti, che all´epoca erano solo uno sconosciuto gruppetto di svitati, e io ero accanto a un uomo molto magro, dalla personalità cupa e ottusa. Non mi fece nessuna particolare impressione, allora, ma anni dopo, quando vidi le sue fotografie, compresi di aver pranzato accanto a Adolf Hitler.
9 - LA COSA PIÙ TRISTE DELLA SINISTRA AMERICANA È CHE HA TRADITO PER PROTEGGERE LE SUE PISCINE
Nell´arte americana il problema, o meglio, uno dei problemi, è il tradimento della sinistra da parte della sinistra, un auto-tradimento. In un certo senso, per stupidità, per ortodossia e osservanza degli slogan; in un altro senso, per semplice tradimento. Siamo molto pochi nella mia generazione a non aver tradito la propria posizione, a non aver fatto i nomi di altra gente...
E´ una cosa terribile. Non potrà mai essere superata. Non so come si possa ricominciare dopo un simile tradimento; è qualcosa che differisce profondamente, per esempio, dal caso di un francese che abbia collaborato con la Gestapo per salvare la vita della moglie; è un altro genere di collaborazionismo. La cosa più triste della sinistra americana è che ha tradito per proteggere le sue piscine. Non c´era nessuna destra americana, nella mia generazione.
Dal punto di vista intellettuale non esisteva. C´erano solo persone di sinistra, e si sono reciprocamente tradite a vicenda. La sinistra non è stata distrutta da McCarthy: si è demolita da sola, cedendo a una nuova generazione di nichilisti. Ecco cosa è successo.
 |
| (Rita Hayworth) |
10 - LA RITA DI SHANGHAI
Credo che conosciate la storia della “Signora di Shanghai”. Stavo lavorando a una spettacolare idea teatrale per Il giro del mondo in ottanta giorni, che inizialmente doveva produrre Mike Todd. Ma da un momento all´altro Todd fece bancarotta, e io mi sono ritrovato a Boston il giorno della prima, impossibilitato a ritirare i costumi dalla stazione perché c´era un debito insoluto di cinquantamila dollari. Senza quei soldi non avremmo potuto andare in scena.
A quel tempo ero già separato da Rita; non ci parlavamo neanche più. Non avevo intenzione di fare un film con lei. Da Boston mi sono messo in contatto con Harry Cohn, il direttore della Columbia, che era a Hollywood, e gli ho detto: «Ho una storia straordinaria, se mi mandi cinquantamila dollari con un vaglia telegrafico entro un´ora, firmo un contratto per realizzarla». Cohn mi ha chiesto: «Che storia?». Io telefonavo dal botteghino del teatro; vicino c´era un banco con un´esposizione di libri tascabili, e io gli ho dato il titolo di uno di quelli: La signora di Shanghai. Gli ho detto: «Compra il romanzo, e io farò il film».
Un´ora dopo abbiamo ricevuto i soldi. In seguito ho letto il libro e l´ho trovato orribile, così mi sono messo al lavoro per scrivere una storia al massimo della velocità. Sono arrivato a Hollywood per girare il film con un budget molto ridotto e in sei settimane di riprese. Ma mi servivano altri soldi per il mio teatro.
Cohn mi ha chiesto perché non usavo Rita. Lei aveva detto che le avrebbe fatto molto piacere. Io le ho fatto capire che il personaggio non era simpatico, era una donna che aveva ucciso e questo poteva intaccare la sua immagine di star agli occhi del pubblico. Ma Rita era molto determinata a fare questo film, così invece di costare trecentocinquantamila dollari è diventato un film da due milioni di dollari. Rita ha avuto un atteggiamento di grande collaborazione. Chi è rimasto davvero orripilato dopo aver visto il film è stato Cohn.
 |
| (La splendida rossa) |
11 - BRECHT ANTI-SOVIET
Terribilmente simpatico. Aveva una mente straordinaria. Si vedeva perfettamente che era stato educato dai gesuiti. Aveva quel tipo di mente disciplinata caratteristica dell'educazione gesuitica. Istintivamente, era più anarchico che marxista, ma riteneva di essere un perfetto marxista.
Quando un giorno gli ho detto - stavamo parlando del Galileo - che aveva scritto un´opera perfettamente anticomunista, è diventato quasi aggressivo. Io gli ho risposto: «Ma la Chiesa che tu descrivi qui deve essere quella di Stalin, non quella del Papa, di questi tempi. Hai scritto una cosa decisamente antisovietica».
12 – PRENDERE PER IL CULO HEMINGWAY
Il mio rapporto con Hemingway è stato sempre molto divertente. La prima volta che ci siamo incontrati è stato quando mi hanno chiamato a leggere il commento narrato di un film che lui e Joris Ivens avevano fatto sulla guerra di Spagna; si chiamava “Spanish Earth” (Terra di Spagna). Appena arrivato mi sono imbattuto in Hemingway, che era tutto intento a tracannare una bottiglia di whisky; mi avevano dato una serie di battute troppo lunghe e vuote, che non avevano niente a che vedere con il suo stile, sempre così conciso e parsimonioso.
C´erano alcune parti pompose e complicate del tipo: «Ecco i volti degli uomini vicini alla morte», e la battuta doveva essere letta in un momento in cui sullo schermo si vedevano volti che erano molto più eloquenti. Io gli dissi: «Signor Hemingway, sarebbe meglio se si vedessero soltanto i volti, senza nessun commento».
La cosa non gli è piaciuta neanche un po´, e siccome poco tempo prima avevo fatto una regia per il Mercury Theatre, che era una specie di teatro di avanguardia, lui pensava che fossi una specie di finocchio, così mi ha detto: «Voialtri... ragazzini effeminati del teatro, che cosa volete saperne della guerra vera?».
Prendendo il toro per le corna ho cominciato a muovermi con gesti effeminati e gli ho detto: «Signor Hemingway, quanto è forte lei, quanto è grande!». La cosa lo ha mandato su tutte le furie, al punto che ha afferrato una sedia; io ne ho preso un´altra e lì, di fronte alle immagini della guerra civile spagnola che continuavano a scorrere sullo schermo, abbiamo iniziato una zuffa tremenda.
E´ stata una cosa meravigliosa: due tipi come noi di fronte a quelle immagini che rappresentavano gente nell´atto di combattere e morire... abbiamo finito col brindare insieme con la sua bottiglia di whisky. Nella nostra vita abbiamo passato lunghi periodi di amicizia e altri in cui a malapena ci parlavamo. Non sono mai riuscito a evitare di prenderlo garbatamente in giro, e questo nessuno lo aveva mai fatto; tutti lo trattavano con il massimo rispetto.
13 – IL TALENTO DI KUBRICK
Non ho visto niente della generazione più recente, a parte qualche esempio d´avanguardia. Tra quelli che potrei definire la «giovane generazione», Kubrick mi appare come un gigante. Non ho visto “Lolita”, ma credo che Kubrick possa fare qualsiasi cosa.
E´ un grande regista che non ha ancora fatto dei grandi film. Quel che vedo in lui è un talento che i registi della generazione precedente alla sua non possedevano, intendo dire Ray, Aldrich, e così via. Forse lo dico perché il suo temperamento si avvicina molto al mio.
 |
| (Michelangelo Antonioni) |
13 – GLI SFONDI VOGUE DI ANTONIONI
Secondo i giovani critici americani, una delle grandi scoperte della nostra epoca è il valore della noia come tema artistico. Se è così, Antonioni merita di essere annoverato tra i pionieri della tendenza come padre fondatore. I suoi film sono sfondi perfetti per mannequins di alta moda. Forse non ci sono sfondi così perfetti neanche in Vogue, anzi, è così che dovrebbero farli. Dovrebbero ingaggiare Antonioni per progettarli.
 |
| (Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg) |
14 – FELLINI, UN ARTISTA SUPERLATIVO CHE HA MOLTO POCO DA DIRE
E´ dotato, come tutti quelli che fanno cinema oggi. Il suo limite - che è anche la fonte del suo fascino - è di essere fondamentalmente molto provinciale. I suoi film sono il sogno della grande città da parte di un ragazzo di provincia. Le sue sofisticherie funzionano perché sono la creazione di qualcuno che non è sofisticato. Tuttavia mostra spesso segni pericolosi di essere un artista superlativo che ha molto poco da dire.
 |
| (Vittorio de Sica e Gina Lollobrigida) |
15 – VIVA DE SICA
Non vi piacerà quello che vi sto per dire, dato che le persone che ammiro non sono affatto stimate dagli intellettuali del cinema; il dramma è tutto qui. Il cineasta che preferisco è De Sica: so che vi fa star male. E John Ford. Ma il Ford di vent´anni fa, il De Sica di dodici anni fa. Ah! “Sciuscià”: è il miglior film che abbia mai visto. Dovreste vergognarvi di non amare De Sica: magari potessimo riparlarne fra duecento anni!
Estratti dal libro “ It's All True. Interviste sull'arte del cinema ”, a cura Mark W. Estrin, con traduzione e postafazione di Serafino Murri, Minimum Fax.
da Dagospia del 15 Febbraio 2005
DAL 1994 AL 2005, ASSEGNATI 102 MLN PER 67 FILM CHE NON SONO ANCORA USCITI
CONTRIBUTO DI 3,718 MLN PER LA WERTMÜLLER PER INCASSSARE 6 MILA E 567 EURO
L’ETA’ MEDIA DEI PRIMI CINQUE REGISTI NELLA HIT PARADE DEI BENEFICIATI E’ DI 70 ANNI
Ma francamente, come dimenticare gli insegnamenti del mistico indiano Osho, la sua idea di fondere la grande anima del Buddha con la passionalità di Zorba il Greco, che ispirano il dj Loris nel progetto di aprire una discoteca sulla costa turca? Sì, è proprio la trama di 'Zorba il Buddha', il film uscito nel 2004 del regista riminese Lakshen Sucameli, che poi si chiamerebbe Antonino, ma il maestro spirituale Osho così lo ribattezzò. Ve lo siete perso? Succede: praticamente quattro titoli su cinque di quelli finanziati dallo Stato (che nel 2000 per Zorba deliberò un aiuto di quasi 2 miliardi di lire) nessuno li ha mai sentiti nominare. Figuriamoci vederli.
C'è di peggio: ad esempio, l'ultimo film di Lina Wertmüller ferita nell'onore, 'Peperoni ripieni e pesci in faccia' con Sophia Loren, ha ottenuto un contributo record di 3 milioni e 718 mila per incassare, la scorsa estate, 6 mila e 567 euro lordi al botteghino: un'uscita clandestina, senza promozione, in meno di 20 copie. Non ha staccato nemmeno mille biglietti: la critica ha steso un velo pietoso, il pubblico non se n'è nemmeno accorto e col box office, praticamente, ci hanno pagato un giorno di catering.

(Linuccia Wertmuller e Giancarlo Giannini - U.Pizzi)
La stessa cifra - cioè, bada bene, la più alta da quando lo Stato sovvenziona i film di interesse culturale nazionale - è stata deliberata per il semi-kolossal 'Masaniello-Amore e libertà' del 37enne regista casertano Angelo Antonucci. Un filmone con Franco Nero, Gabriele Lavia e Anna Galiena, 2 mila comparse e otto settimane di riprese, che è pronto da un anno, ha girato 11 festival e non è ancora approdato nelle sale: la casa di distribuzione Revolver sostiene che i soldi promessi dallo Stato (delibera del 22/5/2003) non si sono ancora visti e finché non arriveranno nessuno vedrà Masaniello. Due film dei primi dieci più aiutati nella storia del cinema italiano non sono ancora arrivati al pubblico. L'altro è 'La storia di Leo' di Mario Cambi.
Sono vicende, e numeri, molto comuni in quel Titanic che è il cinema italiano: nel salone si balla, facendo a gara a chi allestisce il festival più rutilante, mentre la nave va a picco. Lo Stato dall'85 a oggi ha perso qualcosa come 2 miliardi e 170 milioni di euro nel settore. Alla produzione ha stanziato a fondo perduto circa 870 milioni: sarebbero prestiti, cioè soldi da restituire almeno in parte quando l'incasso pareggia l'investimento per poi essere rimessi in circolo, ma nei fatti solo un film su cento salda il debito. I produttori denunciano che quei denari promessi spesso non arrivano mai. Tra l'approvazione e la riscossione passano comunque due anni e mezzo.
La selezione dei film da sostenere ha risposto per anni a criteri discutibili quando non indecifrabili: è stato ritenuto, per dirne una, di interesse culturale nazionale anche 'Senso' di Tinto Brass, il sommo teorico e cantore dell'italico deretano. "Il culo", è il suo manifesto di pensiero, "è lo specchio dell'anima. I miei film non danno solo erezioni ma anche emozioni". Come non firmargli un assegno? E avanti il prossimo.

(Anna Galiena nel film 'Senso 45' di Tinto Brass)
Fare un film in Italia costa in media un paio di milioni e il ministero dei Beni Culturali copre circa tre quarti della somma per i film che valuta di interesse culturale: la legge 153 del '94 stabiliva che il finanziamento potesse arrivare al 90 per cento del budget e al 70 di garanzia statale (il 90 in caso di opere prime e seconde). Il contributo medio elargito è di un milione e mezzo per un ritorno al botteghino di 20 mila euro a pellicola.
Dal '94 fino alla metà del 2005 sono stati assegnati 102,6 milioni per 67 film che non sono ancora usciti e, per lo più, non usciranno mai. Più di uno su dieci non arriva al cinema. Ma è un calcolo generoso, perché tra quelli che si considerano usciti si contano anche i film che hanno fatto una sola apparizione a una rassegna di quartiere o nella sala parrocchiale a Ferragosto. E quindi gli autori dicono: non è colpa nostra se poi le opere non vengono immesse nel circuito. Nel caveau della Bnl e nelle cantine del Centro sperimentale di cinematografia giacciono decine e decine di pizze che non hanno mai conosciuto un proiettore. Facciamo un festival pure con quelle? Sì, c'è già anche quello.
Nell'ambiente gira questa battuta: se l'Istituto Luce distribuisse droga invece che film, il problema della tossicodipendenza sarebbe risolto. "Il nuovo indirizzo", dice Sandro Battisti presidente di Cinecittà Holding, che controlla anche il Luce, "prevede che il Luce si occupi solo di produzione e distribuzione di opere prime o seconde e di grandi film d'autore. Vendendo le multisale e incrementando la partecipazione statale nel circuito delle sale di qualità, la distribuzione di buon cinema italiano dovrebbe essere rafforzata".
La pacchia dei finanziamenti ai registi è finita nel 2003, dopo due stagioni in cui lo Stato, avendo Veltroni raddoppiato a 8 miliardi di lire il tetto per ogni film, aveva scucito totali 220 milioni. La cassa si è prosciugata e ora siamo a 21 film approvati per 37 milioni nel 2006. D'altra parte il fondo di credito della Bnl è passato dai 700 miliardi di lire del '94 ai 78 miliardi (sempre in lire) nel 2004. Così nel 2004 si sono un po' regolati i rubinetti: massimo 70 per cento di copertura (5 milioni di euro) e 50 per cento di garanzia.
L'assistenzialismo scriteriato è una delle ragioni del collasso economico (non creativo) del cinema italiano, sebbene le cose siano migliorate da quando la legge Urbani nel 2004 ha introdotto il reference system limitando al 60 per cento la discrezionalità delle commissioni e legando il restante a una graduatoria stilata su parametri fissi: un punteggio che viene assegnato principalmente in base alla carriera del regista e alla solidità della casa di produzione. Per troppi anni si sono gettati soldi a pioggia, quasi alla cieca, o in qualche caso vedendo benissimo chi era il destinatario amico. Per troppo tempo lo Stato non s'è preoccupato di verificare le referenze dei produttori: gente che, è successo, intascava i soldi gonfiando il preventivo, poi tagliava le spese all'osso e si teneva il resto. Michele Placido ha raccontato di essere stato inserito a sua totale insaputa in cast di film portati all'esame delle commissioni.

(Roberto Faenza)
Sono pochi i registi, tra quelli sovvenzionati, che giustificano la fiducia: Roberto Faenza è il più finanziato, ma ha incassato anche 14,4 milioni con un attivo di circa 600 mila euro rispetto al contributo statale. In pari è andato Pupi Avati, mentre il risultato più eclatante di sempre è stato quello di 'Notte prima degli esami': 12,463 milioni al botteghino con 800 mila euro di finanziamento. Un caso più unico che raro. Ottimo l'esito dei 'Cento passi' di Giordana, uno dei cinque o sei film che ha anche restituito il prestito. Soldini, Bellocchio, Cristina Comencini, Piccioni e Olmi sono tra i direttori che, in linea di massima, portano a casa il risultato.
In netto rosso il patriarca 92enne del cinema italiano Mario Monicelli, con 2,2 milioni di botteghino (contro i 9,5 deliberati) e un film come 'L'omo nero' mai realizzato. Stupisce al quarto posto di questa hit parade la presenza di Pasquale Scimeca, 51enne siciliano, che ha avuto 9 milioni e incassato briciole: il suo 'La passione di Giosuè l'ebreo' ha fatto 64 mila euro al box office contro i 3,5 milioni concessi. Ma a Venezia due anni fa s'è lamentato del boicottaggio ("Pochi potenti decidono i film da fare, distribuire e forse anche portare ai festival. Stiamo entrando in un incubo orwelliano"). Se era raccomandato, quanto gli davano?
Un difetto ulteriore del metodo di finanziamento è quello di premiare soprattutto le vecchie glorie della cinepresa: l'età media dei primi cinque registi nella hit parade dei più beneficiati è di 70 anni. Certo che poi si pigliano belle cantonate anche quando si punta forte su un giovane: un'altra perla nera è 'My father-Rua Alguem 555' di tal Egidio Eronico, 3,5 milioni per 13.722 euro di sbigliettamento. Mah.

(Mario Monicelli - U.Pizzi)
Davanti a questo scenario che sia indispensabile una nuova legge di sistema è opinione condivisa ormai da tutte le componenti. A parte la recente provocazione di Rifondazione (quote obbligatorie di film italiani in sala: un protezionismo inapplicabile), il disegno di legge dell'Unione ha iniziato il suo lungo iter nell'aprile 2006 con l'obiettivo di diventare norma entro quest'anno. Il progetto è stato curato da Andrea Colasio della Margherita: "Bisogna che i costi", spiega, "poggino su tutta la
filiera, tenendo presenti tutte le piattaforme mediatiche: web, telefoni, eccetera. Le tv devono dare un contributo molto più cospicuo".
La prospettiva non piacerà all'opposizione. Nel mirino c'è soprattutto Sky. La legge prevederebbe un prelievo del 5 per cento del fatturato lordo delle pay tv e del 3,5 per i gestori di telefonia e di streaming via Internet, ma anche per i noleggiatori di home video. Tutti i poteri verrebbero decentrati a un'Agenzia per il cinema, creando un soggetto unico per competenze ora suddivise tra Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding. "L'Italia", prosegue Colasio, "destina al cinema 90 milioni contro i 515 della Francia, il cui sistema va preso a modello. Un film francese viene realizzato con 5-6 milioni, un italiano con due e di conseguenza si risparmia sulla promozione. Il risultato è che il cinema nazionale da noi ha una quota mercato del 25 per cento e in Francia del 45. Il vero problema è che non abbiamo produttori indipendenti: ora tutto è nelle mani di Raicinema e Medusa. Chi ha le frequenze tv decide anche i contenuti , e ciò crea una situazione ambigua. Bisogna tornare all'età d'oro dei Ponti e dei De Laurentiis, rilanciando contemporaneamente il Centro sperimentale di cinematografia oggi in stato comatoso. Un dato che dà speranza sono quei 20 film italiani che nel 2006 hanno superato il milione di incassi".

(Aurelio De Laurentiis - U.Pizzi)
La legge dovrebbe essere accompagnata da un decreto per la defiscalizzazione: in fatto di tasse l'Italia è il paese più svantaggiato rispetto alla concorrenza e per questo anche le produzioni internazionali, salvo rare eccezioni, girano alla larga dai nostri studios.

2 - LA TOP TEN DEGLI AUTORI
Regista, totale finanziamenti (in milioni di euro) - numero film
Roberto Faenza 13,789 - 6
Pupi Avati 9,743 - 5
Mario Monicelli 9,490 - 4
Pasquale Scimeca 9,005 - 4
Lina Wertmüller 8,856 - 3
Renzo Martinelli 7,561 - 3
Ettore Scola 6,515 - 4
Roberta Torre 5,797 - 3
Maurizio Nichetti 5,720 - 3
Giuseppe Piccioni 5,606 - 4
3 - LA TOP TEN DELLE PELLICOLE
Film regista e anno di uscita - finanziamento - incasso
Peperoni ripieni e pesci in faccia - L. Wertmüller, 2004 - 3.718.490 - 6.567 €
Masaniello - Amore e libertà - A. Antonucci, 2003 - 3.718.490 - 0 €
La passione di Giosuè l'ebreo - P. Scimeca, 2003 - 3.551.157 - 64.120 €
Totò Sapore - M. Forestieri, 2003 - 3.532.565 - 873. 526 €
Così Ridevano - G. Amelio, 1998 - 3.532.565 - 1.103.294 €
I piccoli maestri - D. Lucchetti, 1998 - 3.532.565 - 1.315.320 €
La storia di Leo - M. Cambi, 2003 - 3.520.194 - 0 €
Rua Alguem 5555 - E. Eronico, 2001 - 3.501.577 - 13.722 €
Io no - S. Izzo, R. Tognazzi, 2003 - 3.468.300 - 398.078 €
Pontormo - G. Fago, 2002 - 3.410.407 - 150.31 €
da Dagospia 06 Febbraio 2007
di Emilio Marrese per “L’espresso”
.... eppoi dicono che i soldi per la cultura non ci sono....
NON ci sono per noi che cerchiamo DAVVERO di fare CULTURA CINEMATOGRAFICA !!!
A volte capita che, per la versione in video, i film vengano modificati: si tagliano scene di sesso, violenza, dialoghi eccessivamente offensivi.
Pensiamo alla versione TV de “Il silenzio degli Innocenti” (Jonathan Damme, 1991), contiene ad esempio scene diverse rispetto a quella distribuita al cinema.
Viene utilizzata la Compressione dei Tempi, che accelera impercettibilmente la velocità del film al fine di inserirvi al suo interno spot pubblicitari.
Alcune scene vengono ridoppiate…
Spesso anche film destinati al noleggio di videocassette vengono revisionati; le colonne sonore possono essere sostituite a causa dell’impossibilità di negoziarne i diritti.
Differenze notevoli si notano tuttavia nel formato d’immagine adattata allo schermo televisivo.
Solo in casi rari infatti la versione video rispetta il formato originale disponendo bande nere sopra e sotto l’immagine: si tagliano cioè porzioni dall’immagine originale, spesso sino al 50%.
E’ il tecnico che decide quali porzioni dell’immagine eliminare.
A volte decide di ricavare inquadrature distinte da quella che in origine era una inquadratura unica alterando così la versione originale del film.
Per questa ragione alcuni registi girano già in funzione del formato televisivo, concentrando l’azione importante nell’area che resterà intatta poi per la versione in video.
Ad esempio, James Cameron ha girato il “Titanic” (1997) tenendo conto della distribuzione in videocassetta in modo tale che le scene più intime soffrissero meno delle sequenze più spettacolari.
Da qualche tempo tuttavia, la diffusione dei DVD fornisce allo spettatore sempre più opzioni; e così all’interno dell’inquadratura è possibile visualizzare o meno le bande nere.
di Diana Rodi




























































































































































